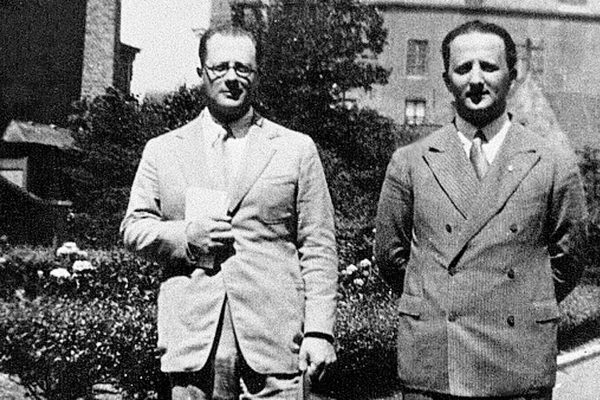Cosa potranno mai condividere un presidente democratico e uno repubblicano degli Stati Uniti? Domanda quantomai attuale vista l’odierna polarizzazione sociopolitica in America, ma Franklin Delano Roosevelt e Ronald Reagan avevano in comune molto di più quello che si potesse immaginare. Considerati forse il presidente USA più a sinistra rispettivamente più a destra del Novecento, il primo aveva gettato le premesse e l’infrastruttura ideologica della Guerra Fredda, mentre il secondo pose fine al conflitto con l’URSS quasi mezzo secolo dopo. Roosevelt era sempre stato un democratico; Reagan “dem” lo era stato in gioventù, quando votò per FDR assieme ad altri ventitré milioni di americani nel novembre 1932, salvo poi convertirsi al GOP. Roosevelt era un internazionalista, mentre Reagan – secondo Henry William Brands (Reagan. A life) – negli anni Trenta «era un isolazionista liberale: rooseveltiano negli affari interni, ma anti-rooseveltiano in politica estera. Nei due decenni successivi avrebbe subito una doppia trasformazione, diventando un internazionalista conservatore: anti-rooseveltiano a livello nazionale, ma rooseveltiano in politica estera.»
Ciò non ha impedito a Reagan di voler assomigliare a Roosevelt, il mito della sua generazione: FDR era sì aperto al mondo e alle istituzioni internazionali, ma aveva capito l’impopolarità della Lega delle Nazioni; stesso discorso per il Gipper, che più volte se la prese con le Nazioni Unite, che contestava le sue decisioni talvolta unilaterali. Contestualizzate, le impressionanti similitudini umane, politiche ed economiche che i due presidenti condividevano, c’erano eccome. E in un’epoca di partigiana e velenosa divisione sociale e politica tremendamente manichea – liberal e conservatives – internazionalisti e nazionalisti, ricordare quanto gli aspetti comuni degli individui siano più importanti delle divisioni sterili e ideologiche, può aiutare a ricostituire un po’ di armonia nel discorso politico. Capirlo attraverso i due più importanti presidenti del primo rispettivamente secondo Novecento può aiutare in questo senso; d’altronde, come ha spiegato Allan Lichtman su “The National”, i due erano «the once in a generation inspirational candidates».
Entrambi i presidenti, come ha scritto Brands, «sono entrati in carica in tempi di turbolenza economica e scoraggiamento nazionale; ognuno ha cercato di trovare l’equilibrio ottimale tra il settore pubblico e quello privato nella vita americana. Roosevelt, il democratico dell’Est, affrontò il problema da sinistra, costruendo il settore pubblico in risposta al crollo del settore privato nella Grande depressione degli anni Trenta. Reagan, il repubblicano dell’Ovest, ha affrontato il problema da destra, promuovendo il settore privato in risposta al naufragio della Great Society durante gli anni Settanta.» Fu proprio Reagan a smantellare parte della Great Society voluta da Lyndon B. Johnson, nonché gli ultimi avanzi del New Deal rooseveltiano, primo e relativamente visionario e controverso pacchetto di welfare state nella Storia americana.
Entrambi erano in grado di domare l’elettorato. Pur non essendo populisti, un pizzico di benevola demagogia la utilizzarono per forza di cose, specialmente Reagan. Non si vergognavano di voler essere il simbolo della gente ordinaria e comune; e soprattutto di dar loro genuina speranza, senza demonizzare l’avversario politico. I due avevano capito come incantare gli americani con carisma e narrativa. Roosevelt sapeva manipolare abilmente la radio e s’inventò le conversazioni al caminetto (i fireside chats); Reagan – chiamato a ragione il Grande Comunicatore – preferiva apparizioni televisive dove alterava solennità ad humor (la stessa tecnica per cui era diventato relativamente famoso a Hollywood negli anni Quaranta). Sia Roosevelt che Reagan conoscevano la differenza tra politica idealistica e quella della concretezza, piano e obiettivo, retorica e azione.
Entrambi avevano grandi ambizioni e una notevole statura geopolitica. Amavano strafare, ma anche ascoltare i consigli di consulenti e advisor. FDR non cedeva potere e non delegava con piacere; dopo aver risollevato l’economia con il New Deal si trovò costretto a riportare gli Stati Uniti in guerra in Europa, dunque a ridisegnare la carta geopolitica del pianeta a Teheran e Yalta. D’altra parte, Reagan è stato un leader con poche idee, ma in compenso precise. Alla Casa Bianca era arrivato con due grandi progetti: quello interno era rilanciare l’economia americana; quello estero, oltre che a ridare prestigio ed egemonia all’America (“Make America Great Again” era un suo slogan prima che venisse scippato e distorto da altri), era convincere i sovietici alla riduzione delle armi nucleari.
Entrambi adottarono una politica economica espansionista. L’enorme debito pubblico lasciato dall’Amministrazione Reagan fu un problema per il Partito Repubblicano (diventato poi, al pari di quello Democratico, il partito del debito pubblico), i cui membri sembravano aver abbandonato l’ortodossia budgetaria e le lezioni di Milton Friedman. Roosevelt era sostanzialmente keynesiano (in questo era il padre indiretto del sistema di Bretton Woods), mentre Reagan – a livello teorico – non si vedeva male in panni hayekiani (in questo era il padre indiretto del Washington Consensus). Entrambi usarono per breve tempo l’arma protezionistica: il primo, nella seconda metà degli anni Trenta per rilanciare il consumo interno; il secondo, a causa dell’“invasione” commerciale giapponese negli anni Ottanta. In generale, Roosevelt si attenne alle politiche di John Maynard Keynes, il cui modello durò fino alla metà-fine degli anni Settanta. Reagan, d’altra parte, preferiva tagliare le tasse (elemento di economia liberale), ma come ha ricordato Brands, sebbene il Gipper limitò imposte e regolamentazioni del mercato, non fece lo stesso con la spesa pubblica inefficiente. Il risultato fu certamente una crescita economica, ma pure l’esplosione del debito federale.
Entrambi aumentarono le spese militari. In particolare, Reagan giustificò il fatto che quello era il prezzo da pagare per la libertà di milioni di individui sotto il Patto di Varsavia. Sia negli anni Quaranta che negli anni Ottanta, la corsa agli armamenti che seguì l’aumento di spesa in difesa da parte di Washington fu ben vista da molti alleati europei: nel caso di Roosevelt per ovvie ragioni, dal momento che l’Europa doveva essere liberata dal Nazifascismo e in Regno Unito aspettavano l’aiuto militare per sbarcare in Normandia. Nel caso di Reagan, bisognava sconfiggere l’evil empire, mostrando i muscoli, ma senza sparare un colpo; con l’eccezione di François Mitterrand – che intratteneva strette relazioni con i sandinisti – tutti gli alleati in Europa furono sollevati dall’incremento della quota di PIL americano allocato alla spesa militare.
Entrambi lasciarono la presidenza ai loro vice, quasi affinché questi continuassero e ultimassero l’opera iniziata dai grandi. Harry Truman – per il quale Reagan aveva raccolto fondi in campagna elettorale e che votò senza entusiasmo – concluse la Seconda Guerra Mondiale con l’ordigno nucleare scaraventato sul Giappone e avviò la ricostruzione istituzionale del nuovo mondo sotto legacy rooseveltiana. George H. W. Bush, che ebbe meno successo e fu molto meno incisivo di Truman, dovette gestire la questione irachena, ma soprattutto l’ampio deficit. Dovette dunque aumentare la pressione fiscale, contravvenendo alla famosa promessa elettorale del «read my lips», cosa che gli costò un secondo mandato nel 1992.
Entrambi avevano capito che la chiave del successo era diffondere ottimismo, fede e speranza al cittadino americano e al resto del mondo. Un new deal, un nuovo corso, nella politica americana delle rispettive epoche. Roosevelt aveva diminuito la disoccupazione – arrivata sopra il venticinque per cento nel 1933 – e la deflazione; Reagan dimezzò la disoccupazione – arrivata all’undici per cento nel 1982 – e fece crollare l’inflazione. Questo diede fiducia ai cittadini: in entrambi i casi, molti americani tornarono a credere in se stessi. Fondamentalmente il messaggio dei due presidenti era quello dell’ottimismo. È così che rinnovarono il sogno americano intergenerazionale. Entrambi svolsero la funzione di ristoratori di fede in un popolo stanco e in declino: quello del crash di Wall Street negli alla fine degli anni Venti, quello della crisi petrolifera alla fine degli anni Settanta. Per questo ed altro, entrambi furono equamente odiati e adorati.
Classe 1997, studente italo-svizzero; Bachelor in Scienze della Comunicazione all’Università della Svizzera Italiana di Lugano e Master in Relazioni Internazionali all’Università Carlo di Praga. Ha fatto oltre 450 interviste e collabora alle testate “L’universo”, “L’Osservatore”, “Immoderati”, “Progetto Repubblica Ceca”, “La Voce di New York”, “Corriere dell’Italianità”, Istituto Bruno Leoni – Blog. Appassionato di (geo)politica, affari e relazioni internazionali, storia, economia, giornalismo e news. Gestisce “Blackstar”.