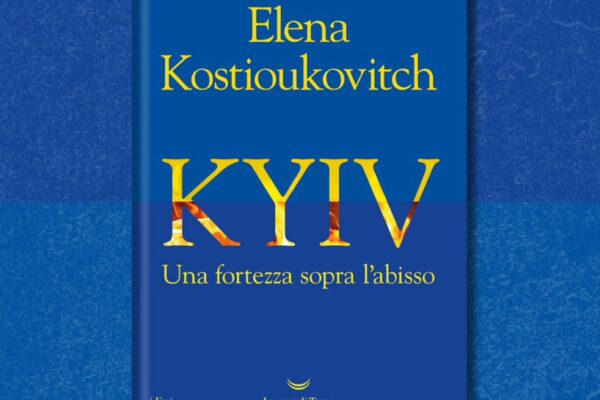Una adeguata dissertazione in ordine alle cause dell’entrata nel primo conflitto mondiale dell’Italia implica una approfondita riconsiderazione storiografica che scompagina consolidati schemi per lo più comunemente e acriticamente accettati, aventi spesso matrici ideologiche, a volte anche con contorni faziosi, atteso che una diversa, più articolata e coerente interpretazione dei fatti stride con la mitologia repubblicana post 1945, in quanto, ponendo a base dell’entrata in guerra solo l’aspirazione irredentistica (ciò che invece non fu!), cioè la liberazione delle terre soggette al dominio straniero, fa esattamente il paio con l’altra liberazione, poggiante sul mito resistenziale ed antifascista come piedistallo emotivo di massa e saga funzionante da “scudo protettivo” della Repubblica.
L’attacco decisamente critico rappresenta dunque l’occasione di serie riflessioni storico-critiche e non retoriche o apologetiche circa gli eventi di cui trattasi, non potendo non partire, peraltro, anche da alcune considerazioni in merito alla vittoria italiana del 4 novembre 1918 contro l’Austria, una sorta di “non-commemorazione” che, anche questa, ha per lo più provenienze ideologiche.
Infatti, quella vittoria dimenticata – come ebbi già a scrivere in occasione del centenario – fu prodromica all’avvento del fascismo, ne fu pronuba, in quanto il fascismo si ergeva a unico erede dell’arditismo, del volontarismo, del cameratismo, dell’aristocrazia da trincea, cosicché il mito dell’uomo nuovo andava a braccetto con il mito della vittoria mutilata. Il tutto, secondo una visione ideologica – appunto quella repubblicana – in base alla quale quella vittoria, più che superare la disperazione di Caporetto, fu una vittoria ambigua da cui il fascismo trasse forza e consenso, ciò che collide con il mito della Repubblica, la quale, anziché sforzarsi nella ricerca di nuovi valori condivisi e fondanti della civitas nazionale, dall’antifascismo continua a trarre, almeno per alcune grandi forze politiche che la sorreggono, la sua ragion d’essere.
L’intento forse ambizioso di questo programma vuole essere dunque il tentativo di un ripensamento storico-critico, in termini di proposizione di motivi di più accurata riflessione nonché di un riposizionamento concettuale e logico rispetto ad accadimenti e interconnessioni fors’anche inaspettati. Insomma, un excursus storico-critico che valga a ricollocare organicamente l’evento de quo in chiave di continuità con il processo risorgimentale e post-risorgimentale, pervenendo così a più coerenti prospettazioni interpretative e re-interpretative rispetto a situazioni altrimenti in larga parte inesplicabili.
D’altra parte, Historia magistra vitae recita l’antica massima, per affermare che il passato illumina il presente, talché ove presa alla lettera si scadrebbe nel determinismo e nella ripetitività dei fatti storici. In realtà la storia è un tunnel di cui non si vede la luce! Infatti, è anche il presente a schiarire il passato e a renderlo sempre più intellegibile, gettando su di esso nuova luce e fornendo continuamente nuovi elementi di valutazione. Insomma, un rapporto di interscambio conoscitivo e interpretativo nell’ambito di una corretta e rielaborata dialettica tra passato e presente su un invertito asse temporale. Una consecutio temporum non soltanto descrittiva ma soprattutto interpretativa – giustappunto come nel caso in trattazione – per scoprire concatenazioni storicamente attendibili, magari dotate pure di una certa suggestività. D’altra parte Historia non facit saltum! La Storia non è assimilabile ad un “sistema modulare” (Sybrick) in cui ogni “blocco” può essere estrapolato e diventare oggetto di analisi a sé stante, ma è un susseguirsi di accadimenti organicamente interconnessi soprattutto nella dimensione temporale su un asse crono-centrico nella ricerca di motivi unificanti di continuità piuttosto che di breack, eventi che di per sé si pretenderebbero, da parte di alcuni, esaustivi come modelli sociologici autoesplicativi dei fatti storici, centrati su astratte formulazioni atemporali e su pretenziosi modelli strutturali e storicistici (p. es. Scuola delle Annales, analisi marxista, ecc.).
ANTEFATTI RISORGIMENTALI
Proprio in virtù di quanto innanzi delineato, occorre pervenire ad un corretto e coerente inquadramento del primo conflitto mondiale, con riguardo soprattutto al suo complesso e articolato mix motivazionale – ciò che costituisce appunto il cardine della presente illustrazione – alla luce dei suoi antefatti storici, vale a dire gli sviluppi risorgimentali e post-risorgimentali, talché è d’uopo svolgere un veloce excursus storico-critico circa tali percorsi, a volte tortuosi, che, senza nulla togliere alla grandiosità dell’epopea risorgimentale, sono stati non sempre e non del tutto idonei a completare l’effettiva unità della nazione italiana.
I suoi prodromi si collocano nel Congresso di Vienna, in cui i negoziatori si pongono l’obiettivo primario di ristabilire, a vantaggio dei grandi Stati, la legittimità dei sovrani, utilizzando il principio giuridico-morale e quello più pragmatico dell’equilibrio europeo, per cui la carta europea veniva a semplificarsi, ancorché siffatta semplificazione non tenesse conto in alcun modo del nuovo principio introdotto nella Storia dalla “Rivoluzione Atlantica”, cioè l’affermazione del principio delle nazionalità contrapposto a quello dinastico.
E’ dunque questa Europa – clericale, legittimista, aristocratica e reazionaria – il “terreno di coltura” in cui cominciano a maturare i germi cospirativi e insurrezionali, ovverosia i fermenti ideologici e culturali di carattere nazionale e liberale per un lungo seguito di rivoluzioni nel continente, che finiranno per avere riflessi anche sulle vicende risorgimentali italiane, atteso che soprattutto in Italia rispecchiano più marcatamente un carattere intellettuale, liberale-costituzionale e borghese, in altri termini, più spiccatamente nazionale e tendente appunto all’autogoverno e all’autodeterminazione.
Ma dopo i trionfi dell’aprile-maggio 1848, la rivoluzione, che ormai rifluisce in tutti i paesi europei, si spegne anche in Italia con la pesante e definitiva sconfitta di Novara, nel marzo 1849, subita dal Re Carlo Alberto nella Prima Guerra d’Indipendenza, anche a causa della cecità politica degli altri sovrani centromeridionali e della intrinseca debolezza dell’esercito piemontese, così come avranno termine le rivoluzioni più prettamente “nazionali” di Venezia, Praga, Zagabria e Roma.
E’ proprio in siffatto contesto, però, che in Italia incomincia a maturare l’idea che l’unificazione non sarebbe potuta realizzarsi secondo il progetto democratico-mazziniano, ma, passando definitivamente nelle mani della classe dirigente liberale-moderata e di fede monarchica, concretizzarsi con il Regno di Sardegna – il cui Re Vittorio Emanuele II si presentava appunto come l’ultimo baluardo della moderazione – e con l’aiuto di potenze straniere, in particolare della Francia.
La seconda fase del Risorgimento, quindi, realistica e spregiudicata in politica estera, che inizia con la paziente decennale opera del “Grande Tessitore”, Camillo Benso di Cavour, “transita” per la “gratuita” partecipazione della Francia (che non ha alcun interesse pratico ma ne fa solo una questione di prestigio) e del Piemonte nel 1854-1855 alla guerra di Crimea nonché per i Patti di Plombières nel luglio 1858, con quel personaggio misterioso e ambizioso, collaterale di Napoleone Bonaparte e che s’indusse a chiamarsi Napoleone III (in quanto nulla più si sapeva del secondo, il figlio Napoleone e di Maria Luisa), e si conclude con l’annessione al Regno della sola Lombardia, “girata” al Regno di Sardegna come una cambiale, dopo la Seconda Guerra d’Indipendenza nel 1859. Questa, sostanzialmente combattuta e vinta dai francesi di Napoleone III a Solferino, ancorché con l’apporto dell’esercito piemontese nelle battaglie di Magenta e San Martino, con la cessione, peraltro, dei territori di Nizza e Savoia alla Francia, trova il suo epilogo a Villafranca, dove s’incontrano i due imperatori Napoleone III e Francesco Giuseppe, ignorando il terzo incomodo piemontese, ma non con un armistizio bensì con dei veri e propri preliminari di pace.
In realtà, la Francia, che aveva assicurato di combattere per la libertà italiana, pur mirando di fatto a dominare la Penisola in luogo dell’Austria, ora, di fronte alle difficoltà, si accontentava di una spartizione di zone di influenza, il tutto mascherato dalla ingannevole volontà di impedire ulteriori spargimenti di sangue.
Tutto ciò comunque darà la stura, l’anno successivo, all’impresa garibaldina della conquista del Regno di Napoli – con il beneplacito però dell’Inghilterra, che aveva in animo di distruggere quel regno posto al centro del Mediterraneo – propedeutica alla proclamazione, il 17 marzo del 1861, del Regno d’Italia, anche se ancora senza il Veneto e Roma.
Insomma – e qui sta il “cruccio” storico, l’altra “distonia” nel processo di formazione della nazione – l’unificazione dell’Italia avveniva non militarmente, ma, nonostante gli sforzi profusi dal piccolo Regno di Sardegna, da un lato grazie a Napoleone III, alla costante ricerca di prestigio internazionale, dall’altro ad opera di Gladstone e dei liberali inglesi. Ed è da qui, dal “tradimento” francese di Villafranca appunto, dalla profonda delusione e dall’amarezza per un trattato che di fatto oscurava e allontanava la possibilità di ricomporre in toto il territorio nazionale, che incomincerà a prendere corpo e a dipanarsi quel filo conduttore che porterà dritto dritto – in concorso con altri fattori che in appresso andranno a verificarsi – al mix causale dapprima delle imprese coloniali e, in rapida successione, dell’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale, e, come si vedrà di sfuggita, anche a quello della Seconda. Ed è proprio da qui che, al di là di ciò che può sembrare solo una superflua esposizione di antefatti storici che nulla avrebbero a che vedere con il tema in trattazione, che incomincia a concretizzarsi l’assunto metodologico posto come premessa!
Mutato dunque lo stato d’animo dell’Italia verso il Paese d’oltralpe, ai fini dell’acquisizione del Veneto al giovane regno, si realizza un quinquennio più tardi, a seguito di manovre diplomatiche e politiche ancora più macchinose di quelle attuate per la preparazione della Seconda Guerra d’Indipendenza, una convergenza di interessi dell’Italia con quelli di Bismark, l’autoritario cancelliere prussiano, fautore di una forte politica espansionistica del Reich, principalmente in funzione antiaustriaca e antifrancese.
Tuttavia, ancora delusioni più cocenti dovranno arrivare con la Terza Guerra d’Indipendenza, che porta sì all’annessione del Veneto, ma solo grazie alla sconfitta dell’Impero asburgico ad opera della Prussia, a cui l’Italia si era alleata, a seguito della schiacciante vittoria di Sadowa, nel luglio 1866, colta dal formidabile esercito prussiano guidato da von Moltke e strumento della politica bismarkiana: tutto ciò, mentre le armi italiane subivano, ad opera degli austriaci, le umilianti sconfitte di Lissa per mare e di Custoza per terra, talché, almeno in una prospettiva nazionale, la guerra doveva considerarsi fallimentare sia per i gravi insuccessi militari sia per il fatto che rimanevano fuori dal regno – e questo sarà un altro passaggio chiave – altri territori, come il Trentino e l’Istria, popolati da numerosissimi italiani. Infatti, con il Trattato di Praga tra l’Austria e la Prussia, veniva decretato il passaggio del Veneto all’Italia tramite Napoleone III, ma non anche di Trento e Trieste, nonostante che Garibaldi, con un’avanzata nel Trentino, avesse ottenuto uno smagliante successo a Bezzecca nel mese di luglio.
Insomma, nel suo primo cimento bellico il nuovo Stato unitario non aveva fornito una buona prova di sé e ciò anche a prescindere dall’entità delle sconfitte subite: del resto, Custoza non era stata una grande battaglia e, dopo Lissa, la flotta italiana era ancora superiore a quella austriaca. E, come vedremo, sarà proprio la consapevolezza della gravità della sconfitta di Lissa che, in prosieguo, darà luogo alla preoccupazione “regina” della nostra marina: il dominio dell’Adriatico, da sempre vero cruccio della forza navale italiana, ciò che si inserirà prepotentemente nel mix rivendicativo innanzi detto, come aspirazione nazionalistica, per l’appunto a ridosso dell’entrata in guerra a fianco delle Potenze dell’Intesa. La Grande Guerra italiana in mare, con l’egemonia del Mare Adriatico, avrà come obiettivo anche la rivincita di Lissa!
Anche la conquista di Roma e l’annessione del Lazio al Regno d’Italia nel 1870 saranno determinati da successi altrui, questa volta a spese della Francia, sconfitta dalla Prussia il 2 settembre a Sedan, la quale, con il crollo dell’impero di Napoleone III, non era più in grado di proteggere militarmente lo Stato pontificio. Ancora una volta, quindi, un grande obiettivo connesso alla unificazione del Paese, vale a dire lo smantellamento del potere temporale della Chiesa e la sua incorporazione nella Monarchia Sabauda, sopraggiungeva non per l’effetto di vittorie militari proprie ma per un caso, soltanto come conseguenza della sconfitta dell’imperatore francese, in aiuto del quale, peraltro, Vittorio Emanuele sarebbe comunque dovuto accorrere, nonostante il “tradimento” di Villafranca, in virtù dell’aiuto dato al Piemonte nel 1859.
ASTI ANTIGOVERNATIVI E NUOVE CORRENTI
Negli anni successivi, proprio per come si era concluso il processo di unificazione nella consapevolezza dei tanti insuccessi che avevano costellato tutto il periodo risorgimentale, incomincia quindi a serpeggiare una diffusa sensazione di malessere spirituale, una sorta di “complesso di inferiorità”, un senso di frustrazione generale e un desiderio di riscatto, che, pur non interessando la maggioranza della popolazione italiana, ancora estranea al processo di unificazione nazionale, alimenta nelle minoranze politicamente attive un risentimento contro il governo nonché vaghi desideri di ingrandire il territorio nazionale con la incorporazione di territori italiani ancora sotto il dominio dell’Austria. Insomma, finisce per ingenerarsi una sensazione che l’Italia dopo il 1870 fosse ancora incompiuta, che, sfociando gradualmente in aneliti di rivincita e di espansione territoriale, trapassa insensibilmente in quello che incomincia a delinearsi come “irredentismo”. Questo, dapprima di matrice di “sinistra”, e quindi di fonte repubblicana e democratico-mazziniana, si trasformerà gradatamente in un movimento ispirato ad una generale volontà di potenza e ad inclinazione nazionalistica: diretto, quindi, contro l’Austria con l’obiettivo della liberazione del Trentino e della Venezia Giulia, perverrà, in prosieguo, a progetti di ben più ampio respiro. In definitiva – ed è questo un altro passaggio fondamentale – le rivendicazioni, inizialmente irredentistiche e – senza voler anticipare nulla – più tardi anche nazionalistiche e colonialistiche, finiranno per riguardare non più soltanto Trento e Trieste, ma anche il Brennero, la regione Dalmatica e l’Albania; successivamente, soprattutto in funzione antifrancese, anche la Corsica, la Savoia, la Tunisia e il porto di Gibuti, seguitando poi con Malta, il Canton Ticino e le Isole Ionie. In prospettiva, come si vedrà, veri e propri “cavalli di battaglia” saranno altresì gli sbocchi del Mediterraneo, vale a dire gli stretti di Gibilterra e di Suez.
Volendo circoscrivere e meglio puntualizzare, per ora, le aspirazioni irredentistiche, in quanto uno degli elementi causali fondamentali dell’entrata in guerra dell’Italia nel 1915, non vi è dubbio che nel corso del tempo, nazioni ben più forti, vale a dire le Monarchie di Francia, Inghilterra e Spagna, avessero posto in atto una lenta erosione delle regioni italiane di confine: la Corsica, sottratta dalla Francia di Luigi XV alla Repubblica di Genova nel 1768 con il Trattato di Versailles; la cessione di Venezia e della Dalmazia all’Austria con il Trattato di Campoformio nel 1797 (Trieste si era già data all’Austria per l’odio verso Venezia); l’isola di Malta, già conquistata da Napoleone nel 1798, nel 1814 diventava colonia Britannica; Nizza e Savoia venivano cedute alla Francia con il trattato franco-piemontese del 24 marzo 1860.
Insomma, nel corso del tempo, i confini dell’Italia-nazione, ma non ancora Stato, si erano via via ristretti a seguito della perdita di territori indiscutibilmente italiani per lingua, storia e civiltà, cosicché era venuto a crearsi uno iato tra i veri confini italiani – in senso linguistico, storico e geografico – e quelli del Regno d’Italia, come entità politica, dopo il 1861 ed il 1866, ma anche dopo il 1870.
Tutto ciò veniva a collidere con il concetto di nazione così come affermatosi nelle ideologie politiche ottocentesche, sia nella versione tedesca, fondata su una visione di unità culturale e linguistica (Herder e successori) sia in quella francese, così come scaturita dalla Rivoluzione, a caratteri per lo più volontaristici.
Sarà proprio questa idea nazionale, nella sua evoluzione, che, partendo dal patriottismo di matrice liberale e democratica, perverrà in prosieguo – non soltanto in Italia ma in tutta Europa – al nazionalismo e all’imperialismo di fine secolo, “transitando” appunto per l’irredentismo, che, dapprima democratico e repubblicano, acquistando via via i caratteri anzidetti, culminerà poi nell’interventismo del 1914-1915.
A voler concludere sul punto, di certo assai qualificante come fatto causale per l’entrata in guerra, v’è da osservare che, in effetti, il termine “irredentismo” – che certamente designava, sin dalle prime fasi risorgimentali, l’aspirazione italiana a rendere completa, e sicuramente in funzione antiaustriaca, l’unità nazionale con la liberazione di quelle terre ancora soggette alla dominazione straniera, per l’appunto le “terre irredente” cioè non salvate – prendeva corpo solo dopo il 1875, dando così un nome ad aneliti di certo già preesistenti e diffondendosi rapidamente in tutto il contesto europeo ed anche oltre. Purtuttavia, a ben vedere, anche l’irredentismo nella sua originaria e autentica espressione antiaustriaca veniva a trovare una qualche limitazione. Ciò in quanto, se il Veneto in senso stretto faceva indubbiamente parte a pieno titolo, per il principio di nazionalità, del nuovo Stato Italiano, non altrettanto poteva dirsi con sicurezza per quelle zone del litorale adriatico conosciute, nel loro insieme, come Venezia Giulia (che, appunto, prendeva il nome dalla gens Julia, a cui appartenevano Giulio Cesare e Ottaviano Augusto): infatti, se vi faceva parte una cospicua porzione sicuramente italiana (Gorizia, Trieste, tutta la costa istriana e Fiume), erano pure presenti una maggioranza slovena nell’alto Isonzo ed una croata nell’Istria interna, mentre la zona di Tarvisio era interamente tedesca.
POST-RISORGIMENTO E GUERRE COLONIALI
Svolta dunque la necessaria riflessione in ordine al fatto che le rivendicazioni italiane interessavano non sempre e non del tutto territori considerati “irredenti” sia sul piano storico-giuridico che su quello più squisitamente culturale, non vi è dubbio comunque che l’irredentismo italiano, che ha la sua matrice ideale nel sentimento di incompletezza e di delusione dopo il 1870, acquisti maggiore consistenza soprattutto dopo l’avvento della Sinistra al potere nel 1876, in una sorta di implicito accordo tra le istanze monarchico-liberali e le sempre più pressanti spinte democratico-mazziniane risorgimentali e post-risorgimentali.
In definiva, l’accettazione della Monarchia finisce per passare, in tal modo sottintendendola, attraverso la sua capacità di saper guidare una riscossa nazionale onde consentire al nuovo Stato unitario di occupare ora, nel contesto europeo e mondiale, quel posto di rilievo che le competeva e che i miti e le aspirazioni risorgimentali – pur a fronte delle passate deludenti prove del nuovo Stato e del suo Governo, verso cui si indirizzava adesso un diffuso sotterraneo risentimento – avevano ingenerato nell’opinione pubblica, quantomeno in quella più politicamente e culturalmente impegnata. Insomma, finisce in tal modo per instaurarsi un ideale compromesso, un tacito accordo contenente, tuttavia, anche una univoca riserva politica, affinché la Monarchia, mostrandosi all’altezza del suo ruolo storico, potesse completare l’opera del Risorgimento sotto vari aspetti: da quello culturale, sociale ed economico alla soluzione delle “Questione Romana”, dalla capacità di colmare il divario tra il Nord e il Sud a quello, soprattutto, di dare all’Italia quel ruolo di prestigio in Europa che le spettava per la sua riconosciuta e indiscussa “missione” nel mondo.
In ogni caso, si sarebbero dovute creare dapprima le condizioni effettive affinché il nuovo Stato potesse di fatto interpretare un ruolo di grande potenza; il nuovo Regno, invece, diviene di colpo aspirante tale, senza aver prima risolto però, almeno per la maggior parte, i gravi problemi che affliggevano – e non solo da quel momento – i nuovi territori del Centro e del Sud della Penisola, ciò che sin da allora avrebbe posto gravi incognite per il futuro sviluppo della vita nazionale.
La nuova classe politica insediatasi al potere, dunque, smaniosa di esibirsi in politica estera e per di più attratta ora dalla politica di potenza di Bismark – in virtù dell’implicito accordo con la Monarchia, che del resto si era venuta a trovare nella condizione di dover contrastare una diffusa, inquietante sensazione, nei propri confronti, di inadeguatezza e di abbandono degli ideali risorgimentali – dà la stura ad una politica di potenza, in special modo dopo lo smacco italiano al Congresso di Berlino nel giugno 1878, da cui l’Italia sarebbe uscita con “le mani nette”, nel mentre tutti gli altri Stati si sarebbero rafforzanti mediante l’acquisizione di nuovi territori ed ulteriori spazi di manovra, e “l’affare” di Tunisi, allorquando la Francia, precedendo un’analoga iniziativa dell’Italia, conquistava la Tunisia, imponendovi il suo protettorato.
Tramontata infatti la linea della prudenza in campo internazionale, sebbene, ad onor del vero, il tacito accordo tra la larga fetta di opinione pubblica che faceva capo soprattutto alla Sinistra puntasse non soltanto sulla politica di potenza e sul ruolo storico dell’Italia in politica estera bensì anche sulla soluzione delle altre problematiche incombenti sul nuovo Stato, alla fine la scorciatoia irredentistica prima e poi quella colonialistico-imperialista diventano il trait d’union tra la nuova borghesia, ormai “smaniosa” di esibirsi in politica estera e la Monarchia, ma anche la scappatoia, ossia l’alibi per eludere la soluzione dei gravissimi problemi che attanagliavano il nuovo Stato unitario. Peraltro, il colonialismo verso l’Africa sarebbe finito per diventare, a seguito della stipulazione del Trattato della Triplica Alleanza con la Germania e l’Austria, nel 1882, un sostituto dell’irredentismo – che poi, come si vedrà, avrebbe ripreso vigore proprio a ridosso dell’intervento nella guerra mondiale, divenendo parte integrante del relativo mix rivendicativo – tanto è vero che soltanto tre anni dopo verrà avviata una politica di espansione nel Mar Rosso e in Etiopia.
L’apertura del capitolo delle guerre d’Africa nel 1885, pertanto, non può considerarsi casuale, in quanto, “congelata” nel 1882 la questione irredentistica, diretta fino a quel momento in primis contro l’Austria, riprende vigorosità la tendenza coloniale e africanista della nostra politica estera, consentendo così anche all’Italia di avviarsi, sebbene ultima tra le grandi potenze europee, a prendere parte alla gara imperialista.
In conseguenza, bloccato l’irredentismo per l’adesione dell’Italia alla Triplice Alleanza, dato che a partire da quegli anni l’Austria incomincia ad apparire un controbilanciamento all’espansionismo russo ed anche come possibile alleata in funzione antifrancese, dando fiato alle aspirazioni della nuova ed avventurosa classe dirigente ed alla larga fetta di opinione pubblica ora favorevole ad una politica di potenza e facendo passare in secondo piano tutti i nodi irrisolti dell’arretratezza del Paese, prende corpo il fenomeno del colonialismo, – che, in tal modo, finisce per diventare del tutto intercambiabile all’irredentismo, ma sommandosi successivamente a questo come elemento causale dell’entrata in guerra dell’Italia – sebbene la maggior parte della storiografia sull’argomento tenda a considerarlo di secondo piano rispetto a quello irredentistico.
Ma dovendo dare qualche cenno anche alle imprese coloniali, se non altro per le loro conseguenze in termini causali rispetto agli accadimenti successivi e in particolare a quello pregnante dell’entrata nel conflitto mondiale, v’è da evidenziare come tutto il capitolo del complesso motivazionale delle guerre coloniali nel periodo postrisorgimentale sia pressoché ignorato o quantomeno sottovalutato dalla storiografia ufficiale, la quale tende a giustificarle soltanto in termini di interesse nazionale estrinsecantesi in una politica estera volta all’espansionismo quale manifestazione “adulta” della volontà di vita della giovane nazione italiana, quando non proprio riconducibili del tutto ad una tradizionale politica espansionistica dei Savoia.
Insomma, il colonialismo di fine secolo XIX trova giustificazione, ad avviso di tale storiografia, soltanto nell’ambito di una politica di potenza sorta quasi per caso, nel contesto delle nazioni europee ben più attrezzate sotto tale profilo. In definitiva, si è posta in atto una sorta di cesura storica rispetto all’epopea risorgimentale, ciò che, isolando il capitolo coloniale e riducendolo così ad un “modulo” a sé stante, lo rende sostanzialmente inintelligibile sotto il profilo motivazionale, sia prima che per gli accadimenti successivi. Invece, proprio la sua ricollocazione su un autoesplicativo asse crono-centrico di accadimenti organicamente interconnessi nella loro dimensione temporale, evidenziando motivi di continuità sia con il percorso risorgimentale sia con quello successivo, consente di coglierne appieno la genesi e il reale significato storico.
La Monarchia viene così a trovarsi ad un drammatico bivio: o dare la stura alla scorciatoia coloniale o essere messa fortemente in discussione, con una significativa perdita di consensi per la vigorosità di tendenze repubblicane sempre più pressanti. Ma poteva il nuovo Stato unitario, con tutte le sue fragilità, considerarsi una grande potenza o almeno aspirante tale? Certamente no!
In conseguenza, con una sommaria preparazione militare, vengono avviate nel 1885, partendo dalla colonia Eritrea acquistata nel 1882, le operazioni militari per l’espansione in Africa Orientale.
Ma anche questa, infatti, è destinata ad aggiungere ulteriori delusioni e profondo senso di frustrazione. Già nel gennaio del 1887, il massacro dei cinquecento uomini del tenente colonnello De Cristoforis a Dogali ad opera di preponderanti forze di Ras Alula; dopo la denuncia unilaterale, nel maggio del 1893, del Trattato di Uccialli da parte di Menelik e i parziali successi di Agordat, Cassala, Senafè e Adigrat negli anni 1894-95 da parte delle armi italiane, la carneficina, il 7 dicembre 1895, dei duemilatrecentocinquanta uomini del maggiore Toselli al passo dell’Amba Alagi. Ma il peggio dovrà ancora arrivare nel mese di marzo dell’anno successivo, con il disastro di Adua, per mano del negus Menelik rifornito di armi dalla Francia, in cui avrebbero trovato la morte cinquemila italiani oltre ad un migliaio di ascari e millecinquecento feriti, più morti quindi di tutti quelli avutisi nelle guerre d’Indipendenza.
La terribile sciagura di Adua, senza pari nella storia risorgimentale e post-unitaria, frutto di imperizia, impreparazione, approssimazione, oltre che di cecità politica, avrebbe portato all’uscita dalla scena politica dell’ormai odiato Crispi e al momentaneo accantonamento di velleità colonialistiche/imperialistiche. Sulla scena scendeva una coltre di odio: si parlò di vergogna, di tradimento, di tutto ciò che prostrava la nazione. Venivano occultate le gravissime responsabilità politico-militari che avevano determinato il fallimento delle imprese coloniali in Africa, tant’è che il generale Oreste Baratieri veniva sì assolto dal Tribunale di Guerra, riunitosi nel giugno del ’96, da responsabilità penali ma con deplorazione dell’esercizio del suo comando. Persino il rigurgito colonialistico nella guerra italo-turca nel 1911, che avrebbe sì consentito la conquista della Libia, limitatamente però alle sole città costiere, avrebbe rivelato impreparazione militare, conducendo anche a gravi insuccessi, come il massacro di bersaglieri a Sciara Sciat. Solo nel 1924 il fascismo ne avrebbe completato la conquista con l’occupazione delle zone interne.
Il PRELUDIO ALLA NUOVA GUERRA
Il secolo era finito sì con un regicidio, ma il giovane Re Vittorio Emanuele III aveva scelto la via della concordia, della moderazione e del parlamentarismo, e comunque era passata alla bell’e meglio la guerra italo-turca, che aveva consentito la conquista, seppure parziale, della Libia e delle isole del Dodecanneso.
Ma di lì a poco, lo scoppio della guerra, in un’estate che pareva quieta, coglieva tutti di sorpresa.
Prima di addentrarci però nella disamina delle condotte politiche e motivazionali determinanti per l’ingresso in quel grande conflitto che fu la Prima Guerra Mondiale, occorre dare uno sguardo d’insieme alla posizione italiana in quei gravi momenti, valutando i vari fattori esogeni ed endogeni, come pure gli antefatti aspirativi della giovane nazione sul filo della continuità Risorgimento/post-Risorgimento; saranno questi a determinare le scelte compiute dalla classe dirigente e dalla stessa Monarchia, tenendo anche conto del fatto che negli anni successivi all’assassinio di Re Umberto, ai rilevanti successi economici e sociali facevano da contraltare uno spostamento a sinistra dell’asse politico e una messa a lato dell’istituto monarchico proprio per effetto dell’assunzione, a partire dal 1901, di più ampie responsabilità politiche da parte del Governo.
Certo è che Giolitti, il protagonista di quel periodo, pur mantenendo il legame con Germania e Austria-Ungheria, curava allo stesso tempo il ripristino di buoni rapporti con Francia e Russia come pure con la Gran Bretagna, nel convincimento, peraltro non infondato e largamente condiviso, della centralità ineludibile dell’amicizia con l’Inghilterra data la sua naturale propensione a sostenerci nel Mediterraneo come elemento equilibratore tra Francia e Austria-Ungheria. Tutto ciò in sintonia con i sentimenti di Vittorio Emanuele III, il quale, distinguendosi per equilibrio e lungimiranza politica, incominciava ad estraniarsi dalle simpatie tripliciste del padre, certamente convinto del progressivo esaurimento della precedente fase dell’Alleanza con gli Imperi Centrali. In sintonia con il suo ministro degli Esteri, il marchese Antonino di Sangiuliano, il quale aveva iniziato una politica di avvicinamento alle potenze dell’Intesa, si stava adoperando per allentare i vincoli che univano l’Italia alla Triplice, al fine di conseguire spazi di autonomia politica e di dirigersi verso la Francia, l’Inghilterra e la Russia, nella convinzione, non a torto, che ciò fosse congruente con la tradizionale politica di ingrandimento territoriale di Casa Savoia, che, pur temperata da una coscienza politica italiana, restava comunque la garante della Nazione e custode dell’unità e dell’unicità dell’autorità dello Stato al di là dei mutamenti di governo e di indirizzo politico. E questo in un momento in cui stavano tornando di larga attualità i gravi contrasti con l’Austria-Ungheria per la ripresa irredentistica, non solo relativamente ai territori trentini e friulani ma anche per quelli nell’Adriatico e nei Balcani.
In realtà, utilizzando i poteri statutari in materia internazionale, il nuovo Re aveva iniziato a svolgere un ruolo di primo piano nella definizione delle politica estera dell’Italia già prima del 1914, proponendosi da subito di dare un nuovo orientamento alla diplomazia italiana che, sotto il regno del padre, aveva operato una rottura con il tradizionale equilibrio tra i sistemi di alleanze care ai Savoia, e in siffatto quadro si inserivano i numerosi viaggi ufficiali da lui intrapresi nonché i soggiorni a Roma dei capi di Stato europei. Si trattava, insomma, di una vera e propria “diplomazia itinerante” che coinvolgeva sì i Paesi alleati della Triplice, ma sempre con minor calore rispetto all’Inghilterra. Ciò consentiva all’Italia, per quanto fosse membro a pieno titolo della Triplice Alleanza, di recuperare, durante il primo quindicennio del regno di Vittorio Emanuele III, ampi spazi di manovra nei confronti degli Alleati proseguendo e ampliando l’avvicinamento alle potenze dell’Intesa, iniziato, ad onor del vero, già dagli ultimi governi del Re Umberto.
La scarsa volontà di Vittorio Emanuele di continuare a mantenere l’Italia all’interno della Triplice derivava dal fatto che egli continuava a considerare l’anziano imperatore austriaco Francesco Giuseppe il nemico storico dell’Italia con il quale non si poteva scendere a patti. Anzi, l’obiettivo vero dei suoi viaggi ufficiali, della sua “diplomazia itinerante”, era proprio quello di isolare l’impero austro-ungarico.
Non vi è dubbio che il riequilibrio nel sistema delle alleanze operato dal Sovrano, questa volta in un ruolo protagonista nelle politiche estera e militare del Paese, riportava in auge l’irredentismo, ora non più però monopolio della sola sinistra ma adottato anche dalle correnti nazionaliste, a cui venivano a sommarsi obiettivi nazionali strategici nazionalistici ed anche colonialistici – come meglio si vedrà nel prosieguo della trattazione, verranno a concretizzarsi proprio nel “Patto di Londra” – giustappunto come grande potenza nel contesto europeo, al pari di Francia e Inghilterra.
L’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando d’Austria il 28 giugno 1914 a Sarajevo, frutto di un complotto di serbi anarco-nazionalisti, al momento non aveva provocato un grande allarme ed era sembrato che la questione potesse risolversi diplomaticamente fra Austria e Serbia, senza gravi conseguenze. Invece, a causa dell’ultimatum austriaco, all’improvviso, quasi un mese dopo il fatto, le cose precipitarono proprio per effetto dell’automatismo delle grandi alleanze: la austro-tedesca, la franco-russa e la franco-inglese. In quei frenetici giorni di fine luglio l’Italia si dichiarava neutrale.
Il governo dell’epoca – Presidente del Consiglio era Antonio Salandra, liberale di destra, e Ministro degli Esteri, come innanzi già detto, il marchese Antonino di San Giuliano – con l’accordo del Re, ebbe la grande abilità di sfuggire al rigido automatismo delle alleanze, in forza del quale avrebbe potuto essere costretto ad entrare immediatamente in guerra a fianco deli Imperi Centrali, suoi alleati nella Triplice Alleanza sin dal 1882. L’Italia non era stata interpellata, quanto all’ultimatum, dall’alleata austrica e pertanto – si sosteneva da parte della nostra diplomazia – l’Austria era da ritenersi la sola responsabile di quanto stava facendo; peraltro, in quella situazione – si aggiungeva – non poteva neppure ravvisarsi il “casus foederis”, in quanto, dato che il trattato di alleanza aveva solo carattere difensivo, non era in atto alcuna aggressione delle Serbia contro l’Austria. Insomma, al di là delle rimostranze di Vienna e Berlino, che parlarono di tradimento, il comportamento dell’Italia era da ritenersi del tutto conforme ai trattati e comunque rientrante nei propri interessi rimanendo fuori da una guerra insensata, cosicché la propaganda dell’Intesa potè avere buon gioco.
Nel Paese stavano intanto maturando vivissimi fermenti di varia natura – dimostrazioni di piazza davanti alle ambasciate austriaca e tedesca, invocazioni per Trento e Trieste – ed anche la maggior parte della stampa si schierava contro Germania ed Austria-Ungheria; ma una decisa svolta si sarebbe avuta allorquando nell’ottobre di quell’anno, morto il Ministro degli Esteri Antonino di San Giuliano, sarebbe subentrato il nazionalista Sidney Sonnino, le cui simpatie si dirigevano verso Londra e Parigi.
In effetti, con la firma del “Trattato di Londra”, siglato il 26 aprile 1915, con le potenze dell’Intesa, un patto segreto a conoscenza solo del Re, di Salandra e di Sonnino, i quali agivano formalmente nell’ambito dei poteri attribuiti ai ministri dal decreto n. 466 del 14 novembre 1901 (Decreto Zanardelli), la responsabilità della guerra ricadeva soltanto sui due uomini politici, sebbene il Re fosse a conoscenza del Patto, pur restando arbitro imparziale. Salandra si dimetteva allorché il Re portava a conoscenza di Giolitti, capo della maggioranza parlamentare, il patto segreto, dimissioni che il Sovrano respingeva. I giolittiani votavano comunque a favore dei crediti di guerra. La guerra era dichiarata.
MIX RIVENDICATIVO E ASPIRAZIONI
In realtà, già prima dell’inizio della guerra i rapporti dell’Italia con le altre due potenze della Triplice si erano in qualche modo deteriorati, principalmente per la crisi della Bosnia-Erzegovina del 1908-1909, regione che l’Austria “amministrava” sin dal 1978 dopo il Congresso di Berlino. L’idea del governo austriaco era quello di annettersi sic et simpliciter questo territorio, teoricamente ancora appartenente all’impero turco, in modo da annientare le speranze dei nazionalisti jugoslavi. Infatti, prendendo a pretesto la “Rivoluzione dei giovani turchi”, che proprio nel mese di luglio aveva portato al governo di Costantinopoli dei riformatori modernisti, il 5 ottobre 1908 non esitava ad annettersi tutta la regione, creando così il fatto compiuto e suscitando in tal modo lo sdegno dei serbi, i quali, pertanto, si affrettavano a chiedere l’aiuto russo.
Non essendo però in grado la Russia di intervenire militarmente, ciò era per l’Austria-Ungheria un completo successo, sebbene questo rivelasse tutta la sua fragilità in quanto non solo non annientava il nazionalismo serbo, ma inaspriva anche la Russia: questa, infatti, bramosa di rivincita e dati i suoi rapporti di amicizia con l’Inghilterra, rivolgeva ancora di più le sue attenzioni verso la Triplice Intesa, rafforzandola notevolmente.
Per converso, il trionfo conseguito da sola dall’Austria a spese della Turchia, finiva per indebolire la Triplice Alleanza, dal momento che l’Italia certamente non vedeva di buon occhio la modificazione dello status quo nei Balcani a solo vantaggio dell’Austria, senza aver ottenuto, da parte sua, una qualche contropartita; questo fatto, oltretutto, veniva a rappresentare un nuovo impedimento alla sue mire espansionistiche nell’Adriatico, cosicché nel Paese incominciava nuovamente a manifestarsi una crescente passione per le tematiche irredentistiche e nazionalistiche, che, alla fine, diventeranno preponderanti dapprima nella decisione di conquistare – rispolverando appieno anche quelle colonialistiche dopo i precedenti insuccessi – la Libia a spese della Turchia, a cui viene dichiarata guerra il 29 settembre del 1911, e successivamente in quella di entrare nel conflitto mondiale al fianco di Francia e Inghilterra.
Posto che ci si è già sufficientemente dilungati sugli aneliti irredentistici, ora prepotentemente ripristinatisi, e quelli colonialistici, solo sopiti dopo Adua, di certo, la necessità del dominio dell’Adriatico – vera e propria aspirazione nazionalistica come già si diceva innanzi – abbisogna invece di qualche ulteriore riflessione che valga ad inserirla correttamente nel quadro rivendicativo per la nuova guerra, posto che la Regia Marina aveva già dimostrato le sue grandi capacità operative e le sue potenzialità durante la guerra italo-turca.
Scoppiato il conflitto e stante la neutralità italiana, l’interesse della Marina e della politica stava volgendo ad oriente e comunque contro l’Austria, tant’è che lo stesso Capo di Stato Maggiore nell’ottobre del 1914 redigeva un memorandum sulla possibilità di guerra in Adriatico contro il nemico di sempre: l’Austria. Come al tempo di Lissa, il dominio dell’Adriatico era nelle salde mani di chi possedeva la sponda orientale, potendo contare su una poderosa linea di porti naturalmente protetta dai fondali e da un susseguirsi di isole potentemente e sapientemente fortificate. In tal modo, a distanza di quasi un cinquantennio, i problemi che avevano afflitto lo sfortunato Ammiraglio Persano e i primissimi governi del neonato Regno d’Italia adesso affliggevano i vertici della nostra Regia Marina non meno che le nostre autorità politiche. Così scriveva Sidney Sonnino: “Il problema fondamentale dell’Italia è assicurarsi il predominio marittimo nell’Adriatico…il predominio assoluto nell’Adriatico è di primaria importanza, costituendo forse oggi il movente principale per accostarci all’Intesa”. Lo stesso Sonnino ancor prima di assumere l’incarico di Ministro degli Esteri nel settembre del ’14, aveva scritto, quasi profeticamente, all’allora Presidente del Consiglio Antonio Salandra “Più ci ripenso e più mi confermo l’impressione che l’occupazione di Saseno e della baia di Valona va fatta subito senza chiedere più permesso a nessuno”. Sono i due uomini politici su cui ricadrà la responsabilità della guerra!
A fine ottobre la Turchia diveniva alleata degli Imperi centrali, la Grecia due giorni dopo occupava Santi Quaranta, cosicché da lì a breve l’Italia avrebbe occupato, come previsto, Valona e l’isola di Saseno. In tutto ciò, mentre gli Imperi centrali si mantenevano prudenti per non creare ulteriori attriti nella già “effimera” alleanza, l’Intesa vedeva invece in tale occupazione una splendida opportunità per ampliare ulteriormente la già considerevole distanza tra Roma e le potenze della Triplice. In effetti, la presenza nella Triplice alleanza della Turchia, alleata sgradita all’Italia, e l’antica rivalità con l’Austria allontanavano di fatto l’Italia dalla alleanza con gli Imperi centrali.
Roma approfittava del periodo di “non intervento” nel conflitto per giocare la partita diplomatica su due tavoli, sebbene il governo italiano fosse sempre più spinto, per tutta una serie di interessi, verso l’Intesa. Di certo, allo scoppio della Grande Guerra, se l’Italia si fosse schierata fianco di Austria e Germania, va da sé che una eventuale vittoria della Triplice avrebbe comportato un deciso rafforzamento dell’Austria sul mare, tale da estromettere irrimediabilmente l’Italia dal Mar Adriatico. Insomma, all’inizio del conflitto la negoziabilità dell’intervento italiano non era più a favore degli Imperi centrali; lo era, per contro, o per il mantenimento della neutralità oppure per lo schieramento con le potenze dell’Intesa. Queste, d’altronde, a fronte delle striminzite concessioni dell’Austria circoscritte a Nizza e alla Savoia nonché ad un lembo del Trentino, per di più solo a guerra sfinita, promettevano più che generose offerte territoriali; per di più, la conduzione delle operazioni in Adriatico sarebbe stata posta sotto l’esclusivo controllo della Regia Marina dato che le marine francesi e inglesi avrebbero inviato delle navi.
Così di lì a breve sarebbe arrivato l’accordo con le Potenze dell’Intesa, il Patto di Londra, siglato il 26 aprile 1915, per la partecipazione dell’Italia al conflitto, dopo aver riesumato, dunque, le sue aspirazioni irredentistiche sui territori ancora occupati dall’Austria, vale a dire il Trentino e la Venezia Giulia, solo temporaneamente accantonate per effetto della sua adesione alla Triplice Alleanza, e dopo aver posto sul tappeto anche quelle nazionalistiche e quelle colonialistiche a spese della Germania a guerra finita.
In effetti, con la firma dell’accordo che prevedeva l’entrata in guerra dell’Italia, con modalità offensive, si concedeva il Trentino, il Tirolo Meridionale, Trieste, Gradisca e Gorizia, l’Istria fino al Quarnaro e le isole antistanti, una parte della Dalmazia e le sue isole, Valona, Saseno e il Dodecanneso, con esclusione però di Fiume, in quanto sbocco a mare dell’Ungheria o del nuovo stato Croato, e della città di Spalato; inoltre, varie acquisizioni territoriali in Africa e in Asia minore in caso di ampliamenti in quei territori da parte di Francia e Inghilterra. Insomma, un mix rivendicativo che spaziava dal Brennero all’Istria, dalla Dalmazia al controllo dell’Adriatico e al Dodecanneso, ciò che era proprio quello di una grande potenza o almeno aspirante tale, tutt’assieme irredentistico, imperialistico-colonialistico e nazionalistico, aspirazioni che, come più volte dato cenno, venivano da lontano, dallo stesso Risorgimento e dal post-Risorgimento.
LA “QUARTA GUERRA D’INDIPENDENZA”?
Delineatasi in tal modo la tracciabilità dell’intero percorso risorgimentale e postrisorgimentale in un unicum, un “fiume” via via arricchitosi di suggestive aspirazioni irredentistiche, colonialistico-imperialistiche e nazionalistiche, ai fini della collocazione del nuovo conflitto nel quadro complessivo e composito delle guerre per l’indipendenza, deve considerarsi, però, anche quanto psicologicamente veniva ad inculcarsi in una larga fetta dell’opinione pubblica e condiviso dalla maggior parte della storiografia in un solco risorgimentale “puro” – ma certamente in modo incompleto quanto agli aspetti motivazionali per l’entrata nel nuovo conflitto – circa la ideale identificazione della Prima Guerra Mondiale come una “Quarta Guerra d’Indipendenza”, in perfetta continuità con la Terza del 1866, allorquando il generale Pollio, in chiusura del suo libro su Custoza, individuava il trionfo di Vittorio Veneto come vindice della sconfitta di Custoza.
Ma siffatta ricostruzione di aggancio diretto – senza “l’intermediazione” di una più coerente rielaborazione concettuale del multiforme e composito mix causale nella sua interezza – della Guerra mondiale, come Quarta Guerra d’Indipendenza, al percorso risorgimentale e in particolare alla Terza del 1866, e del trionfo di Vittorio Veneto alla sconfitta di Custoza, ricondurrebbe il tutto solo ad un “rispolverato” esile filone irredentistico, bypassando in tal modo a piè pari tutto il travaglio postrisorgimentale, generato dal diffuso senso di malessere e di incompiutezza anche dopo la realizzazione del processo unitario, ciò che avrebbe poi trovato la stura in una più generale volontà di potenza. Invece, come si è visto, siffatto indirizzo era venuto ad integrarsi in un mix sempre più articolato di progetti colonialistico-imperialisti e nazionalisti, diventando con essi intercambiabile. Insomma, resta legittima la qualificazione della Prima Guerra Mondiale come “Quarta Guerra d’Indipendenza” soltanto a patto di ricomprendere nel suo coacervo rivendicativo interessi ed aneliti ben al di là di quelli unicamente irredentistici.
D’altra parte, qual è significato del termine indipendenza in senso lato? Sotto un primo aspetto, sicuramente quello connesso alla riunificazione del territorio nazionale mediante l’acquisizione delle terre irredente, cioè non ancora salvate, e quindi la capacità di autodeterminarsi nell’ambito del territorio nazionale. Ma, sotto un altro profilo, una grande potenza, per assicurarsi una reale indipendenza, cioè una sua incontrovertibile sovranità sopranazionale, non può tollerare né limitazioni ai suoi confini naturali né restrizioni allo sviluppo di una propria politica internazionale (casomai anche a carattere imperialistico, perché no?) come chiavi strategiche per non rendere la sua indipendenza puramente nominale.
Proprio in siffatta ottica, non vi è dubbio che la Prima Guerra Mondiale possa configurarsi a pieno titolo come “Guerra d’Indipendenza”, in quanto tesa a conseguire obiettivi nazionali strategici, sia a carattere irredentistico sia a impronta nazionalistica e imperialistica, giustappunto come grande potenza nel contesto europeo, al pari di Francia e Inghilterra.
In effetti, il suo coacervo rivendicativo – che spaziava dal Brennero, dove si aspirava a portare il confine, all’Istria, alla Dalmazia e al Dodecanneso, nonché, in chiave più prettamente colonialistica, dai possedimenti tedeschi in Africa, alla cui spartizione si sperava di partecipare, ai territori in Asia Minore a spese dell’ex impero turco – era proprio quello di una grande potenza realmente indipendente, o almeno spirante tale.
PARALLELO CON LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Mi sia consentita una digressione per meglio definire la sostanza dell’indipendenza! La guerra che iniziava il 10 giugno 1940 – con tutto il suo imponente mix rivendicativo che tendeva ad accaparrarsi l’isola di Malta e la Corsica (aspirazioni irredentistiche), Gibilterra e il controllo del Mediterraneo in mano inglesi (aspirazioni nazionalistiche), Gibuti e Suez, con mire anche sulla Tunisia (ma non erano in parte quelle stesse aspirazioni colonialistiche successive al Congresso di Berlino del 1878?) – non era pur essa in chiave irredentistica di ricomposizione del territorio nazionale, di sicurezza esterna nonché di consolidamento dell’impero coloniale a spese di Francia e Inghilterra? Allora perché quella guerra non dovrebbe essere considerata a pieno titolo, ancora di più e meglio della Prima, come la “Quinta Guerra d’Indipendenza”?
Insomma, non è possibile opporre un aprioristico rifiuto concettuale a siffatta tesi ove si consideri l’armonico e compatto filone “risorgimentale-post-risorgimentale-primo conflitto mondiale” sol perché in ossequio alla vulgata l’idea potrebbe apparire ripugnante! D’altra parte, lo storico non è titolato ad addossarsi una specie di veste sacerdotale come un giudice del tempo ideologizzando o manipolando i fatti della Storia in base ai suoi intendimenti o a seconda delle sue passioni: o meglio, come affermava Marc Bloch, “Lo storico non è un giudice degli inferi incaricato di assegnare premi e punizioni agli eroi morti”!
In definitiva, così incardinato e acquisito il concetto di una reale indipendenza, le rivendicazioni fasciste, poste sul tappeto internazionale a ridosso dell’intervento in guerra, non rappresentavano i fondamenti di una strategia complessiva – i cui obiettivi, qualitativamente identici, differivano semmai solo dal punto di vista quantitativo da quelli del primo conflitto mondiale – per portare l’Italia, a dispetto della sua impreparazione militare, a diventare una grande potenza realmente indipendente, e perché no, anche verso il ben più potente alleato germanico?
Non erano forse gli stessi obiettivi che, in un modo o nell’altro, semmai rielaborati soltanto sotto il profilo quantitativo, avevano caratterizzato in fondo tutta la storia d’Italia fin dal 1859, per proseguire poi con la Terza Guerra d’Indipendenza nel 1866, con la “Quarta” del 1915 e con le guerre coloniali del 1885, 1895, 1911 e 1935? Un crescendo rivendicativo, dunque, che estendendosi via via dalla Lombardia a tutta la Penisola italiana, con la conseguente proclamazione dell’Unità d’Italia, dal Veneto a Roma, dal Trentino alla Dalmazia, dall’Adriatico al Dodecanneso, dalla Corsica a Malta, da Gibilterra al Mar Mediterraneo, dalle conquiste coloniali del XIX secolo all’annuncio del grande impero africano nel 1936 per finire alla “Guerra parallela”, contrassegna quasi un novantennio di storia italiana e che non ci permette di condannare sic et simpliciter chicchessia, da Cavour a Crispi e a Giolitti, per finire a Mussolini, e men che mai la Corona, del resto sempre ligia ai dettami costituzionali-parlamentari.
Sgomberato quindi il campo da pregiudizi ideologici, non sembrano esservi più dubbi di sorta in ordine al fatto che la Seconda Guerra Mondiale possa configurarsi quanto la Prima, e probabilmente ancora più di questa, come la “Quinta Guerra d’Indipendenza” e, come si vedrà, anche “l’ultima”. Sicuramente “guerra fascista” di conquista (ma ciò di per sé non vale a meglio qualificarla intrinsecamente sotto il profilo contenutistico e della esegesi storica, ma tutto al più, solo sotto il profilo ideologico), questa difatti è volta a conseguire, come grande potenza e al pari delle altre, un’autonoma strategia operativa nel contesto internazionale ed un’effettiva indipendenza, intesa, a torto o a ragione, non solo in termini di ricomposizione in ambito nazionale di territori comunque ritenuti italiani, ma anche e soprattutto come capacità di attuare una sua politica estera senza dover dipendere da una o più potenze dominanti.
Ad ogni buon conto, giusto per concludere sul punto, la “Quinta Guerra d’Indipendenza”, la c.d. “Guerra parallela”, voluta dal duce in concorrenza se non proprio in contrapposizione ad Hitler, sarebbe terminata miseramente di lì a poco sul fronte greco-albanese, sulle infuocate sabbie del deserto africano, a Sidi el Barrani a soli novanta chilometri dal confine libico-egiziano, a Taranto, con la messa fuori combattimento di parte della potente flotta di guerra, e a Capo Matapan, con la perdita anche dell’Africa Orientale.
Aveva fine così il mito della “Guerra parallela” per imboccare il triste percorso della “guerra subalterna”. Con l’epilogo triste della “Quinta Guerra d’Indipendenza”, a distanza di meno di un secolo dall’avvio del percorso risorgimentale, si consumava pure l’indipendenza dell’Italia, in seguito mai più riconquistata.
Tutto quello che è venuto dopo non è stato l’evoluzione di uno Stato realmente indipendente: quello, infatti, era svanito e ormai definitivamente “sepolto”, dopo meno di un anno di guerra, nella primavera del 1941!
LA MADRE DI TUTTE LE GUERRE: INTERVENTISMOE NEUTRALISMO
Certamente la Prima Guerra Mondiale, definita “la Madre di tutte le guerre” in quanto rappresentava la nascita della moderna guerra totalitaria, è stata una sovrapposizione dei conflitti, in cui ogni potenza combatteva per un suo obiettivo particolare o aveva un conto da regolare, e il risultato dell’automatismo delle grandi alleanze ma anche dell’apparizione di due nuove potenze nella seconda metà dell’Ottocento, cioè l’Italia nel 1861 e soprattutto la Germania nel 1870, ciò che aveva alterato gli equilibri in Europa.
Ma al fine di evidenziare aspetti connessi alla mitologia della “Grande Guerra” occorre svolgere alcune considerazioni preliminari in ordine agli elementi conflittuali, ciò che sin da allora mettevano in crisi la società italiana, connessi alla dicotomica contrapposizione tra neutralismo, che trovava suo terreno fertile nel pacifismo, nell’internazionalismo e nell’antimilitarismo, vale a dire nell’eredità giusnaturalistica del socialismo, e interventismo, in cui dominavano stati d’animo e aspirazioni diverse, quali ampliamento di obiettivi di politica estera, politiche di potenza, liberazione terre irredente, ecc., ma anche fermenti irrazionalistici, volontaristici ed anche decadentistici: comunque un coacervo di valori empirici che, in un modo o nell’altro, assegnavano in ogni caso un posto privilegiato al concetto di patria.
Interventisti erano il Governo, allora presieduto da Antonio Salandra, Luigi Albertini, i socialisti riformisti (Leonida Bissolati e Gaetano Salvemini) i quali intendevano affermare il principio di nazionalità sulle rovine dei due imperi autoritari, i nazionalisti, Mussolini, il quale, abbandonato il partito socialista si proponeva di realizzare un suo disegno rivoluzionario, una parte del mondo cattolico e un’ampia fascia della borghesia benpensante, animate da un generico ideale patriottico, ora rafforzato dal progetto di ricongiungimento alla patria delle terre irredente.
Comunque, uno spirito di incontenibile entusiasmo patriottico-bellicista investiva non solo l’Italia, in cui le piazze ribollivano e specialmente a Roma, bensì tutto il continente europeo, quasi senza distinzione di ceto e di età, di élite e di massa. Saranno poco efficaci, specie in Francia, in Germania e in Austro-Ungheria, gli argini di carattere politico religioso o sindacale frapposti alla trascinante forza degli umori collettivi.
In Italia le dimostrazioni di piazza si intensificano nel mese di maggio, proprio mentre le truppe degli Imperi centrali trionfavano in polonia e in Galizia. Ed anche la stampa non mostrava alcun dubbio per questa guerra che doveva completare l’unità nazionale rimasta in sospeso nel 1866.
Di certo, nei fermenti irrazionalistici veniva a coagularsi in maniera indistinta la prima grande rivolta populista contro le istituzioni liberali, così come si erano venute formando e consolidando dal 1871 al 1915, inquietudini che erano espressione di un’avversione per la così detta Italietta e per l’uomo che di essa era il principale rappresentante, Giovanni Giolitti.
In siffatte aspirazioni emergeva un primato del fare o un dissolvimento del pensiero nell’azione, un irrazionalismo attivistico contro il quale, per esempio, Benedetto Croce reagiva; infatti, vedeva simboleggiato questo irrazionalismo attivistico soprattutto in Gabriele D’Annunzio e lo riduceva ad un momento del decadentismo europeo, un decadentismo che dalla sfera estetica passava direttamente nella vita morale, instaurando così una confusa brama del nuovo.
MITO ED EROISMO NELLA GRANDE GUERRA
Prendeva sempre più piede, dunque, il mito della Guerra, che si fondava su vari elementi: patriottismo, ricerca di uno scopo nella vita, amore di avventura e ideali di virilità, tutti fattori che segnavano lo spirito guerriero dei giovani, che poi costituiranno le folte schiere dei volontari, in un clima di effervescenti movimenti e correnti in campo artistico e letterario che non mancavano di sottolineare il mutamento a cui si stava assistendo. Tra essi spiccava il Futurismo, il quale, esaltando una virilità militare che glorificava la conquista e la guerra e sostituendo il movimento violento all’immobilità del pensiero, denotava tutti gli aspetti della guerra in modo positivo. Proprio l’esaltazione della guerra, come desiderio ardente dello straordinario, diviene una decisa forma di opposizione ad una società pietrificata. Tutti questi sentimenti dei futuristi finiranno dunque per incanalarsi nel nazionalismo e la figura idealizzata del soldato comune diverrà una componente essenziale alla creazione del mito di un uomo nuovo che avrebbe redento la nazione, un mito che confluiva in quello dello Stato nuovo, in un processo di formazione di una coscienza politica estesa che può definirsi come “radicalismo” di tradizione mazziniana.
In definitiva, l’occasione dell’evento bellico segnava il fondamentale passaggio dall’idea all’azione nella prospettiva dello Stato nuovo, ereditato e poi fatto proprio dal movimento fascista. Come afferma Emilio Gentile, il fascismo fu, “un movimento collettivo di giovani che si erano formati nella brutalizzante esperienza della guerra…che assimilò i temi del radicalismo nazionale integrandoli con i miti dell’interventismo, del trincerismo e del combattentismo”.
Mai come nella Grande Guerra il mito ha svolto una funzione importante nella presa di una forte coscienza politica delle masse, talché esso ha finito per perdere i tipici tratti politico-sociali per fondere la sua identità con il concetto di eroismo.
Molti alti ufficiali, persino generali, avevano il merito di stare a stretto contatto con i soldati, di trovarsi con loro in trincea, di incoraggiare gli uomini e di fare in modo che fossero evitate inutili perdite. Il generale veniva dunque innalzato a mito e la prima linea diventava il punto di contato tra il soldato-massa e il generale-eroe. Appunto in questo modo l’eroismo, amplificato, diventava mito.
In tale ottica, generalizzando, l’esaltazione della guerra, di quella guerra, in cui spesso viene ad essere superato quel flebile confine che separa gli obblighi del soldato dai gesti di eroismo, diventava essa stessa esperienza caratterizzante e formativa per le generazioni e la Patria future. In siffatto quadro, ogni gesto di sacro dovere superava qualsiasi valore e ogni soldato della prima guerra mondiale morto per la patria diventava un vero eroe.
Cosicché mito ed eroismo finivano per confluire in un processo edificatore, quasi purificatore, per il popolo e per la politica italiana, un processo teso alla costruzione di un ideale supremo: un percorso politicizzato, basato su ideali come Patria, Nazione e Stato, a cui si affiancava un processo morale che aveva come elemento unificante l’esempio supremo incarnato da soldati e condottieri della guerra: in siffatto contesto, quasi “mistico”, mitico ed eroico assieme, si colloca anche il mito del Milite Ignoto, un semplice militare italiano caduto sul fronte della Grande Guerra e sepolto sotto la statua della dea Roma all’Altare della Patria al Vittoriano, la cui tomba simboleggia tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Di certo, i traumi, le fratture che la nostra storia ha conosciuto dalla Grande Guerra ad oggi sono stati troppi per mantenere un ininterrotto percorso identitario.
Innanzitutto il trauma di un’altra guerra mondiale a distanza di venticinque anni dalla prima, a seguito della quale, dopo il 1943-45, i meccanismi di legittimazione, i vincoli simbolici e ideologici che duravano dal 1861 ebbero per lo più a dissolversi.
Allora qualcosa di simile alla morte si è verificato poiché una Patria senz’altro morì. Morì il patriottismo della Nazione, sostituito dal patriottismo di partito o dal patriottismo di classe come l’unico vincolo della comunità politica nazionale. Caduto nella polvere, assieme al fascismo, il concetto stesso di nazione, la legittimazione democratica, dunque, non poteva che provenire se non dai partiti, soprattutto quelli più fortemente ideologizzati.
Un altro grande momento di rottura che separa enormemente l’Italia attuale dalla Grande Guerra è stato l’avvento di ordinamenti politici di tipo democratico così come sanciti dalla Costituzione attuale, pur essa nata tra equivoci e contraddizioni profonde, una rivoluzione culturale che ha definitivamente rimosso, al di là di patetiche formali rappresentazioni di facciata, l’identità sociale e culturale della vecchia Italia che combatté la Grande Guerra.
E’ proprio la rottura del rapporto storico con lo Stato unitario in conseguenza della sconfitta del ’40-45, unita all’avvento della democrazia repubblicana, dunque, che ha reso l’odierna identità italiana qualcosa di difficilmente comparabile con quella dell’Italia della Grande Guerra, che in tal modo non costituisce più il suo piedistallo emotivo e mitologico. Insomma, in Italia è abortito, a differenza di altre nazioni più coese anche ideologicamente, il passaggio cruciale tra liberalismo e democrazia che il conflitto mondiale aveva messo dappertutto all’ordine del giorno.
Con siffatti presupposti, sicuramente la Nazione è morta nel cuore degli italiani, è morta l’idea stessa di Nazione e con essa anche quella di Patria. Una nazione incompiuta, una nazione mancata, uno Stato-non nazione, un Paese che, per le sue inadeguatezze, non è riuscito a farsi nazione e che sconta ancora oggi, le sue tradizionali lacerazioni: una divisività che viene da lontano, dagli antefatti stessi della Grande Guerra. Una disunione che, oltre a riferirsi ad una dimensione ideologico-politica, tende a presentarsi quasi come sistemica, strutturale, a carattere antropologico e culturale e perfino morale.
Un Paese, dunque, con un colossale difetto di coscienza politica, un Paese caratterizzato dalla “lontananza” del popolo dallo Stato, un Paese in cui è troppo labile, se non proprio inesistente, il legame di appartenenza del popolo verso una ancora “mal conosciuta Patria”: un popolo a cui ben si attaglia l’affermazione gobettiana “Il nostro vero dramma consiste nel fatto che non possiamo essere un piccolo popolo e non sappiamo essere un grande popolo”. Aggiungo solo che non lo siamo stati quando avremmo potuto esserlo, ora non possiamo più esserlo nel nostro ineluttabile declino di popolo e di nazione.
In tema di “unità-disunità” nazionale s’impone a questo punto qualche ulteriore riflessione che, senza “arrières pensée”, riposizioni più correttamente, in termini concettuali, il ruolo della Monarchia sabauda in un possibile processo coesivo nazionale. In altri termini, avrebbe potuto questa, ove fosse rimasta al timone istituzionale del Paese, evitare lo sfaldamento dello Stato in quanto titolare della custodia dell’unità e dell’unicità dell’autorità statale al di là e al di sopra dei mutamenti di governo e di indirizzo politico, così come del resto durante il regime aveva comunque rappresentato la continuità storica rimanendo la garante della nazione?
In altri termini, avrebbe potuto la Corona costituire un argine al fenomeno di ideologizzazione e frammentazione partitica di una “stracciata” Repubblica “tirata” da ogni dove – una Repubblica che non affonda le sue radici né nel Risorgimento né nella Grande Guerra bensì di qualcos’altro di estremamente divisivo – e così continuare a fungere da fondamento di una conservata identità unitaria degli italiani? E’ certamente più che lecito dubitarne, ma non è legittimo non chiederselo almeno!
E profondamente vero comunque che quell’acquisto dell’unità intorno alla Patria italiana, che, superando la disperazione di Caporetto, si fondava sulla resistenza sul Grappa e sul Piave fino alla vittoria, è andato del tutto perduto, cosicché la “morte della Patria” in questa striminzita, asfittica Repubblica – una Repubblica con la sua strana democrazia, sulla quale è scesa una evanescente ombra lunatica e in cui anche i caduti sono diventati solo stracci senza memoria ingoiati dall’oblio – è rimasta la grande questione irrisolta del nostro vivere collettivo.
Si chiude così un loop, tragico e grottesco allo stesso tempo, una riflessione a struttura circolare, così come nel film Pulp fiction di Quentin Tarantino, con l’inizio di questo tragico excursus che si ricongiunge alla sua fine! Una pericolosa deriva ed una tangibile prospettiva di una moderna e irreversibile disunità nazionale, a distanza di oltre un secolo e mezzo dal compimento della sua unità politica e dopo avere combattuto ben cinque guerre d’Indipendenza: sono trascorsi cosi, in modo deteriore e come se nulla fosse avvenuto, altri ottant’anni dall’ultima di esse!
BIBLIOGAFIA ESSENZIALE
- ACQUARONE, L’età giolittiana, Bologna, Il Mulino, 1988.
- BELLAVIITA, La battaglia di Adua, Rimini, Rusconi, 2012.
- CHABOD, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Bari, Laterza, 1976.
L.M. CHASSIN, Storia militare della seconda guerra mondiale, Firenze, Sansoni, 1971.
- CROCE, Storia d’Italia dal 1870 al 1915, Milano, Adelphi, 1991.
- B. DUROSELLE, l’Europa da 1815 ai giorni nostri, Milano, Mursia, 1974.
- FALDELLA, l’Italia e la seconda guerra mondiale, Bologna, Cappelli, 1967.
- FERRANTE, La Marina e la Diplomazia in Italia dall’unificazione nazionale alla Grande Guerra, in “Bollettino d’Archivio dell’Ufficio Storico”, Roma, dicembre 2005.
- A. L. FISHER, Storia d’Europa, Tomo II, Dall’età dell’assolutismo all’epoca dei totalitarismi, Roma, Newton Compton, 1995.
- FREDIANI, Le guerre dell’Italia unita, Roma, Newton Compton, 1995.
- A. HOBSON, L’imperialismo, Roma, Newton Compton, 1996.
- ISNENGHI, La prima guerra mondiale, Bologna, Zanichelli, 1972.
- IVALDI, Storia del colonialismo, Roma, Newton Compton, 1997.
- JACHINO, La campagna navale di Lissa1866, Milano, Il Saggiatore, 1966.
- MACK SMITH, Storia d’Italia1861-1869, Bari, Laterza, 1972.
- MALNATI, Difendo l’Italia, Rimini, il Cerchio, 2008.
- MELOGRANI, Storia politica della grande guerra, Bari, Laterza, 1969.
- PETRIGNANI, Neutralità e alleanza. Le scelte di politica estera dell’Italia dopo l’Unità, Bologna, Il Mulino, 1987.
- PIERI, Storia Militare del Risorgimento, Torino, Einaudi, 1962.
- RENOUVIN, La première guerre mondiale, Presses Universitaires de France, 1993, traduz. M. G. Saulini.
- ROMANELLI, l’Italia liberale (1861-1900), Bologna, Il Mulino, 1979.
- ROMEO, Il giudizio storico sul Risorgimento, II edizione, Catania, 1987.
- SALIMBENI, Storia, linguistica e politica nell’Adriatico orientale dalla fine dell’800 al 1954, in Storia del ‘900 nell’area dell’Adriatico orientale, Trieste, 2001.
- SCHETTINI, Nascita di una nazione, Roma, Newton Compton, 1996.
- A. THAYLER, L’Italia e la Grande Guerra. Politica e cultura dal 1870 al 1915, Firenze, Vallecchi, 1973.
- TOMASSINI, L’Italia nella grande guerra, Milano, Fenice 2000, 1995.
Francesco Giannubilo, laurea Scienze Politiche ed ex dirigente della P.A., si occupa di studi storico-politici dell’età contemporanea. Pubblicista su testate provinciali e su “l’Opinione delle Libertà” nazionale, dopo la ricerca “Aspetti della politica italiana 1920-1940” (2013), il saggio “DALLA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA ALLA DEMOCRAZIA LIQUIDA (O LIQUEFATTA?)” (2015).
Ha pubblicato: “L’ITALIA CHE (NON) CAMBIA (2010), assieme di considerazioni etico – politiche sull’impossibilità del riformismo in Italia; “1848-1870 IL RISORGIMENTO INCOMPIUTO” (2011), una riflessione sullo sviluppo storico in Italia in termini di continuità con il processo risorgimentale; “1939-1940 IL MONDO CATTOLICO ALLA SUA SVOLTA?” (2012), un profilo critico sugli atteggiamenti del mondo cattolico dagli inizi del Novecento fino all’entrata in guerra dell’Italia.