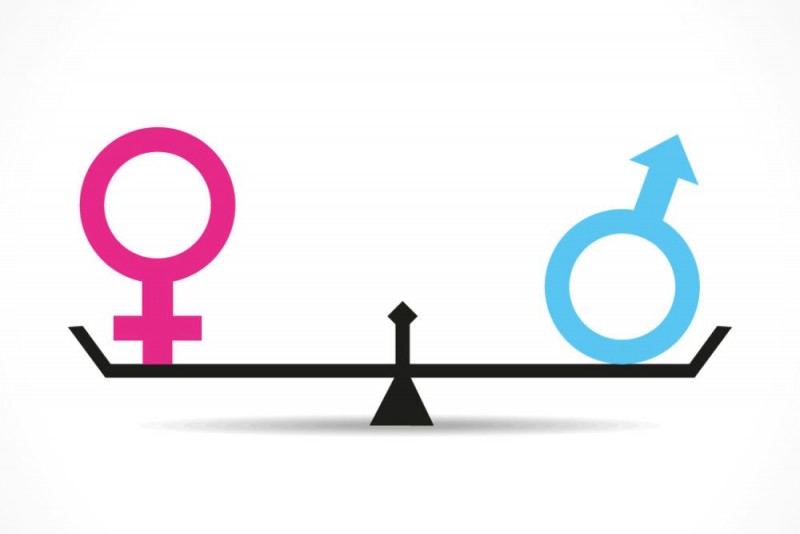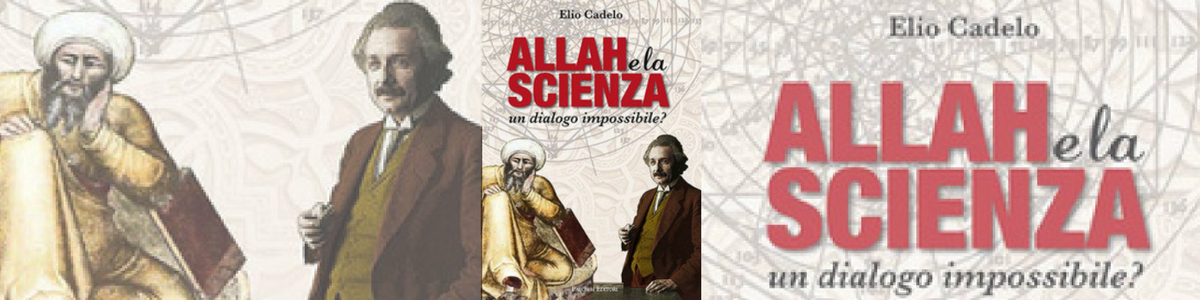La notizia è del primo giorno del nuovo anno. In migliaia le donne indiane hanno sfilato a formare una catena umana, per oltre 600 chilometri. È avvenuto nello Stato del Kerala e il gesto ha un sottotitolo che sa di resistenza: “a sostegno dell’uguaglianza di genere“.
Ma resistere a cosa? Si è trattato di un segnale tangibile, partito appena dopo una sentenza storica della Corte Suprema. I giudici hanno decretato la fine – per le donne tra i 10 e i 50 anni, considerate “impure” – di un divieto antico che impediva loro di entrare nel tempio Sabarimala, luogo sacro agli indù.
Una decisione certamente rivoluzionaria, contro cui si sono subito schierati i religiosi, in un paese – l’India – che è tristemente noto per far registrare il più alto numero di spose bambine, con il 47% di ragazzine costrette a matrimoni forzati prima di avere compiuto i 18 anni e molte addirittura prima dei 10. I dati elaborati e resi noti da Save the children sono agghiaccianti.
La reazione degli integralisti è stata violenta, scontri e proteste hanno infuocato molte città della regione. L’accesso al tempio di due delle manifestanti è durato pochi minuti e ha indotto l’autorità religiosa a disporre la chiusura del luogo sacro, per un “rituale di purificazione”, immediatamente dopo aver preteso l’allontanamento delle fedeli.
Il 2019 inizia adesso, dunque. Davanti a noi mille sfide; per i liberali, come per chi si sente meglio rappresentato da ideologie che tradizione e cuore collocano altrove, in questi giorni la riflessione la detta l’agenda. Ci siamo chiesti cosa stessimo lasciando con l’anno che si è chiuso; da oggi dobbiamo chiederci cosa vogliamo da quello che è appena entrato.
Le battaglie di civiltà sono terreno aperto, sconfinato. I diritti civili e le libertà sono esigenze che si coniugano insieme, senza separazione. Il pensiero va in quella direzione. Non c’è solo l’India.
Per le donne non è stato facile pretendere parità e continua a non esserlo, anche in Italia. E se troppo spesso questo è terreno di scontro, in realtà è argine che ci rappresenta tutte, luogo che dovremmo sentirci chiamate a indagare e a cercare di seminare.
La sfida al momento è di sopravvivenza. La cronaca dice che bisogna che le donne combattano con consapevolezza, una guerra che le sta uccidendo. Il femminismo, in un’accezione che ai più fa storcere il naso, è ciò che evoca un discorso simile; l’eccezione è delle più prevedibili.
Ma i numeri sono dati e sono fatti. Una vittima ogni due giorni, uccisa dal partner o ex partner; sono oltre un centinaio i femminicidi nel 2018. Il termine per molti è persino scelta linguistica stucchevole e inutile. Diversamente, è necessità di piegare le parole all’urgenza di raccontare un fatto, antico quanto il mondo.
Ma allargando la lente, l’inquadratura è più ampia e include più scene. Basta però non perdere il fuoco e la nitidezza che è nettezza, certezza dei contorni.
Il tema del contrasto alla violenza di genere passa ad esempio, come ogni altro, attraverso piani di lettura molteplici. Quello delle parole e del linguaggio, innanzitutto, che è in fondo traduzione del pensiero. E allora si ritorna all’esempio di quel neologismo, scelto per descrivere più di un omicidio quando la vittima è una donna; un termine in grado di dare conto tanto del sesso degli attori di quella scena del crimine, quanto del movente. Potrebbe citarsi, alla stessa stregua, l’antica querelle sull’uso non sessista della lingua, fronte tuttora assolutamente aperto.
Fermarsi a riflettere, allora, potrebbe essere necessario; serve oggi più che mai, in un mondo che è interconnesso, peraltro in maniera ossessiva e ininterrotta. È esercizio utile per allenare i sensi all’ascolto critico e arrivare a rintracciarlo, quel pensiero, finalmente al di là dell’espressione. Bisogna sperimentarsi, in un’operazione che strati di reale sedimentatisi negli anni e impastati ad altrettante verità che potremmo definire “usa e getta” hanno reso complessa e a tratti infruttuosa.
Ma pensare è attività del mondo di oggi?
Un passo più in là lo fa Massimo Recalcati, quando interrogandosi sui limiti e sulla spinta al loro trascendimento, si chiede se il nostro tempo abbia davvero ridotto il pensiero a un mero tabù. Il ragionamento è interessante perché attuale, quando prova a spiegare la violenza. “Quello che più conta oggi non è tanto il pensare quanto l’agire – teorizza lo psicoanalista, in un interessante saggio per Einaudi – Sembra un’evidenza: non è il pensiero a essere la virtù più celebrata, quanto l’agire. Ma quando l’azione si stacca dal pensiero tende ad assumere la forma di un passaggio all’atto, ovvero di una scarica all’esterno di quelle tensioni interne che la vita non riesce a tollerare. Non è forse quello un modello che aiuta a comprendere la spirale di violenza che ci circonda?”.
La domanda aleggia attorno a noi, figli di un presente fatto di forti contrasti, spesso cruenti, e dai contorni sempre più liquidi. Ecco che, talvolta, la risposta può arrivare dall’analisi. Quando “anziché elaborare i conflitti che attraversano la nostra vita individuale e collettiva passiamo a evacuarli direttamente nella realtà attraverso l’atto cruento”, assistiamo alla via breve della violenza che tenta di sostituire la via lunga del pensiero. Quello esige tempo, l’azione no.
“Dovunque l’uomo evita di essere toccato da ciò che gli è estraneo”. Entra in gioco un fattore di stallo. Bisognerebbe creare ponti e non muri e, questo, è concetto inconfutabile. I conti si devono fare con la paura. L’ansia che l’altro travalichi i nostri confini completa il quadro, facendo di noi singoli uomini e singole donne, in perfetta solitudine davanti alle proprie battaglie. Soli e troppo spesso in preda a emozioni che non sappiamo penetrare, senza che degenerino in panico che, poi, nemmeno gli artifici della mente o quelli della materia sanno sedare.
Ma alla base del disagio cosa c’è? Se i tabù ci frenano, dovremmo chiederci qual è il nervo scoperto. Se ciascuno di noi provasse a dare una risposta, si potrebbe anche scoprire che il tasto dolente ha a che fare con la libertà. La libertà di essere che è poi, inevitabilmente, anche libertà di dire ciò che si è. Vale per le donne, da millenni certo, ma in fondo non vale solo per loro.
Ecco che nel mio primo contributo alla Fondazione Luigi Einaudi, la riflessione su pensiero, azione e infine libertà segue un percorso che magari sorprende. E attraversa il tempo, finendo per far grumo attorno alla storia di Jan Palach.
È di questi giorni, infatti, l’annuncio che la FLE avvia un progetto che è commemorazione, 50 anni dopo. Al centro c’è il giovane studente il cui sacrificio è simbolo di lotta a ogni forma di repressione. Lo strumento prescelto è quello di un tavolo di studio, il 18 e 19 gennaio, e – a chiudere i lavori – la deposizione di una corona in Piazza San Vencesla, nel giorno dell’anniversario che è quello del suicidio, avvenuto a Praga nel 1969.
Segnatamente, su quei fatti molto si è scritto. Molto si è elaborato, fino a una lettura estrema che ha persino reso il giovane praghese una delle icone dell’anticomunismo ceco. La traslazione, compiuta sugli altari dell’estrema destra europea, ha poi finito per snaturare quel gesto, del quale se un tratto rimane – al di là del colore e dell’ideologia – è il suo mostrarsi profondamente umano. Per dirla con Recalcati, è gesto che rompe ogni argine e ogni tabù, e insieme ogni senso umano del limite.
L’intento della Fondazione è chiaro: bisogna riaccendere quella torcia. E allora decidiamoci a illuminare, ancora una volta, il concetto stesso di libertà nella declinazione di Jan Palach, in quella di Benedetto Croce, come in quella delle femministe.
Per ritornare alle donne di ogni continente, in Italia come in India, l’urgenza è che ci si impegni tutte (e tutti), in uno sforzo quotidiano. Perché l’ansia di essere libere è anelito a cui, proprio noi, non possiamo e non dobbiamo rinunciare.