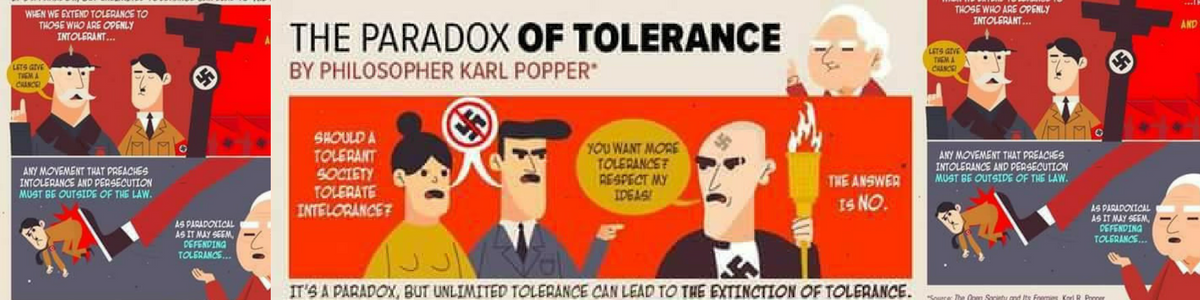L’espressione “giustizia sociale” è tanto pervasiva quanto si presta a molteplici usi (e abusi). Sotto tale ombrello, infatti, è possibile farci stare un po’ tutto: un rimedio per ingiustizie e diseguaglianze economiche, discriminazioni di genere, di appartenenza razziale e financo violazioni della dignità della propria religione. Insomma, qualsiasi presunto torto subito da un individuo, ma ancor più da un gruppo, in nome della giustizia sociale si invoca l’intervento di un’autorità volta a redimerlo, andando così incontro alla lesione della classica idea di giustizia come possesso della propria legittima proprietà. Per dirla con Kenneth Minogue, «la classica definizione di giustizia “dare a ciascuno ciò che gli è dovuto” si riferisce in termini giuridici alla proprietà. Ma estendendo il significato della parola “dovuto”, la formula può diventare, sotto l’etichetta di giustizia sociale, la base per qualunque forma di redistribuzione, secondo i principi di equità che più aggradano all’oratore. Nella maggior parte di questi significati derivativi – continua il teorico politico neozelandese – l’espressione giustizia sociale è dunque l’esatto contrario del significato elementare di giustizia. I termini che si prestano così facilmente all’auto-contraddizione sono meravigliosi strumenti di retorica».
Com’è noto, il dibattito su tale etichetta non è nuovo a livello accademico. John Rawls, pubblicando nel 1971 A Theory of Justice, ha dato inizio – o forse ha solo sistematizzato un pensiero radicato ma non ben strutturato – a quelle pretese di gruppi, più che di individui, ad aver diritto a riparazioni di origine primariamente economica. Col cosiddetto “principio di differenza”, infatti, si sarebbe legittimato l’interventismo statale per riparare le ingiustizie economiche ai danni dei più svantaggiati. In poche parole, il welfare state si affermava con forza prorompente. Qualche anno dopo, nel 1974, a Robert Nozick spettò la replica con Anarchy, State, and Utopia. In buona sostanza, i principi universalmente ritenuti giusti e razionali, giacché scelti da tutti sotto un “velo d’ignoranza”, comportano il fatto che si voglia modellare il risultato finale del “gioco” cooperativo: ogni esito della cooperazione sociale cozzerà coi principi di giustizia e, quindi, argomenta Nozick, si dovrà continuamente intervenire per appianare le ingiustizie create.
Oggi, scrive Alberto Mingardi in Contro la tribù. Hayek, la giustizia sociale e i sentieri di montagna (Marsilio 2020), il campo di applicazione delle riparazioni considerate come dovute, poiché violano i principi di giustizia fondamentali, sono andate sempre più allargandosi. Lo scienziato sociale austriaco al centro del volume, nota Mingardi, s’inserisce in tale dibattitto solo di lato e in modo particolare. Non va dimenticato infatti che egli era un economista e solo nel prosieguo della sua attività accademica virerà sulla teoria politica (cui approderà soprattutto con la pubblicazione di The Constitution of Liberty, nel 1960). Hayek cercava di capire cosa si celasse dietro una tale espressione, quali mentalità ad essa era sottesa e cosa ciò causasse poi nel concreto. Alla fine, giungerà a dire Hayek in Law, Legislation and Liberty (1982, volume unico sebbene composto da tre volumi originariamente usciti nel 1973, 1976 e 1979) giustizia sociale è un’espressione «del tutto vuota e senza significato». In una società libera in cui ciascuno cerca di migliorare la propria condizione e vige il processo di mercato, giusta o ingiusta può essere considerata l’azione di un individuo ma non l’esito del processo che deriva da un fitto e imperscrutabile intreccio di azioni individuali.
L’idea che il mercato ponga in essere esiti ingiusti, diseguaglianze insopportabilmente sbagliate deriva dal fatto che si ritiene vi sia qualcuno responsabile di un siffatto risultato – per non parlare dell’atavismo che vuole la cooperazione sociale come un gioco a somma zero. Alla base di ciò vi è lo stesso errore costruttivistico secondo cui qualcuno è in grado di riportare le lancette dell’orologio indietro al fine di riparare i danni subiti da questo o quel gruppo. Una sorta di presunzione razionalistica, nutrita da un “individualismo falso” per dirla con Hayek, secondo cui dietro a ogni evento, fatto o conseguenza vi è sempre qualcuno che l’ha scientemente pensato e posto in essere. Epperò, ci ricorda Hayek, la realtà sociale è complessa. Essa è costituita da molteplici istituzioni che sono il frutto dell’evoluzione tendenzialmente spontanea. Al pari dell’organismo umano, le società sono evolute secondo una legge che, per riprendere Herbert Spencer – di cui Mingardi è un fine studioso e di cui fruisce copiosamente: si rammarica, tuttavia, del fatto che Hayek, in merito al concetto di evoluzione delle istituzioni e delle norme sociali, non vi abbia fatto ricorso, pur forti le consonanze con i moralisti scozzesi, forse per lo stigma di darwinista sociale –, caratterizza qualsiasi progresso: «la legge del progresso organico». La società in cui viviamo è l’ennesima creazione di molteplici cambiamenti evolutivi, che hanno visto il passaggio da società idealtipicamente “militari”, gerarchiche, corporative, statiche, a conoscenza centralizzata e facenti capo a un telos imposto dall’alto, a quelle “industriali”, ovvero ordini aperti, nati per evoluzione spontanea dal basso, pluralistici e policentrici, caratterizzati da alta divisione del lavoro e conoscenza, nonché basati su norme astratte: per riprendere la terminologia che Hayek prese a prestito da Michael Oakeshott, i primi possono essere definiti come ordinamenti “teleocratici”, mentre i secondi come ordini “nomocratici”.
Il mercato, sostiene Hayek, dà vita a risultati che sono solo marginalmente meritocratici: il caso gioca il ruolo preponderante. E così, se un’economia aperta crea disordine e caos, giacché non vive di esiti certi e dati una volta per tutte, ma solo di regole giuridiche impersonali e astratte, la tentazione, innata in qualche modo, di aspettarsi – poco importa che sia una mera illusione: ciò che conta è credere che possa inverarsi un tale desiderio – qualcosa di ben definito e dotato di contorni netti e immediatamente percepibili crea le condizioni per rigurgiti corporativi, che rinviano a ordinamenti tipicamente chiusi. La critica alla giustizia sociale operata dall’allievo di Mises, scrive lo storico del pensiero, «è in realtà soprattutto l’identificazione di uno straordinario e diffusissimo errore cognitivo». L’idea è che un’economia di mercato è «un mondo innaturale, ingiusto, inumano, che deve essere superato» per recuperare quel senso di certezza e controllo che, però, solo un ordinamento statico, a carattere corporativo e pure gerarchico può (ingannevolmente) dare. Come sosterrà poi Hayek in The Fatal Conceit (1988), «se la civiltà è il risultato di cambiamenti graduali e non voluti nella moralità, allora, per quanto si possa essere riluttanti ad accettarlo, nessun sistema universale valido di etica può essere da noi conosciuto».
«Le invocazioni alla giustizia sociale si spiegano così. Si cerca, attraverso una determinazione di premi e punizioni estranea al gioco del mercato, di compensare il ruolo che il caso gioca nelle vicende umane», asserisce Mingardi. Si anela, in altre parole, ad emendare la lotteria naturale che vede tutti coinvolti sulla base di principi che di volta in volta possono essere rivisti, aggiornati, ampliati: ogni rivendicazione che va in tal senso implica un intervento arbitrario che lede la certezza del diritto, manomette il processo di mercato, inibendo così i prerequisiti della cooperazione volontaria che crea ricchezza. Le norme impersonali di cui una Grande società necessita servono a tenere a bada quegli istinti morali innati che hanno visto svilupparsi l’uomo nel piccolo gruppo. Ripristinare norme non valide erga omnes ma mutevoli a piacimento serve esattamente a trasformare «la democrazia in un ordinamento teleocratico», per citare Raimondo Cubeddu.
A ben vedere, alla fine, un tale mentalità tribale serve a ripristinare quel potere nelle mani di pochi che così tanto ha nuociuto alla libertà di tutti. Il benessere e la felicità, che dipendono dalla possibilità di ciascuno di liberamente realizzarsi, tornano ad essere privilegi che i decisori politici dispensano in cambio di consenso a questo o quel gruppo. «Per Hayek – scrive lo storico del pensiero – la giustizia sociale è un’invocazione che sottende la nostalgia della tribù: di una società organica, dove tutto stava al suo posto, libera dalla difficoltà, dalla delusioni, dalla paure del cambiamento». Hayek, ricorda Mingardi, non ha mai nascosto quanto perigliosa e irta di ostacoli fosse la via verso la libertà (un cosmos, per dirla con l’Austriaco), quasi un sentiero di montagna, lentamente sedimentatosi, ma soggetto a essere ora dimenticato dalle persone, ora consumato dalle intemperie. Molto più facile da prendere è l’autostrada che porta alla schiavitù (una taxis): essa distrugge quel poco di progresso fin qui raggiunto, mediante quel razionalismo costruttivistico che alimenta la «fallacia animistica» descritta dall’economista Thomas Sowell.
Le buone idee ancora una volta sono essenziali per la precaria tenuta della società libera, intrinsecamente fragile: «idee sbagliate di ciò che è razionale, giusto e buono possono cambiare i fatti e le circostanze in cui viviamo; esse possono distruggere, forse per sempre, non soltanto gli individui evoluti, gli edifici, l’arte e le città (che noi sappiamo da lungo tempo essere vulnerabili ai poteri distruttivi di morali e di ideologie di vario tipo), ma anche le tradizioni, le istituzioni e le interrelazioni senza le quali tali creazioni non sarebbero potute venire alla luce», ammoniva Hayek in The Fatal Conceit.
(Pubblicato su “Istituto di Politica”, 14/12/2020)
Carlo Marsonet, PhD candidate in “Politics: History, Theory, Science”, Luiss Guido Carli, Roma
PhD candidate, Luiss Guido Carli, Roma. Tra gli interessi di ricerca: populismo, rapporto liberalismo/democrazia, pensiero liberale classico