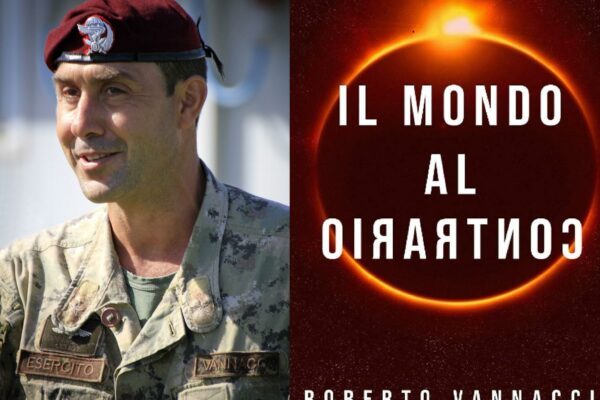Aver-cura come accarezzamento dell’assenza tra me e l’Altro
Parlare della dinamica del vuoto nella filosofia heideggeriana equivale a scoperchiare il vaso di Pandora: così come in Esiodo[1], questo, starebbe a rappresentare, aperto, l’imperversare nel mondo dei mali — e del male in-sé nella sua più tragica e peccaminosa interezza — portando però l’uomo ad essere autentico in quanto composito tanto da letizia quanto da tristezza, così in Heidegger, apertolo, portando alla luce il vuoto, l’«assenza», fonda l’interezza «autentica» dell’essere. Se, per un certo approccio filosofico tipicamente ellenico[2], il vuoto avrebbe dovuto essere ripudiato ed anzi aborrito, in Heidegger è proprio quest’ultimo — che contrappasso! — a renderci conto della realtà nella sua più fulgida e veritiera effigie.
Il grande problema della filosofia heideggeriana è, infatti, quello di ricontestualizzare il senso dell’essere nell’ottica di un Occidente che, secondo Heidegger, stava continuamente confondendone l’essenza, fondendola alla bene e meglio con l’ente: non c’era, difatti, alcuna differenza ontologica — parlare dell’ente stava diventando sinonimico di parlare dell’essere-in-quanto-tale; per Heidegger, questo è assolutamente inammissibile: è necessario che i due vengano riposizionati e rivisti attraverso un’analisi che li renda evidenti, chiari e, soprattutto, distinti. Così, con il più teoretico dei saporiti retrogusti che avrebbero potuto essere dati ad una speculazione filosofica, in Sein und Zeit[3] (1927) — l’opera unanimemente considerata fondamentale del pensiero heideggeriano, si tenta proprio questo; il risultato è un lavoro mastodontico il quale, grazie ad un fraseggio serrato ed una lessicologia istericamente oculata, ripenserà l’essere-in-quanto-tale e, attraverso questo, contestualizzerà entro un perimetro limpidamente definito quella che è la condizione esistenziale dell’uomo. Diventa, poi, quasi indessicale rispetto alla stessa coerenza strutturale del sistema teoretico heideggeriano, evidenziare come l’opera che stiamo prendendo in considerazione sia inconclusa: così come per Heidegger — e stiamo per vederlo, l’essere non avrebbe che potuto essere compreso solo attraverso l’assenza, così la sua opera, in quanto assente di una parte (una cospicua, direi, parte), è da un lato esteticamente armoniosa col pensiero che vorrebbe esprimere, dall’altro, più teoretico, veniente alla luce nel modo più chiaro proprio perché quanto manca, in virtù dello stesso fatto di mancare, assume più rilevanza, vigore e cospetto.
Quando per la prima volta in Essere e Tempo si parla di umano e, di questo, se ne evidenzia l’importanza all’interno del discorso sull’essere, ciò che viene primevamente chiarito — in modo del tutto humeano[4], è che ogni scienza, prima d’essere scienza descrivente un dato fenomeno, è parlante dell’uomo stesso; in altre parole, che sia umanistico o convenzionalmente scientifico, ogni approccio conoscitivo al mondo, prima di parlare di quest’ultimo — ammesso che ne possa parlare! —, parla dell’uomo: “In quanto comportamenti dell’uomo le scienze hanno il modo di essere di questo ente (l’uomo)” (M. Heidegger, Sein und Zeit/Essere e Tempo, trad. it. a cura di Franco Volpi, Longanesi, Milano, 1971, p. 24).
Ancora più fortemente e convintamente nei riguardi del posizionamento ontologicamente centrale dell’uomo rispetto ad un dis-velamento sensato della verità dell’essere, viene detto che quest’ultimo, l’uomo, nel suo particolare modo di essere-nel-mondo — inteso tanto nel senso puramente esistenziale, quanto in quello più meramente inerente la sua consapevolezza del mondo stesso —, sia Dasein (Esserci); ovverossia, l’uomo è il luogo nel quale l’essere-ci-è. Potremmo azzardare due possibili interpretazioni — credo, equivalentemente corrette nella loro attinenza all’impalcatura del pensiero heideggeriano: l’uomo è essere-nel-mondo tanto nel senso che sia Dasein — dove l’essere è dentro, tanto nella misura in cui sia colui il quale, nel mondo, è portante la possibilità di poter cogliere l’essere nel modo più veritiero e coerente. Pertanto, la vera ed unica ontologia possibile che possa comprendere l’essere sarà l’«analitica esistenziale» — un’analisi il cui studio è soffermantesi sull’esistenza dell’uomo la quale porta infine all’affacciarsi dell’essere-in-quanto-tale. Di fatti, Heidegger sostiene come “l’Esserci comprende sé stesso in base alla sua esistenza[…]” e che “perciò l’ontologia fondamentale, da cui soltanto tutte le altre possono scaturire, deve essere cercata nell’analitica esistenziale dell’Esserci”[5].
Alla luce di queste considerazioni, possiamo intendere l’essere-in-quanto-tale e l’uomo in quanto onticamente Esserci talmente tanto tangentesi ed anzi interconnettentesi — se non addirittura inestricabilmente coincidenti pur mantenendo una sostanziale separazione — che lo studio sull’uno porta allo svelamento dell’altro: l’analitica dell’esistenza la quale ha in oggetto l’uomo nella sua «esistenzialità» porta, infine, all’essere e, inversamente, compresosi l’essere, da questo si può ontologicamente ridiscendere alla comprensione dell’Esserci[6]. Procedendo nelle argomentazioni — e sempre più distruggendo l’ontologia moderna e le altre da essa derivate, Heidegger giungerà, infine, ad ammettere che l’essere possa comprendersi autenticamente solo nella sua assenza: dove vi è assenza, vi è la percezione ontologica di quel «qualche-cosa» che, tolto, pone l’asfissiante assenza-in-sé e che, proprio in virtù di questa assenza, si fa presente. In altre parole, l’essere, sfuggente ed apparentemente non catturabile attraverso una concettualizzazione determinata, è sempre stato catturato ed anzi, è sempre nell’Esserci e, ancora, quanto più è sembrato o è sembrante non-esserci, tanto più è stato o è affermantesi nella sua presenza: nel luogo del tolto, è rilucente quella presenza-assente del tolto stesso.
È in questo senso che, heideggerianamente, viene affermata un’inalienabile necessità dell’assenza, del vuoto: questi, infatti, costituirebbe l’ontologica condizione di possibilità per la comprensione autentica dell’essere stesso; in termini maggiormente esistenzialisti (ed in Heidegger la matrice esistenzialista rasenta l’identità con quella più speculativo-teoretica), l’uomo, affinché possa autenticamente vivere e comprendersi, necessita di veder-si nella morte; deve essere-per-la-morte. Infatti, “il morire non è un semplice accadimento, ma un fenomeno che va compreso esistenzialmente[…]” (ivi, p.289): compreso esistenzialmente nella misura in cui, l’accadere della morte, inerisce alla costituzione ontica dell’Esserci — e riguarda congenitamente il suo porsi in quanto ente. L’uomo è un essere-per-la-morte e, quando se ne rende conto esperendo per questo la vita nel modo più serio e consapevole — heideggerianamente esprimentesi temporalmente nel «progetto», è in una condizione esistenziale di «vita autentica»: una vita la quale, per così dire, vede il suo fondamento in quell’assenza-di-vita che è la morte e, proprio in virtù di quel vuoto-pieno-del-tolto, si auto-chiarifica e comprende.
Un altro caposaldo fondamentale della struttura teoretica heideggeriana — che ci permetterà finalmente di pervenire all’argomentazione centrale di questo lavoro, è rappresentato dalla «Cura». Per meglio parlare della Cura, è necessario anzitutto comprendere come Heidegger certamente non lasci aperto il problema della con-esistenza degli Altri rispetto al nostro essere-nel-mondo: coloro i quali condividono con noi il mondo, infatti, sarebbero heideggerianamente i «con-Esserci»[7] — ed il rapporto che ogni Esserci possa intrattenere con l’altro deve essere strettamente regolato su misura dell’aver-cura. Il mondo è il campo dove hanno luogo le azioni degli Esserci e, in quanto mondo, è anche mutante, diveniente; è il mondo del quale le cose sono transeunti, modificantesi, corrompentesi: è il mondo dove s’abbisogna — se si vive genuinamente e rispettosamente nei confronti di questo — d’avere cura delle cose che sono in quanto cose, ed in quanto con-Esserci. Per le cose, Heidegger adopera l’espressione prendersi-cura; per i con-Esserci, invece, come abbiamo detto, l’avere-cura.[8] È di singolare e rilevantissima importanza, tra le altre cose, rendersi conto di come, il tema della Cura nei confronti delle cose-nel-mondo e dei con-Esserci, venga ad essere argomentato successivamente ad un approfondimento nei riguardi dell’esperienza dell’angoscia — status tanto caro alla filosofia del ‘900 e specificatamente a quella esistenzialista: questo, come a voler Heidegger evidenziare che, affinché un individuo possa avere-cura dell’altro, è necessario, prima, che faccia esperienza dell’angoscia — la quale (per come descritta da Heidegger) è l’esperienza del mondo-come-tale[9]. Ovverossia, l’angoscia è quella “situazione emotiva fondamentale” in cui l’Esserci vive in una condizione di completa separazione rispetto a quel mondo vivo e diveniente, comprendente i con-Esserci di cui sopra; è, in altre parole, l’avvertimento del mondo in quanto spoglio mondo, in quanto mondo secco, insipido, grezzo ed in un certo qual senso scarnificato e quindi depauperato del suo senso più autentico: il mondo, così pensato — de-vitalizzato e percepito in modo grigio, vacuo, soffuso —, è, per l’Esserci che fa esperienza dell’angoscia, insignificativo[10]. L’essere, seppure in-sé sia certamente finitamente uno, non è né deve sentirsi solo.
Esperito il nulla dell’angoscia, l’Esserci è adesso pronto per un contatto genuinamente intrapreso con l’Altro — contatto allacciantesi a partire dalla Cura. Questa, ci viene presentata sotto le spoglie teoretico-linguistiche dell’«esser-presso»[11]: l’Esserci, infatti, ha la caratteristica di essere sempre avanti-a-sé; in altre parole, l’estensione esistenziale dell’individuo è compresa entro il suo porsi in un momento che è sempre sporto verso l’avanti — tanto in uno cronologico quanto in uno ontologico riguardante il suo incontrarsi con le cose e l’Altro. Ci viene chiarito il concetto da parte di Heidegger stesso, il quale infatti lo sintetizza come un “[…]essere-avanti-a-sé-già-in (un mondo) in quanto esser-presso (l’ente che si incontra dentro il mondo)[12]”.
Certamente nella filosofia heideggeriana l’aver-cura è fondamentale per questioni di matrice puramente ontologica[13], eppure, nella sua praticizzazione all’interno del campo della vita quotidiana, essa si esplicita attraverso un rapporto sano e rispettante l’Altro, il con-Esserci: questi, infatti, starebbe concorrendo — esattamente come noi — all’autenticizzazione della propria vita e, con questo, al disvelamento del senso dell’essere. Pertanto, compartecipanti l’uno all’esistenza dell’altro, è necessario che sia inequivocabilmente la Cura a rifinire l’intelaiatura delle complesse relazioni sociali (ed ontologico-esistenziali, in questo caso): aver-cura dell’altro-da-me, in altre parole, è una missione che heideggerianamente si gioca tutta entro il campo del senso dell’essere. L’aver-cura-dello-altro-da-me è avente sensatezza, come questione, solo se avviluppantesi entro un canale di rapporti interpersonali che facciano del rispetto ontologico la loro base fondamentale: io che m’incammino nel mondo, non sono solo e, in quanto non-solo, ho l’altro-da-me come oneroso ma rispettabile compito; un compito che già lo stesso Dostoevskij, ne I fratelli Karamazov, evidenzia con ineguagliabile delicatezza — e direi anche dolcezza: “[…]anche se la tua luce risplendesse e tu vedessi che gli uomini non vengono salvati da essa, tu resisti lo stesso e non dubitare del potere della luce celeste; abbi fede che, seppure non si sono salvati adesso, si salveranno in futuro[…]. Il giusto se ne va, ma la sua luce rimane[14]”. La dostoevskijana luce risplende grazie al mio rispettare l’Altro per il solo fatto che questi esista e, esistendo, entri in relazione con me: nella Weltanschauung dostoevskijana moralizzante il senso del mondo-in-quanto-mondo, attraverso l’«amore onnicomprensivo»[15], in quella invece heideggeriana ontologizzante il senso del mondo-in-quanto-mondo, attraverso il fatto che ogni Esserci, nel suo essere-nel-mondo, non invada ontologicamente l’altro nel suo cammino, nel suo progetto.
È proprio intorno a questa «invasione» che vorremmo imbastire l’argomentazione fondamentale di questo lavoro: il termine, etimologicamente, deriva dal lat. invadĕre (comp. di in- e vadĕre, “andare”)[16]; in altre parole, la significazione più corretta del lemma rimanda all’«andare-dentro», alla penetrazione di un qualcosa in qualcos’altro. Ogni individuo, ogni Esserci, abbiamo detto, è in cammino: è avanti-a-sé, coercitivamente e necessariamente; non c’è una individualità ferma, statica, stagnata in un luogo, in un determinato tempo. L’uomo — sartrianamente, è condannato alla Libertà[17]: ne soffre, ne è angosciato e, infine, cerca in ogni modo di colmare una mancanza ontologica che, in-sé, è quanto poi, inevitabilmente, lo fonda nel suo stesso porsi; come a voler dire: questa mancanza che ti spinge fuori-di-te, alla ricerca di un mancante sconosciuto ed inconoscibile, nebuloso e segreto, assente eppure dirompentemente presente, seppure sia un anatema — una dannazione, è anche quanto poi, alla fine, ti rende ontologicamente uomo. Così, quindi, ogni uomo, è chiamato a scegliere, è chiamato a mettersi-in-gioco, è chiamato a divenire sé stesso[18]: anche la più apparentemente ininfluente delle scelte, anche la più effimera delle decisioni, è un modo-di-essere dell’uomo il quale, per condanna o per fortuna che si voglia, ha deciso liberamente. Eppure, la decisione che si getta fuori di sé in un mondo con-vissuto è, inevitabilmente, una decisione che contatta gli altri, che etimologicamente li tocca[19], che, quindi, può tanto accarezzarli quanto schiaffeggiarli, tanto renderli sofferenti quanto gaudenti, tanto tristi quanto felici, tanto essenti quanto defunti: la chiamata alle armi dell’essere autentico rispetto al progetto — in Heidegger —, o rispetto alla scelta determinante l’io (kierkegaardianamente), ha una caratteristica ben più importante — quella di avere l’Altro come scotto.
È tutta focalizzata qui l’attività ontologicamente etica nei confronti dell’Altro e del suo porsi in quanto con-Esserci: così come l’autenticità viene restituita all’Esserci attraverso l’esperienza del presente-nello-assente (esistenzialmente, della morte), tanto deve dirsi nei confronti del suo rapportarsi all’Altro — l’autenticità del rapporto (che si fonda entro il rispetto dell’altrui esistenza) è da darsi nella preoccupazione di quella assenza che separa la costituzione ontologica di ogni singolo con-Esserci. Le fondamenta di un rapporto consolidato che si delinei entro una sensatezza rispettante l’Altro, passano attraverso la Cura di quel vuoto, di quell’assenza, che rende la mia individualità unica e separata rispetto a quella dell’Altro: c’è uno scarto inequivocabile, inopinabile ed inalienabile a descrivere la mia persona e quella dell’Altro. Anche mettendoci quanto più affiancati sia possibile immaginare, io e l’Altro non ci fonderemo né dissolveremo l’uno nell’altro: rimarremo io-e-lo-Altro; seppure congiunti — anche grammaticalmente, è la separazione quanto, paradossalmente, ci dà la possibilità di essere vicini, compagni, con-Esserci. La congiunzione “e”, infatti, avvicina ma allontana, separa ma rende contigui, eppure, tutto quanto rende possibile l’essere-congiunti è proprio quella separazione stessa, quel vuoto, quell’assenza circoscrivente ogni individualità entro una propria costituzione ordinata e per questo assoluta; l’unica possibilità data all’Esserci di poter invadere l’individualità esistenziale altrui è nella sua stessa esistenza: esistendo, divengo, dinamicamente e spasmodicamente. Divenendo, io, inevitabilmente — essendo l’esistenza un filo le cui estremità sono sempre allacciate ad altri fili le cui estremità a loro volta si allacciano ad altre di altri fili creando un nodo inestricabile di individualità interconnesse[20], porto con me l’Altro e, se non mi preoccupo di quest’ultimo, se non ne ho cura, lo posso limitare, costringere, inibire esistenzialmente e, peggio, ontologicamente. Il rapporto sano è espressione dell’assenza e del vuoto, è la sua più aulica ed accecante manifestazione, la sua più elegante e raffinata esplicitazione; è quanto, quel vuoto, lo accarezza e se ne prende cura lasciandolo lì. Aver-cura dell’Altro è aver-cura dell’assenza che s’interpone tra le nostre costituzioni e che, posta, ci rende inter-personalmente avvicinabili, accostabili, dialoganti; e da questo vuoto, da questa assenza — da vedere non come un abisso aberrante ma come territorio della possibilità, emerge l’alterità nella sua forma più incondizionata, compresa la quale è possibile non solo averne-cura e rispetto, ma volerle anche bene.
[1] Opere e Giorni, vv. 94-105; ivi, inoltre, viene anche poeticamente introdotta la Speranza: essa, però, rimarrebbe in fondo al vaso e, non avendo fatto in tempo ad uscire coi mali, verrebbe rinchiusa ermeticamente. Quella Speranza, in modo del tutto heideggeriano, è veniente dal Male, passabile d’essere inteso come «assenza», e, infine, è quanto riuscirà a risollevare l’uomo; allo stesso modo, nell’assenza heideggeriana si trova il senso dell’essere, ne si trova la sua più inconfondibile presenza.
[2] Si presti, infatti, particolare attenzione a come la dinamica del vuoto venga trattata da Aristotele nella Fisica (IV.8 215a); ivi, infatti, Aristotele prende le distanze dalle dottrine di Melisso di Samo, il quale, viceversa, argomentando le tesi del proprio maestro Parmenide, riteneva il vuoto fosse il contrario dell’essere: per questi, l’essere veniva rappresentato dal «pieno» e, invece, il non-essere dal «vuoto» (DK 13 B 7-8). Il problema è che, sostenendo una siffatta dottrina, Melisso perveniva alla diretta conseguenza per cui, considerando lui (e come lui in particolare gli atomisti) il vuoto come necessario per il movimento (differentemente da Aristotele), non ci fosse, poi, in assoluto alcun movimento.
[3] Essere e Tempo, nella sua titolazione originale in Tedesco.
[4] Cfr. D. Hume, Trattato sulla Natura Umana, Bompiani, Milano, 2020, p. 17
[5] M. Heidegger, Sein und Zeit/Essere e Tempo, trad. it. a cura di Franco Volpi, Longanesi, Milano, 1971, pp.25-26
[6] Heidegger stesso, infatti, parla di una sorta di espulsione, di «deiezione» dell’essere il quale, facendosi mondo, si veste delle spoglie dell’Esserci che, comunque, in-sé, con-tiene ontologicamente quell’essere stesso e che, comunque sia, è-gettato in quel mondo il quale a sua volta, compresente all’Esserci, è anch’esso, ancora, essere. — ivi, p.215
[7] ivi, §26
[8] ivi, §41, p.235
[9] ivi, §40, p.228
[10] ivi, p.227
[11] ivi, §41, p.235
[12] ibid.
[13] Heidegger stesso, onde evitare strumentalizzazioni eccessivamente moralistiche del concetto, chiarisce, senza lasciare spazio a dubbi, come questo abbia in gioco solo istanze di tipo ontologico e qualsiasi iper-moralizzazione del termine sia assolutamente fuorviante rispetto a quanto esso voglia esprimere nella sua più legittima significazione. — ibid.
[14] F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov, Garzanti, Milano, 1999, p.446; per altre edizioni: cfr. Parte II, Libro VI, Cap. III
[15] ivi, p. 444; per altre edizioni: ibid.
[16] Etimo gentilmente prestataci dal vocabolario Treccani.
[17] Cfr. J.P. Sartre, L’essere e il nulla, Milano, Il Saggiatore, 1965, pp. 69-70
[18] Sul tema, consigliamo caldamente la lettura di Aut-Aut/Enten-Eller, di S. Kierkegaard.
[19] Dal lat. contactus –us, der. di contingĕre, “toccare” — Treccani.
[20] La metafora del nodo viene utilizzata anche dall’antropologo T. Ingold ne “Siamo Linee. Per un’ecologia delle Relazioni Sociali” per descrivere la complessità delle relazioni sociali.
Nato nel 2001, attualmente studente presso la facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; si è occupato già di Filosofia presso numerose riviste e blog. Spiccano, tra le varie, le collaborazioni con “Gazzetta Filosofica”, “Filosofia in Movimento”, “Ereticamente — Sapienza” e “Pensiero Filosofico”. È stato membro della redazione della rivista “Intellettuale Dissidente”; ivi, si è occupato dell’etichetta “Filosofia”. Ha anche pubblicato per il blog “Sentieri della Ragione” e, sulla sua pagina Facebook (“Sentieri della Filosofia”), è stato relatore, con la direttrice, di due webinar aventi riscosso soddisfacente successo. Saltuariamente, pubblica i suoi contributi sulla piattaforma accademica “Academia.edu”; qui, questi hanno ricevuto — in totale — quasi una decina di migliaia di letture. Ha collaborato con l’editorial board di “Pillole di Ottimismo”, dando, della complessa e poliedrica questione pandemica, una contestualizzazione filosofica. Ha tenuto convegni di Filosofia locali presso la sua città d’origine, Bitonto — in collaborazione con la testata giornalistica del luogo, dal titolo “La Persistenza Filosofica”. Occasionalmente, pubblica anche per il blog di psicologia Italiano, “Psiche.org”. È stato membro della redazione, occupato nell’etichetta “Filosofia”, della rivista — ormai inattiva, “nuovoumanesimo.eu”. Infine, è stato chiamato a presentare un lavoro sul testo “Mobilitazione Totale” di M. Ferraris in occasione dell’evento “Summer School di Filosofia Teoretica” (2019) intitolantesi “Pensare il Futuro/Pensare al Futuro” tenutosi in Bitonto — al quale dibattito (oltre alla presenza dell’autore) ha partecipato il filosofo B. Stiegler.