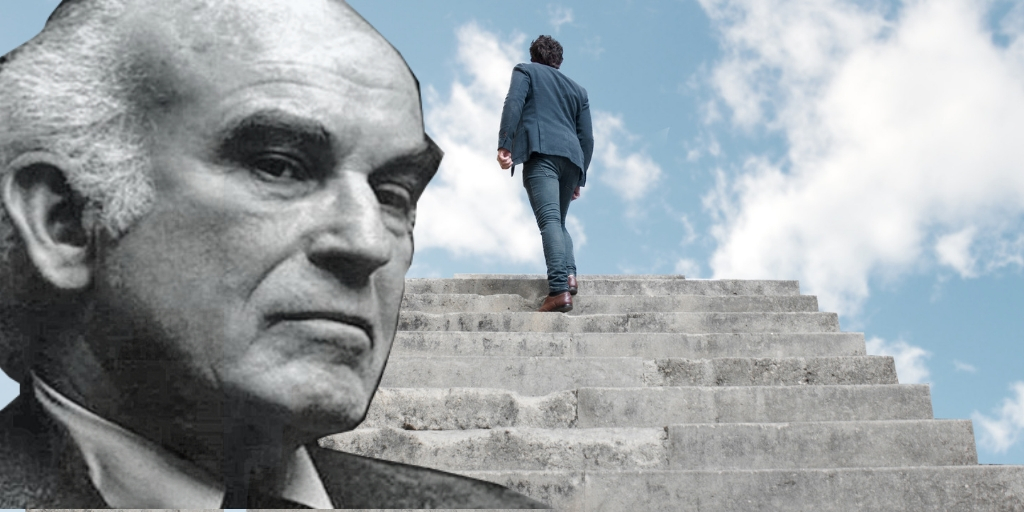Credo che chiunque ami definirsi progressista debba affrontare la sfida concettuale che si trova in un libro che il sociologo americano Robert Alexander Nisbet (1913-1996) pubblicò nel 1969 per la casa editrice dell’Università di Oxford. Il grosso tomo, un vero e proprio classico, esce solo ora in traduzione italiana (di Stefano Magni) per IBLibri, la casa editrice dell’Istituto Bruno Leoni di Milano, con il titolo: Storia e cambiamento sociale. Il concetto di sviluppo nella tradizione occidentale (prefazione di Sergio Belardinelli, pagine 339, euro 22).
Di storie dell’idea di Progresso ne esistono in verità di buone anche in italiano, da quella di John Bury alle altre più teoretiche di studiosi come Gennaro Sasso e Raffaello Franchini (non è stata mai tradotta invece quella che Nisbet stesso pubblicò nel 1980). Quello di Progresso è un concetto che, oltre ad avere avuto un indubbio riscontro pratico nella mentalità moderna, a partire almeno dall’età dell’illuminismo, è stato concepito e teorizzato nei modi più diversi da filosofi, scienziati, uomini di lettere. Ripercorrerne la storia è sicuramente un modo per ripercorrere la storia della nostra civiltà da un angolo visuale significativo. Tutto sommato si può però dire che progressisti e antiprogressisti si siano comunque mossi su un terreno comune, quello che ha dato per scontato lo sviluppo per accumulazione di conoscenze e anche di sensibilità in lato senso morali. Che è proprio invece il dispositivo logico, il meccanismo mentale, che Nisbet vuole mettere in discussione e smontare.
La storia, dalla visione ciclica a quella progressista
Prima di tutto egli vede una sostanziale continuità nella tradizione occidentale, dai Greci fino ai giorni d’oggi, nel modo di intendere la storia: tradizione giudaico-cristiana e tradizione classica non sono da concepirsi in antitesi. Anzi è proprio nel pensiero greco, precisamente nell’elaborazione del concetto di physis o “natura” delle cose, che è da ravvisare quella metafora organicistica che ci porta a pensare alla storia nel suo complesso e a ogni singola civiltà come fossero una pianta o un albero, quindi con un loro ciclo vitale fatto di nascita, crescita e infine decadenza e morte. Il pensiero sociologico, erede di questa tradizione, ha pensato il cambiamento sociale, che è il suo oggetto specifico, in quest’ordine di idee, che potremmo definire “sviluppista”. Lo sviluppo è diventato una chiave euristica in senso conoscitivo e si è imposto quasi come un dovere morale il seguirlo (prospettando un’età futura di pace, giustizia e libertà) o il negarlo (propronendo il ritono ai buoni costumi di una antica “società dell’oro” che in vero non è mai esistita).
Dalla teoria ciclica greca alla concezione teleologica e provvidenzialistica cristiana, fino all’idea di Progresso e alle teologie secolarizzate dell’età moderna (in primis quella marxista), fino ancora al nostro quotidiano pensiero irriflesso, è uno stesso meccanismo mentale che ha funzionato. E una stessa metafora: quella che riconduce lo sviluppo storico, e quindi umano, alla crescita, e quindi ai processi che hanno corso negli organismi viventi. Particolarmente significativo è considerare a tal proposito che Nisbet, da una parte, sembra avvicinarsi alla classica interpretazione di Karl Loewith secondo cui il progressismo moderno è la secolarizzazione dell’idea cristiana di sviluppo storico su base provvidenziale; dall’altra, come se ne discosti perché mostra che, nel profondo, le differenze fra la concezione pagana dei cicli storici e quella giudaico-cristiano del progresso lineare, ereditata dalla modernità, sono da considerarsi come la diversa modulazione di uno stesso spartito, quello sviluppista, Il concetto di “necessità storica” che troviamo, fra gli altri, in Karl Marx ha le sue radici nella filosofia di Sant’Agostino, in cui anzi nasce propriamente, come spiega questo libro nelle intense e originali pagine sul vescovo di Ippona.
Contestare i progressisti da un’altra ottica
Nisbet è stato uno dei massimi studiosi conservatori della seconda metà del secolo scorso, ma la sua critica viene a coinvolgere anche classici del pensiero che all’idea di progresso si sono opposti e che solitamente vengono ascritti alla categoria del conservatorismo. E coinvolge addirittura autori, come Oswald Spengler, che hanno teorizzato il declino e la decadenza. Tutti hanno infatti accettato il campo da gioco tracciato dagli sviluppisti, semplicemente cambiando segno al giudizio morale da dare al procedere della storia. Nisbet propone invece di contestare i progressisti in un modo ancora più radicale, cioè mettendone in discussione lo stesso modo, a torto considerato “naturale”, di guardare alla storia: è di un altro occhio, di una differente prospettiva, che secondo lui c’è bisogno. Il modo comune di guardare alla storia, che potremmo definire metafisico, tende infatti a razionalizzare il mondo umano, così come lo scienziato fa con la natura. Ciò comporta l’eliminazione dal nostro orizzonte del caso singolo nella sua specificità, e quindi anche della casualità e imprevedibilità con cui esso si impone. Da qui le comparazioni storiche, spesso inappropriate (ad esempio, potremmo dire noi con un occhio all’attualità, quelle che portano a vedere il ritorno del fascismo storico in ogni episodio di intolleranza del tempo nostro). Da qui anche l’esigenza, che pure ha un suo valore pratico, di ricondurre il caso singolo a “leggi generali” e a non considerarlo come la particolare risposta data dagli uomini a problemi emersi con forza e prepotenza dall’esterno in quello specifico tempo e contesto.
Quella di Nisbet è così una concezione puntualistica della storia, e dell’attività dello storico, che lo avvicina molto, ai teorici dello storicismo tedesco (ad esempio Leopold von Ranke) e a importanti storici tout court (da Erodoto e Tucidide fino a Theodor Mommsen). E che lo porta anche a scrivere pagine di ammirazione nei confronti di Max Weber, che, come gli storicisti tedeschi, faceva riferimento ad un orizzonte dopo tutto relativistico. Nisbet, in verità, non si pone il problema del relativismo, almeno per quanto io ne sappia. Anzi i suoi valori sembrano solidi e precisi e sono quelli del conservatorismo liberale classico: né individualista né statalista ma molto attento ai corpi sociali intermedi (a cominciare dalla famiglia) che proliferano nella società come garanzia di libertà. Una predilezione però di gusto se, per certi versi, Nisbet sembra portare più a fondo di Friedrich von Hayek la critica alle astrazioni logiche e alle generalizzazioni: l’affermazione “nessuno ha mai visto morire una civiltà” con cui si apre il libro ha, a mio avviso, un valore logico-epistemologico prima che storico.
“Smontare” i miti
In ogni caso, la grandezza del libro sta nella pars destruens, nella capacità che Nisbet ha in sommo grado di smontare i miti del discorso politico e del pensare comune. Non solo quello di sviluppo, ma anche, come dicevo, quelli di Individuo e Stato: il primo non può concepirsi infatti come un ente isolato, il secondo nasconde sempre concreti e sedimentati rapporti di potere. Ma miti sono anche la democrazia, la giustizia, la stessa libertà se considerata avulsa dai contesti storici e slegata da ogni regola o consuetudine. Mito è forse anche, pur se Nisbat non lo dice, quello di una comprensione storica “pura” e scevra da ogni mito, metafora, pregiudizio, persino utopia. Dopo tutto il monito di Ranke a conoscere i fatti per come effettivamente si sono svolti è illogico e utopistico. Fatto sta che, “in negativo” appunto, anche questa idea può servire a smontare e mostrare i limiti di un pensiero metafisicamente atteggiato. Per questa via il libro, che come si è capito è una dotta e documentata ricostruzione storica, ricca di spunti, finisce per essere sicuramente un ottimo antidoto alla sociologia positivistica, che ancora domina il nostro pensiero. Non è un caso che la critica ad essa sia compiuta con metodo storico, mostrando come concetti generali, come quello di mutamento (da non non confondere con quello di movimento) falsifichino la comprensione degli eventi, immettendo in essa pregiudizi intellettuali che solo a posteriori cerchiamo di far combaciare con i fatti.
Più in generale, mi sembra di intravedere in Nisbaet una più radicale critica, in nome della storia, a tutto il pensiero sociologico, anzi alle scienze sociali nella loro totalità, almeno così come si sono affermate negli ultimi due secoli (pur sorgendo su basi profondamente radicate nella cultura occidentale). “Quali che siano le esigenze di una teoria sociale, le prime a dover essere soddisfatte sono quelle della realtà sociale che troviamo unicamente nei dati storici”. Tutto il resto è sicuramente secondario”: così significativamente il libro di Nisbet si chiude.
Ancora più a fondo, mi sembra che nel sociologo (ma ormai è chiaro che è riduttivo definirlo tale) affiori a tratti anche la consapevolezza, essa sì liberale, della tragicità della vita, della inconciliabilità dei suoi elementi, e della necessità di tenere sempre aperta la tensione fra essi. A dimostrazione di ciò, in conclusione, credo anche io, con l’autore della incisiva prefazione, che sia opportuno riportare la pagina con cui simpateticamente Nisbet cerca di trarre il senso ultimo delle riflessioni sulla democrazia di Alexis de Tocqueville (che sempre Belardelli considera, insieme a Edmund Burke, il suo autore di riferimento). Eccola: “La libertà libera ma incatena – in un nuovo tipo di dispotismo al quale solo le democrazie si trovano a dover far fronte. L’individualismo emancipa ma incatena – in nuove forme di egoismo, di isolamento spirituale e di nervosismo incessante. Il secolarismo dischiude le menti su nuovi mondi di conquista, ma sistematicamente affievolisce il desiderio di agire. L’opinione pubblica trionfa sulla tirannia dei principi, ma diventa essa stessa una forma di repressione del pensiero individuale più forte di ogni altra riscontrabile nell’Inquisizione spagnola. E sotto forma di democrazia, il potere diviene ancora più pervasivo di quanto non lo sia nelle mani di monarchi assurti al trono per diritto divino”.
Ecco, a me sembra che il centro della questione sia proprio qui. E anche il problema dell’oggi.
Corrado Ocone, Il Dubbio 12 settembre 2018