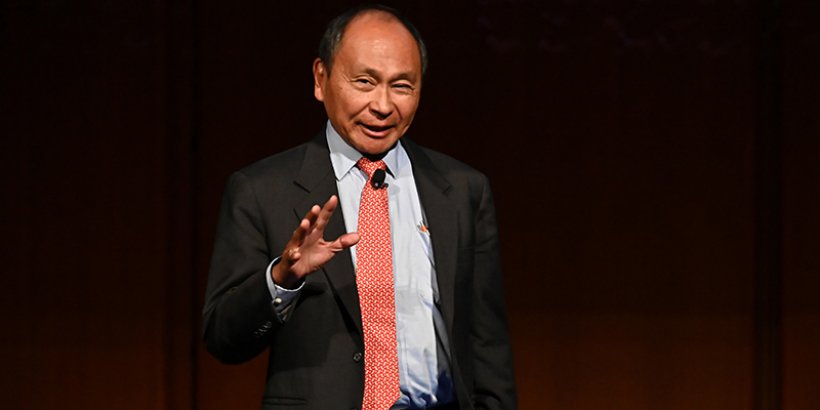Quando Francis Fukuyama pubblicò nel 1992 La fine della storia e l’ultimo uomo, il libro fu accolto con un certo scetticismo, come ha evidenziato Gianfranco Pasquino. Il politologo americano, secondo Pasquino, non profetizzava “un avvenire nichilistico senza storia”, come ha scritto Giulio Sapelli, dal momento che la storia che poteva considerarsi conclusa era in realtà quella della contrapposizione tra le liberaldemocrazie e il comunismo. Nello scenario che si schiudeva, dopo il tramonto dei socialismi “reali”, gli individui avrebbero fatto esperienza di più ampi spazi di partecipazione e questi spazi avrebbero potuto rappresentare un esempio per chiunque volesse estendere le libertà individuali entro la cornice di un’economia di mercato. Nell’introduzione alla nuova edizione del saggio, pubblicato da UTET nel 2020, Pasquino mette in luce come la “fine della storia”, nel senso indicato da Fukuyama, ha dato voce alle potenzialità rimaste inespresse in Paesi lontani dagli orizzonti della liberaldemocrazia.
La condizione “poststorica” non implica che vivremo in un mondo irenico. Nel saggio si coglie infatti la consapevolezza della presenza dei fondamentalismi e dei nazionalismi, che minacciano dall’esterno e dall’interno le istituzioni democratiche. Entro queste dinamiche il liberalismo dimostra però di possedere gli anticorpi necessari per difendere il pluralismo.
L’analisi di Fukuyama è stata fortemente influenzata dal corso sulla Fenomenologia dello spirito di Hegel tenuto da Alexandre Kojève alla Ecole Pratique des Hautes Etudes dal 1933 al 1939, un corso al quale parteciparono intellettuali che, in campi diversi, hanno inciso profondamente nella cultura dei nostri giorni, come Aron, Lacan, Merleau-Ponty, Queneau, Bataille, e altri. È noto che Hegel vide in Napoleone la figura che portava a conclusione una fase storica. La battaglia di Jena, dell’ottobre del 1806, segnò, a suo avviso, il superamento del momento rivoluzionario, conservandone insieme il messaggio di liberazione. Per Hegel l’uomo si distingue dall’animale in quanto aspira al riconoscimento. Si sente uomo quando è riconosciuto dagli altri uomini che egli stesso riconosce. Ciò può realizzarsi pienamente nella condizione giuridica della cittadinanza, che ha assunto un ruolo decisivo nella Rivoluzione francese e che si è estesa universalmente con Napoleone. L’individualità e il desiderio di riconoscimento si realizzano, commenta Kojève, nello “stato universale e omogeneo”, che caratterizza le liberaldemocrazie, in cui vengono soppresse le differenze e le istituzioni si rapportano al singolo come cittadino. Soddisfatto per aver raggiunto questo stato, l’uomo, prosegue Kojève, “non proverà la tentazione di negarlo”. Ciò non conduce a una stasi, proprio perché l’uomo, immerso nella dialettica della storia, darà forme nuove al suo anelito di libertà.
Fukuyama non vuole allora dirci che la storia è finita nel 1989, con la caduta del Muro di Berlino, così come Hegel non voleva dirci che era finita nel 1806, con la battaglia di Jena. Per Hegel il divenire procedeva verso forme sempre più elevate di autocoscienza, di razionalità e di libertà. Il suo immanentismo idealistico esprimeva questo processo sul piano teoretico, la forma di stato che stava prendendo corpo con Napoleone lo esprimeva sul piano politico. Il cammino verso la libertà non è inteso come un percorso che si conclude giungendo a una meta definitiva, dal momento che le declinazioni della libertà sono molteplici e sempre legate al momento storico in cui prendono corpo.
Kojève considerava le rivoluzioni successive all’ ‘89 come un’estensione di ciò che Robespierre e Napoleone avevano realizzato in Francia. Le rivoluzioni comuniste divenivano allora delle tappe lungo un percorso di progressiva affermazione dell’uguaglianza. Il fallimento dei socialismi “reali”, che Kojève non ebbe il tempo di vedere, ha poi dimostrato l’incapacità del marxismo-leninismo di coniugare uguaglianza e libertà. I principi che si erano affermati con la Rivoluzione francese erano per Kojève incarnati dalle democrazie capitalistiche occidentali, che avevano dato risposta alla domanda di riconoscimento. La soluzione dei conflitti sociali aveva spostato dunque l’attenzione dall’ambito politico a quello economico. Fukuyama commenta che la scelta di Kojève di lasciare l’insegnamento per diventare un alto burocrate della Comunità europea esprimeva l’esigenza di riconoscersi in una concezione tecnocratica, legata alla sua visione della “fine della storia”.
Se il desiderio di riconoscimento si realizza pienamente nella democrazia liberale, questo modello politico può rappresentare un meta “finale”, ma divenire allo stesso tempo un ideale regolativo per i popoli e gli individui che lottano ancora per essere riconosciuti. Fukuyama è pienamente consapevole che il liberalismo deve la sua durata alla capacità di coniugare ragioni pragmatiche, morali, economiche, e che, nell’affrontare le crisi, mette in luce le sue fragilità insieme alle sue virtù. Ciò emerge con evidenza nel suo recente saggio Il liberalismo e i suoi oppositori, (UTET, 2022).
Il liberalismo classico, a cui egli fa riferimento, deve difendersi dai liberals (l’equivalente americano dei nostri partiti di centrosinistra), dai libertarians (teorici l’anarcocapitalismo) e dai movimenti europei di centrodestra. Populisti e progressisti, in modi differenti, accusano infatti il liberalismo di favorire le disuguaglianze e di privilegiare le ragioni del mercato sulla giustizia sociale.
Il liberalismo, puntualizza Fukuyama, pur essendo profondamente connesso con la democrazia, non si identifica del tutto con essa. Se infatti la democrazia ha teorizzato prioritariamente il potere del popolo, il liberalismo ha elaborato l’idea di stato di diritto, al fine di limitare ogni forma di potere, quello esecutivo, come quello delle maggioranze. Quando non è garantita la separazione dei poteri e sono minacciate le libertà fondamentali, ci troviamo dinnanzi alle cosiddette democrazie popolari del socialismo “reale” o alle “democrazie illiberali”, di Orban e di Putin. L’autonomia, che ha da sempre costituito la struttura portante del liberalismo, può essere però declinata in modi estremi. Se a sinistra si invocano politiche che tutelino non solo l’autonomia individuale, ma il gruppo di appartenenza, facendo venir meno la dimensione universale della legge e creando nuove discriminazioni, a destra l’autonomia rischia di identificarsi con una totale libertà di mercato, incurante delle disuguaglianze che produce. La deregolamentazione, che ha dato buoni frutti in molti settori, rischia di tener conto esclusivamente dell’interesse del consumatore. Si agevolano così colossi, come Amazon, che sono in grado di ridurre fortemente i costi, ma si danneggiano i piccoli esercenti. Il dogma secondo cui gli individui sono esclusivamente dei “massimizzatori dell’utilità razionale” non tiene conto, per Fukuyama, dell’esigenza cooperativa, e delle motivazioni irrazionali che talora influenzano i comportamenti umani. Ecco perché in Francia e in Giappone sono stati assunti provvedimenti a difesa dei piccoli produttori, anche se ciò ha ridotto l’efficienza economica. Chi identifica l’individualismo liberale con il fondamentalismo del mercato esprime una banale semplificazione. Ignora infatti quell’orientamento del pensiero liberale che, con Einaudi e Röpke, potremmo chiamare il liberalismo delle regole, in cui la libertà d’impresa si colloca sempre in una cornice definita dallo stato.
Un’accusa frequente, rivolta all’individualismo liberale, riguarda la sua specificità “bianca”. Ciò significa non tener conto, scrive Fukuyama, che “una delle sfide più antiche delle società umane è il bisogno di andare al di là della parentela come fonte di organizzazione sociale, verso forme più impersonali di interazione”. Il liberalismo, nel corso della sua storia, ha adottato metodi che riflettono il carattere aperto della ricerca scientifica. La critica alla modernità, che ha attraversato molti ambienti della cultura contemporanea, non ha risparmiato il liberalismo, come non ha risparmiato il sapere scientifico. Fukuyama prende in esame, in proposito, la concezione di Foucault secondo cui le parole sarebbero espressione del potere. In questo quadro, la presunta neutralità del metodo scientifico, dall’economia alla medicina, potrebbe rappresentare un progetto di dominio e di controllo sociale. Queste tesi, diffuse nel pensiero postmoderno, possono fornire ampi spunti per una riflessione critica ma, nella loro estremizzazione, possono anche alimentare logiche paranoiche e complottistiche, come è accaduto durante la pandemia, quando le politiche sanitarie sono state viste come uno strumento del biopotere.
Il liberalismo dimostra la sua vitalità proprio in quanto rifugge da ogni dogmatismo scientista e da ogni “abuso della ragione”, come direbbe von Hayek. Può sentirsi allora in sintonia con il falsificazionismo di Popper, in cui a un sapere aperto non può che corrispondere una Società aperta e pluralista. Rivelando la sua formazione umanistica, Fukuyama scrive che le società liberali devono far proprio il motto delfico meden agan (niente di troppo) e il principio della sophrosyne (moderazione). La realizzazione dell’autonomia individuale non coincide infatti, nella vita sociale, con l’abbattimento di ogni vincolo, ma con l’accettazione del limite. Nel richiamare i classici amati da Mill e le riflessioni di Tocqueville, Fukuyama ci ricorda che recuperare il senso della moderazione individuale “è la chiave per far rivivere, anzi sopravvivere, il liberalismo”.
È presidente del Collegio Siciliano di Filosofia. Insegna Storia della filosofia moderna e contemporanea presso l’Istituto superiore di scienze religiose San Metodio. Già vice direttore della Rivista d’arte contemporanea Tema Celeste, è autore di articoli e saggi critici in volumi monografici pubblicati da Skira e da Rizzoli NY. Collabora con il quotidiano Domani e con il Blog della Fondazione Luigi Einaudi.