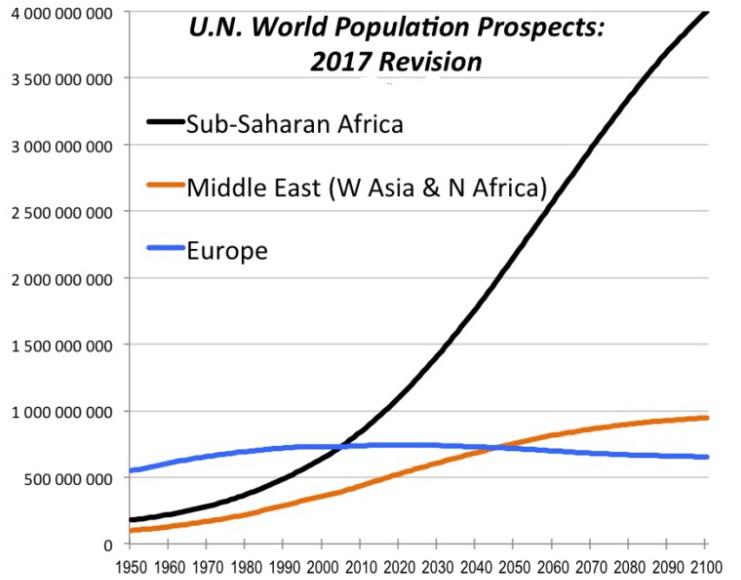Quando i coloni americani si opposero alla politica fiscale esercitata dalla Madrepatria nei loro confronti (il Sugar act è del 1764 e lo Stamp act del 1765), Edmund Burke prese le loro difese. Su questo tema, in America, si erano espresse figure rilevanti, come Bejamin Franklin, Thomas Jefferson e Samuel Adams, rifacendosi al principio del No taxation without representation. Il 22 marzo del 1775 Burke presentò in Parlamento la sua Mozione di conciliazione per le colonie, sostenendo che l’amore per la libertà era “più forte nelle colonie inglesi che in ogni altro popolo del mondo”.
Scrive che si tratta di una forma di libertà “intesa secondo idee e principi inglesi” e che la libertà in astratto non esiste. Ogni nazione si è riconosciuta in determinati valori e da sempre, in Inghilterra, le più grandi battaglie per la libertà si sono combattute “intorno a questioni di tassazione”. Non consentire ai coloni di dire la loro riguardo ai provvedimenti fiscali sovverte dunque i principi che gli inglesi hanno difeso da sempre. In questo scontro, prosegue, “non guadagniamo mai un meschino punto su di loro, senza attaccare qualcuno di quei principi o deridere qualcuno di quei sentimenti per cui i nostri antenati versarono il loro sangue”.
Burke commenta ironicamente che forse alla Madrepatria sarebbe stato maggiormente gradito “uno spirito di libertà più moderato e accomodante”, conciliabile con un’autorità “arbitraria ed illimitata”, ma proprio la cifra britannica che animava la passione civile americana non avrebbe tollerato soluzioni arrendevoli. Valuta positivamente il fatto che i coloni abbiano formato un “governo sufficiente ai propri compiti, senza l’eccitamento di una rivoluzione o le noiose formalità di un’elezione”, un governo originato dal popolo che “non fu trasmesso mediante alcuno degli ordinari mezzi artificiali di cui si avvale una costituzione formale”. La posizione di Burke è tesa a scongiurare ogni azione militare, perché ciò, oltre a esasperare il contrasto, potrebbe favorire l’intervento delle potenze ostili all’Inghilterra. Pur non non facendo propri in toto i principi della Rivoluzione americana, Burke si impegna per estendere ai coloni quegli stessi diritti garantiti dalla common law britannica.
La sua anima whig, che lo condusse dalla parte dei coloni, dovette confrontarsi criticamente con gli eventi francesi dell’ ’89. La Società della Rivoluzione celebrava ogni anno, il 4 novembre, l’anniversario della Gloriosa Rivoluzione del 1688. Nel novembre del 1789 un pastore dissidente, il dottor Price, lesse gli avvenimenti rivoluzionari francesi come una continuazione di quanto si era realizzato in Inghilterra un secolo prima. Burke avverte allora l’esigenza di esprimere tutto il suo dissenso nei confronti di una interpretazione storiografica che rischiava di snaturare il significato della Gloriosa Rivoluzione, assimilandola ai furori ideologici francesi. Il 1688 non fu caratterizzato, a suo avviso, dalla violenza rivoluzionaria, ma da uno spirito di continuità, nel rispetto della consuetudine. Burke immagina che la libertà abbia la potenza di un gas che si sprigioni violentemente. Il giudizio sugli effetti che è in grado di produrre non possono risultare attendibili prima che l’effervescenza sia sfumata. Queste considerazioni lo portavano a “sospendere ogni espressione di compiacimento per la libertà testé conquistata dalla Francia”.
Prima di valutare gli esiti di un processo, occorre “osservare l’uso che vien fatto del potere”, soprattutto quando ci si trovi in presenza di individui nuovi, che aspirano alla realizzazione di una libertà tesa a sovvertire i consueti assetti istituzionali. Burke descrive la Rivoluzione francese come la più “stupefacente” che si sia verificata nella storia. Tutto gli appare innaturale “in questo strano caos di leggerezza e di ferocia, di crimini d’ogni specie, mescolati con le più diverse follie”. Il disprezzo si alterna così all’indignazione, “il riso alle lacrime, lo sdegno all’orrore”. Prende dunque le distanze da quanti guardavano con ammirazione i rivoluzionari, come il pastore Richard Price. Nel suo sermone si potevano riconoscere, infatti, i toni con cui, nel 1648, il reverendo Hugh Peters si era schierato con le frange più radicali della prima Rivoluzione inglese. Peters citava il salmo CXLIX, nel quale si invocano dei santi, che con le lodi al Signore e una spada a doppio taglio avrebbero punito i pagani, i re e i nobili. Veniva meno così, a suo avviso, quella moderazione che, nella chiesa, avrebbe dovuto esprimere la voce “risanatrice della carità cristiana”.
Burke coglieva con lungimiranza, nell’incontro fra la tensione escatologica di una certa sensibilità religiosa e le velleità rivoluzionare di rifondare la storia, le insidie che avrebbero segnato in seguito i totalitarismi, le vere e proprie teologie secolarizzate del ‘900. I predicatori come Price interpretavano allora la Gloriosa Rivoluzione del 1688 riconducendola alla Rivoluzione del 1648 e alla Rivoluzione francese, con la sua deriva giacobina e il Terrore : ”Le confondono costantemente tutt’e e tre insieme”.
La Dichiarazione dei diritti del 1688 si colloca, per Burke, entro la tradizione consuetudinaria e rimanda a forme di legislazione “che hanno la stessa forza e promanano da una medesima autorità, fondata sull’accordo comune, […] sulla comune obbligazione della comunità”. Tale accordo è egualmente impegnativo per il re e per il popolo, “fino a quando ne siano osservati i termini e perduri lo stesso organismo politico”. Il mutamento, senza cui uno Stato non può sopravvivere, è avvenuto, in Inghilterra, nella continuità della consuetudine e della commom law, diversamente da quanto è accaduto in Francia, dove si è imposto con la violenza rivoluzionaria. Ecco perché, secondo Burke, non è possibile leggere le vicende inglesi alla luce dell’ ’89 francese : “Il popolo inglese non scimmiotterà mai mode che non ha mai sperimentate, né richiamerà in uso quelle che abbia provate una volta e trovate sediziose”.
Da qui derivano le riserve di Burke nei confronti dei diritti universali enunciati nell’ ’89, considerati alla stregua di un’astrazione rispetto all’ “eredità tradizionale”, che si trasmette dai padri ai figli. Nella prefazione all’edizione inglese del suo celebre saggio su I diritti dell’uomo, Thomas Paine scriverà che, in considerazione delle posizioni assunte da Burke sulla Rivoluzione americana, lo aveva giudicato “un amico dell’umanità”, aggiungendo che avrebbe preferito “continuare in quell’opinione , anziché di doverla mutare”.
Una costituzione, per Burke, non può imporsi in seguito a una rivoluzione, ma deve essere il frutto di un processo storico. Come ha evidenziato Hannah Arendt, Burke rivendica i “diritti di un inglese”, collocandoli al di sopra degli inalienabili diritti dell’uomo, che riteneva pura astrazione. Egli temeva, sostiene Arendt, che la difesa dei diritti naturali avrebbe condotto all’ “astratta nudità dell’essere-nient’altro-che-uomo”. Tutto ciò comportava il rischio che l’individuo moderno perdesse il contatto con il mondo in cui si era formato. Se la tragedia delle tribù “selvagge”, commenta Arendt, “consiste nell’abitare in una natura immutata che non riescono a dominare, nel vivere e morire senza lasciar traccia, senza aver contribuito in nulla alla creazione di un mondo comune, gli apolidi moderni si trovano invero in una specie di stato di natura” e, pur non essendo di certo dei barbari, mostrano “i primi segni di un possibile regresso di civiltà”.
La contrapposizione di Burke ai diritti universali, richiama la celebre espressione di de Maistre, il quale, nelle sue Considerazioni sulla Francia, scriveva di non aver mai incontrato l’ “uomo” delle Dichiarazioni, ma solo francesi, italiani o russi. Vengono anche in mente molte delle argomentazioni che i comunitaristi utilizzano per attaccare l’impostazione universalistica e procedurale del liberalismo, ma non bisogna dimenticare che le riflessioni di Burke si collocano all’interno di un pensiero whig che si riconosce nella common law e non vogliono affatto fornire armi per una crociata antimoderna.
Scriveva Friedrich von Hayek in Perché non sono un conservatore, nel 1960, che se si fosse potuto parlare ancora di Burke, di Macaulay o di Gladstone come di grandi liberali e di Tocqueville e di Lord Acton come dei più importanti pensatori liberali del secolo XIX, egli si sarebbe sentito orgoglioso di fregiarsi di quel nome. Riteneva però che i liberali europei, nel corso del tempo, avevano accolto idee “fortemente avversate da quegli uomini, ed erano guidati dal desiderio di imporre al mondo un preconcetto modello razionale più che da quello di fornire possibilità di libero sviluppo”.
Nell’abuso della ragione, Hayek riconosceva quello spirito giacobino che Burke aveva denunciato nelle sue Riflessioni, contrapponendovi una concezione della libertà come sviluppo graduale e spontaneo. Anche negli Stati Uniti, oltre che in Europa, scrive Hayek, il termine “liberale” aveva gradualmente assunto un significato che si discostava dalla sua concezione del liberalismo. Egli non riusciva, al tempo stesso, a riconoscersi nel libertarismo.
Gli ideali whig avevano subito, a suo avviso, delle profonde trasformazioni durante il XIX secolo, da quando il loro carattere era stato alterato “dalle esagerazioni dovute alla rivoluzione francese con la sua democrazia totalitaria e le sue dottrine socialiste”. Se dunque il liberalismo aveva gradualmente assorbito quello che Hayek definiva “il rozzo razionalismo militante della rivoluzione francese”, si rendeva necessario “liberare quelle tradizioni dall’influenza socialista, superrazionalista e nazionalista, arbitrariamente introdottasi”. Ecco perché avvertiva l’esigenza di definirsi, pensando sicuramente a Burke, “un impenitente old whig – con l’accento su old”.
Testi citati
Burke, Discorso di Edmund Burke nel presentare la sua mozione di conciliazione con le colonie, trad. it. in Id, Scritti politici, UTET, Torino, 1963.
Id., Riflessioni sulla Rivoluzione francese e sulle deliberazioni di alcune società di Londra ad essa relative : in una lettera destinata ad un gentiluomo parigino, trad. it. in Id, op. cit.
Th. Paine, I diritti dell’uomo, trad. it., Editori Riuniti, Roma, 2016.
Arendt, Le origini del totalitarismo, trad. it., Edizioni di Comunità, Milano, 1967.
von Hayek, Perché non sono un conservatore, trad. it. in Id., La società libera, Vallecchi, Firenze, 1969.
È presidente del Collegio Siciliano di Filosofia. Insegna Storia della filosofia moderna e contemporanea presso l’Istituto superiore di scienze religiose San Metodio. Già vice direttore della Rivista d’arte contemporanea Tema Celeste, è autore di articoli e saggi critici in volumi monografici pubblicati da Skira e da Rizzoli NY. Collabora con il quotidiano Domani e con il Blog della Fondazione Luigi Einaudi.