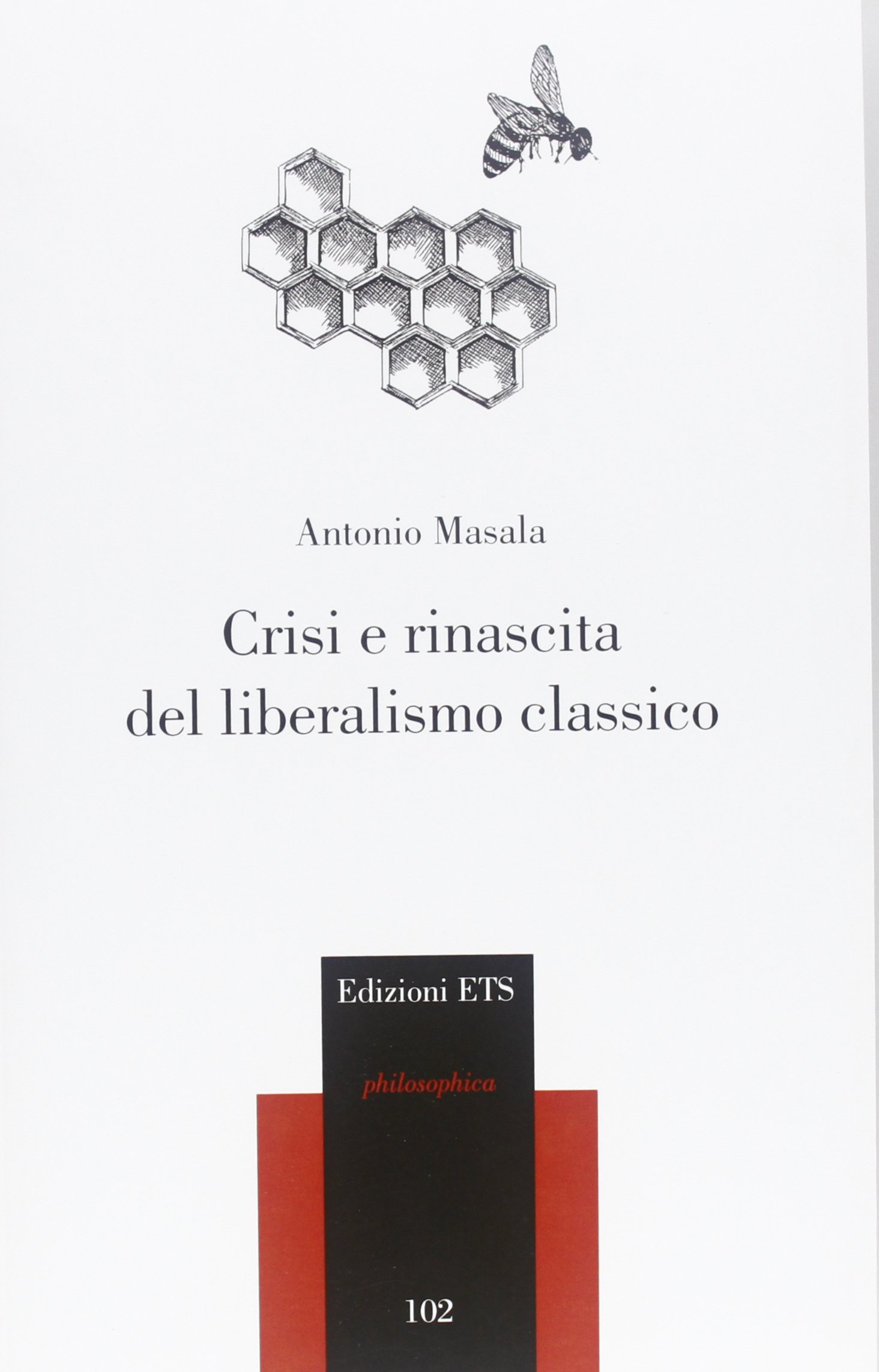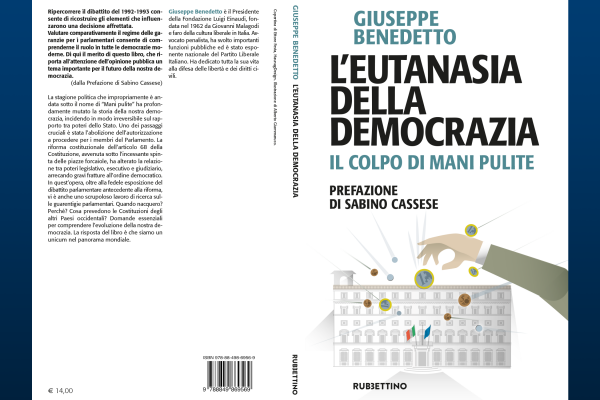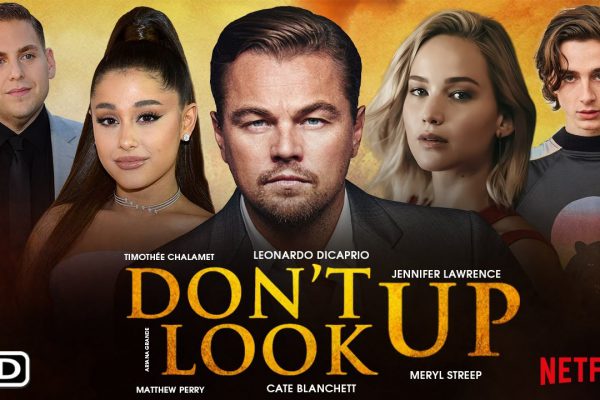Sono ormai quindici anni che Jacques Derrida non è più fra noi: morì infatti a Parigi, stroncato da un tumore al pancreas, il 9 ottobre 2004 (era nato ad Algeri, in una famiglia benestante di ebrei sefarditi il 15 luglio 1930). Era un filosofo con una forte visibilità pubblica e mediatica, che non aveva disdegnato a partire da un certo momento di usare i mezzi moderni della comunicazione di massa (ci sono anche film e documentari su di lui e con lui protagonista) pur non concedendo mai nulla al grosso pubblico in termini di fruibilità del suo discorso. Il quale, pieno di allusioni e proficuamente e volutamente inconcludente quale era, si presentava spesso ostico, poco comprensibile.
Era da questo modo di fare, di porsi e imporsi, che emanava il suo fascino, per alcuni. Per altri, invece, egli era semplicemente un “ciarlatano”, come ebbero a definirlo i filosofi analitici che firmarono nel 1992 una lettera-appello comparsa sul Times contestando la decisione dell’Università di Cambridge di laurearlo honoris causa.
Oggi, forse anche per la crisi evidente della filosofia analitica, quelle polemiche si sono spente o comunque sembrano lontane nel tempo. Derrida continua però ad essere un punto di riferimento per chi fa filosofia, ovvero per chi pensa il mondo e la vita in modo radicale. Lo è a maggior ragione per chi va oltre il suo pensiero e lo tradisce perché sa che esso tendeva proprio a questo, per sua intima costituzione: a essere tradotto e tradito dagli “allievi”.È questa allora la più evidente “eredità” del filosofo francese, almeno per come la concepisce, nella lettura radicale che fa del suo pensiero, Simone Regazzoni, autore del recente Jacques Derrida. Il desiderio della scrittura (Feltrinelli, pagine 140, euro 14). Il libro, pur attraversando molta parte del pensiero del filosofo francese, almeno quella più teoretica, non vuole essere un’introduzione ad esso: non perché di fatto non finisca per esserlo ma perché pensare all’opera derridiana come un corpus da afferrare col pensiero significa non comprenderne la portata destabilizzante per ogni idea di definizione o senso circoscritto e compiuto.
I più evidenti traditori di Derrida sono allora, per Derrida stesso, come opportunamente Regazzoni ricorda, proprio i decostruttivisti, cioè tutti coloro (e sono stati tanti) che nei più disparati ambiti delle scienze umane si sono appropriati della “decostruzione” e ne hanno fatto una teoria, un metodo e uno stile definiti. La decostruzione va concepita invece come una pratica di scrittura, è anzi la scrittura, che non porta e non può portare da nessuna parte per sua intima costituzione. Ecco allora che, agli occhi di Regazzoni, non è la decostruzione il centro del pensiero derridiano ma proprio il desiderio della scrittura richiamato nel sottotitolo del suo libro. Il che è da intendere nel doppio senso di una voglia irrefrenabile di scrivere e anche in quello di desiderare la scrittura in sé, nel suo essere l’oggetto più enigmatico, e perciò più umano, che nel mondo ci è dato incontrare.
Per provare a capire, almeno un po’, cosa fosse la scrittura per Derrida, il senso che essa aveva per lui, ci conviene andare per gradi e far finta, tanto per cominciare, di ignorare che essa fosse per lui il centro di tutto proprio perché non aveva un centro, né un “essenza”, né un senso (e che porsi queste domande significava porsi all’interno proprio di quel pensiero logocentrico, cioè il pensiero occidentale, che egli voleva destrutturare). Generalmente, noi siamo portati a intendere la scrittura come l’ultimo atto di un processo che inizia nel pensiero, si traduce in parole e lascia una traccia scritta sulla carta o su qualsiasi altro possibile medium (oggi anche virtuale). Se la scrittura non ci soddisfa, in questo ordine di ragionamento, è perché essa non ha saputo tradurre fino in fondo il senso dei nostri pensieri. Che è un po’ l’idea di Martin Heidegger per cui il senso dell’essere esiste ma il nostro linguaggio attuale, basato sulla “semplice-presenza”, non è in grado di esprimerlo: un senso che, per lui, è stato perso nel corso della storia occidentale e che va recuperato (con un processo che però è nelle mani dello stesso Essere più che nelle nostre, tanto che egli usa termini come “attesa”, “ascolto”, “abbandono”, e dice che “solo un dio potrà salvarci”).
La scrittura così come la concepisce invece Derrida è prima di tutto archi-scrittura, cioè qualcosa che viene prima, che precede logicamente il nostro stesso scrivere e che è l’origine, l’arché, di ogni cosa (e anche qui fingiamo di ignorare che un arché in verità per Derrida non si dà mai). Come può essere? Come è da intendersi questa vera e propria inversione logica? Intanto osserviamo che anche nella nostra concezione semplicistica della scrittura, lo scrivente è come se si sdoppiasse ed esteriorizzasse, lasciando una traccia fisica di un sé che è per sua natura “spirituale”, cioè immateriale. Ora, a ben vedere, questo sdoppiamento è all’opera in continuazione in tutta la nostra vita, in cui un tracciante e un tracciato, uno scrivente e uno scritto, un’anima e un corpo, non possono darsi mai in modo separato. Più radicalmente, l’io stesso è un due prima di essere un uno: io posso definirmi un individuo solo perché mi oppongo agli altri individui, di cui ho bisogno perché senza di loro io stesso non sarei. Ne ho bisogno, ma io né posso annullarmi in loro né posso annullare loro in me. L’amore, col suo tendere all’amato e col ritornare sempre a sé stessi (c’è qualcosa di egoistico anche nell’amore più puro), è un esempio palpante di questa tensione. Questa spaccatura, di cui la scrittura originaria è traccia, si riproduce per Derrida in ogni ambito e momento della vita: io e l’altro, l’altro e io, lo scritto e lo scrivente. Ogni tentativo di ridurre ad uno è sempre fallimentare. Non si può ridurre né tutto a Dio né tutto all’uomo. La spaccatura è originaria, come aveva intuito l’“oscuro” (anche lui!) Eraclito, che aveva riposto l’origine di ogni cosa nel fuoco (la cui immagine ritorna spesso nel pensiero di Derrida). Voler ridurre a logos, a senso, a essenza, qualsiasi cosa, significa tradire questa costitutiva ambiguità, o meglio dualità del mondo o dell’essere. A cui si corrisponde scrivendo, cioè lasciando nel mondo una nostra traccia e essendone sempre insoddisfatti pur sapendo che la soddisfazione che ci dà l’unità è irraggiungibile e fallace.
La decostruzione non è che questa pratica dello scrivere e riscrivere, del cercare una pienezza che non si dà. La decostruzione come lo scrivere non approda a nulla, non può e non deve approdare a nulla. Essa è un esempio probante del nostro modo fallace di pensare: è, per Derrida, la separazione che noi continuamente compiamo fra la parte corporea di noi stessi e quella spirituale, fra l’alto e il basso, fra momenti e momenti del nostro vissuto. Il desiderio di una autobiografia completa (Regazzoni parla più propriamente di un “auto-immuno-bio-grafia”), o di un “diario totale” (dai vaghi echi borgesiani), percorre l’opera del filosofo francese, che si chiede in un’intervista contenuta all’interno di un documentario (che alla luce di quanto detto non può essere considerata una parte minore della sua vita-opera) perché i filosofi non abbiano parlato mai del loro privato, “della loro vita sessuale. Qual è la vita sessuale di Hegel e Heidegger. Perché è qualcosa di cui non parlano. Ho voglia che parlino di ciò di cui non parlano. Perché questi filosofi si sono presentati come asessuati nella loro opera? Perché hanno cancellato la propria vita personale? Perché non hanno mai parlato della loro vita privata? Quando dico ‘sessuale’ dico privato, vita privata, e non c’è niente di più importante nella vita privata dell’amore, del rapporto sessuale”.
In un’altra occasione, Derrida si propone di essere “il solo filosofo a mia conoscenza che accolto – più o meno- nell’istituzione accademica, autore di scritti più o meno legittimi su Platone, Agostino, Cartesio, Rousseau, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Benjamin, Austin, avrà osato descrivere il proprio pene, come promesso, in modo conciso e dettagliato”. Lasciamo stare in questa sede tutti i complessi richiami, anche alla pratica della circoncisione ebraica, che sono presenti e resi espliciti in queste affermazioni e nell’opera intera di Derrida. Quel che mi preme sottolineare è che l’autore che nella sua radicalità, e nell’ispirazione ultima del suo pensiero, è da considerarsi più affine al nostro è Soeren Kierkegaard. Uno dei tanti meriti del libro di Regazzoni è quello di rimettere in primo piano proprio questa discendenza ideale, affermata a chiare lettere da Derrida stesso ma spesso fraintesa o ignorata dai suoi interpreti. Era stato infatti il pensatore danese a insistere in pieno Ottocento sulla singolarità di ogni uomo, sull’irriducibilità del “singolo” ad ogni essenza o concetto. Un’idea che avevano poi fatto propria, come base del loro pensiero, gli esistenzialisti nel Novecento.
Derrida, che si era formato in un ampiamente legato in senso lato alla filosofia dell’esistenza, può a sua volta essere considerato, con un po’ di azzardo, un esistenzialista, seppur eccentrico e radicale. “È a Kierkegaard – egli dice in un’intervista con Maurizio Ferraris (suo allievo a Parigi come, d’altronde, Regazzoni stesso) – che sono stato più fedele, e che mi interessa di più, se si può dire una cosa tanto semplicistica: l’esistenza assoluta, il senso che dà alla parola soggettività, la resistenza dell’esistenza al concetto o al sistema, è qualcosa a cui tengo assolutamente e a cui non posso nemmeno pensare che non si tenga. È solo a questo che si può tenere, anche se, allora, non si tiene nulla. Lo sento molto vivamente, ed è in nome di questo che mi muovo in continuazione. In fondo, anche quello che taluni hanno potuto interpretare come una riduzione della filosofia alla letteratura, come una maniera di ridurre il filosofico al letterario, risulta da quel gesto”. Un gesto che continua a produrre effetti.
Corrado ocone, Il Dubbio 7 novembre 2018