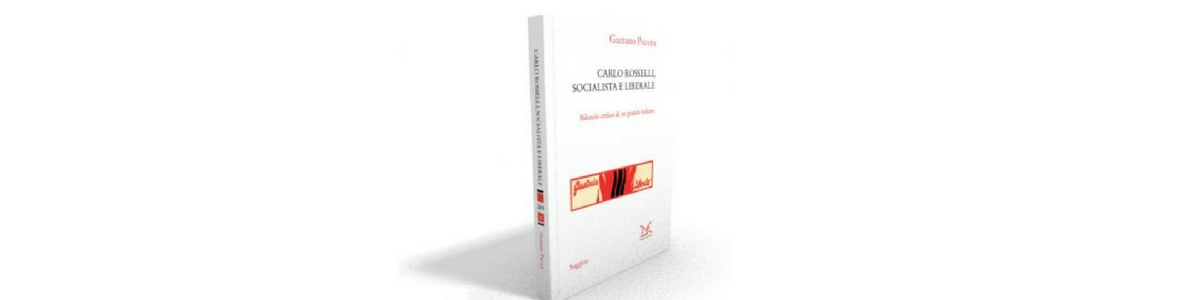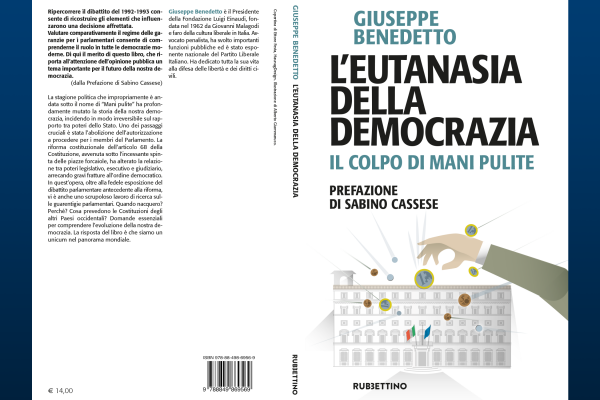Strana assai la monografia che Gaetano Pecora ha dedicato a Carlo Rosselli (1899-1937), appena pubblicata da Donzelli nella sua collana di “saggine” (Carlo Rosselli, socialista e liberale. Bilancio critico di un grande italiano, pagine 224, euro 19).
Strana assai, certo, per lo stile di scrittura dell’autore, barocco e pieno di ornamenti più che di succosa sostanza. Ma strano soprattutto perché vorrebbe essere un “bilancio critico”, ma finisce per suonare il de profundis del suo pensiero. Il quale, nonostante i “salti mortali” compiuti da Pecora, e qualche contraddizione intrinseca di troppo, ai parametri del liberalismo, generalmente parlando, non corrisponde affatto.
Certo, gli inizi einaudiani avevano sempre tenuto a freno, negli anni venti, i conati collettivisti di Rosselli. Certo, Socialismo liberale, l’opera-manifesto del 1929, contiene una critica radicale del marxismo inteso come determinismo e arriva ad anteporre la libertà alla giustizia.
Certo, ancora, qua e là, dopo quella data, è possibile rintracciare qualche eco delle giovanili idee liberali, ma fatto sta, come Pecora scrive nell’introduzione, che quello del ‘29 “è il libro di accompagnamento che lo trasporta verso un’altra riva sulla quale dalla metà degli anni trenta esploderanno con fragore di novità tali trasformazioni e tali mutamenti che il critico guarda al suo iniziale liberalismo come attraverso un cristallo screziato”.
Da quel momento è tutto un crescendo di proposte di socializzazione intesa, come Pecora mostra, sic et simpliciter, come nazionalizzazioni: della grande agricoltura e industria, ma poi anche sempre più delle piccole attività persino artigianali.
Nella teoria di Rosselli la proprietà privata tende a scomparire e ad essere così limitata nella propria azione da non poter certo più essere definita tale. Lo Stato assume un ruolo sempre più pervasivo e Rosselli, pur consapevole dell’esistenza e critico dell’universo concentrazionario sovietico, arriva addirittura a scrivere che un qualsiasi sistema socialista, anche il più liberticida, è sempre meglio del nostro asfittico e capitalistico.
La stessa tanto decantata, dagli interpreti compiacenti, “economia a due settori”, finisce per essere in lui una economia per una parte, la maggiore, sotto il controllo dello Stato, e per l’altra, sempre più piccola, affidata a piccoli proprietari in autogestione e concessione. Ma questo solo in una prima fase, visto che per comunisti e socialisti, secondo Rosselli, il metodo è diverso, il fine, cioè la socializzazione dei mezzi di produzione e distribuzione, è lo stesso.
Pecora, che pur rimane da parte sua fermo al mito azionista della libertà che deve conciliarsi con la giustizia (laddove trattasi invece di principi che agiscono su piani completamente diversi), è costretto alla fine ad ammettere che l’attivo di Rosselli, così come emerge dal suo “bilancio critico”, è ben poca cosa da un punto di vista teorico.
A nulla vale, aggiungo io, da questo punto di vista, attenuare, come Pecora fa, il giudizio storico con la “durezza dei tempi” che imponevano scelte nette, con il fascismo che premeva da ogni lato e attentava alla vita di chi li si opponeva, con la contemporanea “corsa” a chi fosse più di sinistra e più rivoluzionario nel socialismo e nell’antifascismo italiani (e non solo italiani) di quegli anni.
A nulla vale perché, pur in quella tempesta europea, ci furono intellettuali che tennero ben ferma la barra dell’antitotalitarismo nelle due versioni allora trionfanti, di destra e di sinistra, senza asimmetrie (anche perché essi avevano un origine comune). E a nulla vale perché la bontà delle intenzioni si deve concedere a tutti, fino a prova contraria, non solo a Rosselli ma persino a molti fascisti.
Il fatto è che Rosselli non era propriamente un pensatore, ma un uomo di azione. Per di più impegnato in battaglie dure e cruente. La mobilità estrema delle sue idee andrebbe considerata perciò sotto questo aspetto prima di tutto. Dimenticando, se possibile, quelle “coloriture” ideologiche che, nel secondo dopoguerra, un’Italia alla ricerca di “padri nobili” e di un’ideologia di riferimento (quella antifascista, per l’appunto) si meritò di edificare.
Tutto preso dalla teoria, Pecora afferma poi che la spiegazione ultima della nonchalance, diciamo così, con cui Rosselli da liberale si fece socialista anticapitalista, si deve ascrivere a un altro dei suoi maestri di gioventù: quel Croce che aveva slegato la libertà da ogni concreto ordinamento giuridico ed economico, facendola essere metodo e non sistema, spirito e non materia.
L’autore di queste pagine è consapevole di essersene uscito con un paradosso, essendo Croce stato un liberale conservatore e per di più molto critico delle “accozzaglie” di concetti proprie del pensiero di Rosselli.
Pure, piuttosto che paradossale, la tesi di Pecora sembra a me bizzarra e surreale: sia perché ferma a una lettura del rapporto che in Croce si instaura fra liberalismo e liberismo che la storiografia più recente ha smontato radicalmente; sia perché, fatta astrazione della teoria, in pratica Croce fu uno strenuo difensore della proprietà privata, delle libertà occidentali e (quasi sempre) della libera iniziativa privata.
Fatto sta, in ogni caso, che il libro di Pecora è un’opportuna base per una discussione senza infingimenti sui presupposti (ahimè non liberali) di molta cultura e dell’“ideologia italiana”.
Corrado Ocone, Formiche