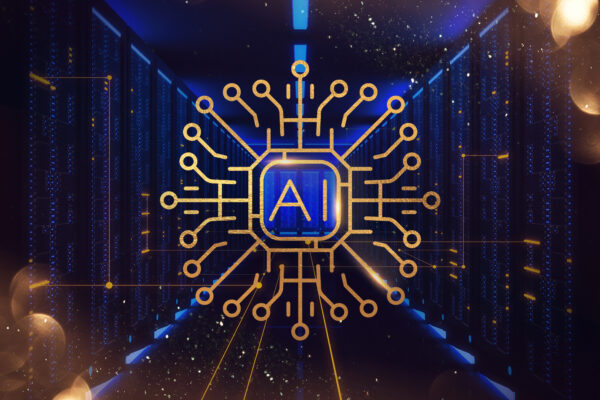Lo Stato è una costruzione artificiale, il dispositivo di potere per antonomasia dell’età moderna. Esso è una “finzione”, un “costrutto mentale”, che ha, rispetto agli individui che lo fanno essere, essi sì concreti uomini in carne ed ossa, un fine strumentale: nasce per servire i loro obiettivi non per “entificarsi” e anteporsi ad essi come fine in sé. In ogni momento gli individui che lo hanno messo in essere possono farlo morire se esso non serve più ai loro fini.
Allo Stato tutto è permesso, avendo il monopolio esclusivo e “legittimo” della forza sul territorio di sua competenza, ma solo in vista del raggiungimento di certi fini prestabiliti e “contrattualizzati”, solo come “mezzo per”. L’estensione di questi fini extrastatali si allarga sempre di più man mano che ci si sposta dalle concezioni assolutiste a quelle liberali dello Stato. Anche però nella forma paradigmatica delle prime, quella che si trova nel Leviatano di Hobbes, lo Stato ha come fine quello di garantire e preservare la vita dei suoi cittadini la qualità della cui vita non spetta a lui giudicare. Lo Stato, cioè la legge, non può perciò in nessun caso mettere a morte un suo cittadino innocente, neanche per il “suo bene”. Chiunque viva sotto la sua potestà, semplicemente in quanto uomo e in quanto tale degno di vivere, deve sentirsi garantito in questo principio assoluto che è la sua vita.
Lo sviluppo della medicina mette sempre di più oggi di fronte a situazioni limite in cui un individuo che ha perso coscienza non è in grado di decidere se accettare o meno il cosiddetto “accanimento terapeutico”: è una situazione che, fermo restando il principio che non può essere lo Stato a decidere in sua vece, si è tentato di regolamentare, con tutti i limiti del caso, con il cosiddetto “testamento biologico”.
Quella del “testamento” potrebbe anche essere considerata una scelta saggia, non limitandosi ad altro lo Stato se non a certificare una volontà acquisita precedentemente. Essa però di fatto si accompagna a tutta una retorica sulla “vita che è degna di essere vissuta” che di fatto pone la scelta di vita e quella di morte su un piano asimmetrico di accettazione sociale.
Lo Stato da artificio nato per garantire la vita, dovrebbe per alcuni convertirsi in dispensatore di morte. Si badi “garantire la vita”, non “una vita degna di essere vissuta” o “normale”, le cui caratteristiche nessuno, men che meno lo Stato, può arrogarsi il diritto di definire per gli altri.
Il caso di Alfie, da questo punto di vista, è alquanto diverso: l’individuo non era in grado di giudicare non per aver perso coscienza ma per non averla ancora acquisita in quanto in tenerissima età. Chi doveva decidere per lui? Lo Stato o le persone più prossime e preposte ad allevarlo, cioè i suoi genitori?
Poiché nelle nostre società i figli non vengono sottratti ai genitori e affidati all’educazione in comune come nell’antica Sparta, mi sembra evidente che fra la volontà dello Stato, o dei medici di un ospedale, e quella dei genitori, sia quest’ultima a dover prevalere.
Certo, i genitori si possono dimostrare non all’altezza, come dice Laura Zambelli Del Rocino, ma, a parte che non era questo il caso dei genitori di Alfie, lo standard comportamentale non può certo essere deciso da un’entità terza ed astratta che è nata solo per garantire la vita di chi è ad essa sottomesso e che comunque non può stabilire a priori, in base a inesistenti canoni “oggettivi” o “scientifici”, se il livello di vita di un essere umano debba considerarsi o meno appropriato.
Mi sembra che, così posta la questione, da un punto di vista liberale non possano esserci dubbi su chi spettasse la decisione nel caso di Alfie, e soprattutto a chi non spettasse proprio. Lo Stato dovrebbe tenersi lontano il più possibile dalle decisioni di coscienza o che pertengono all’ambito etico, semplicemente perché non è nato per questo.