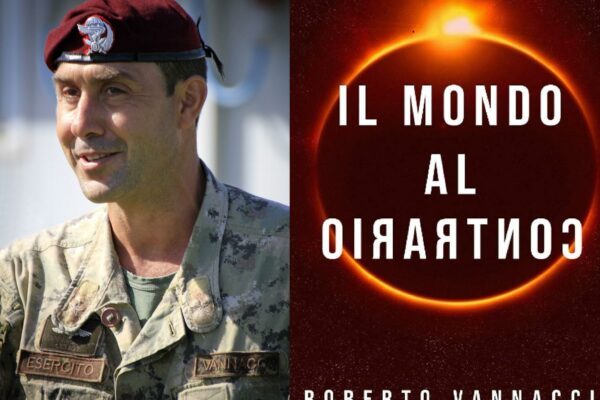La melmosa marea del pregiudizio antimonarchico
Sono più d’uno gli spettri che animano il background politico-culturale di questa Repubblica, costituendone così il piedistallo emotivo di massa con la sua sedicente coscienza democratica: dall’ingombrante passato coloniale alla vittoria del novembre 1918, pur essa da dimenticare in quanto prodromica all’avvento del fascismo, dalle complicità della Corona nell’ascesa al potere di Mussolini all’adozione delle leggi razziali od anche all’ingresso in guerra dell’Italia nel ‘40, dall’invadente peso di ignorati eroi e caduti, solo stracci senza memoria ingoiati dall’oblio, al mito dell’Italia tradita dal suo Re, dallo psicotico attaccamento all’insegna resistenziale e antifascista all’irremovibile preconcetto nei confronti di Casa Savoia. Questi, insieme ad altri “lemuri”, rappresentano la palude ideologica su cui si fonda l’istituzione repubblicana del nostro Paese! E’ questo l’universo mitologico della nazione, centrato su una aberrante volontà di conquista della storia contemporanea come campo di azione in cui rigenerare, sulle ceneri del Regno, del fascismo e di una guerra perduta, una “nuova civiltà” – con il suo triste apparato di mortifere, sordide ideologie – che, con i suoi rituali di cartapesta e la sua falsa democrazia, ha relegato al “ridotto della Valtellina” i valori liberali e nazionali.
Il decesso del Principe Vittorio Emanuele di Savoia, recentissimamente avvenuto, ha infatti rappresentato, ancora una volta, l’occasione per esternare – e non soltanto da parte di una storiografia falsata da pregiudizi ideologici perlopiù di parte marxista, ma anche di quella più moderata, pur incline a rivedere la storia d’Italia non in chiave ideologizzata – tutto il livore antimonarchico che ancora impregna in generale questo Paese, impedendo in tal modo una più scrupolosa e meno sbrigativa storicizzazione della Monarchia sabauda – e in particolare della figura del Re Vittorio Emanuele III – relegata pressoché esclusivamente al periodo risorgimentale o poco più, che valga invece a riposizionarla più correttamente nel suo composito e astruso contesto storico, durato oltre un settantennio dopo la conclusione del processo unitario, su un asse temporale crono-centrico di elementi fattuali altamente drammatici nella cruda realtà in cui essi ebbero ad estrinsecarsi.
Insomma, la vulgata antimonarchica tuttora in auge è diventata una sorta di “sceneggiata veneziana”: una messinscena supremamente autolesionista, anche esteticamente scadente oltre che storicamente inattendibile. Essa, confinando l’Istituto monarchico esclusivamente alla tradizione e ascrivendo semmai – il che peraltro non è neppure certo, dato che ricorre troppo spesso anche il termine “usurpazione” – a Casa Savoia l’unico merito della unificazione del territorio italiano, bypassa a piè pari tutto il travaglio postrisorgimentale: dalle guerre coloniali, viste soltanto come manifestazione della volontà di potenza dei Savoia, al primo conflitto mondiale, dall’avvento del fascismo, grazie alla presupposta complicità della Corona, alla nuova guerra mondiale e alla “fulgida” nascita della Repubblica, autolegittimatasi come “vero inizio” della Storia d’Italia.
Cosicché, invece di sollevare un reale, enorme problema di coscienza collettiva su fatti storici che avrebbero dovuto costringerci a rimeditare – e quantomeno dovremmo farlo ora – e ad instaurare una discussione storica da sostanziarsi in una robusta ispirazione etica, si è verificata, e continua tuttora a verificarsi, solo una reazione isterica che, in svariati casi, sfiora i toni della denuncia e del linciaggio, basati su luoghi comuni e affermazioni liquidatorie e diffamatorie da parte di una pubblicistica manichea, demagogica, cinica e settaria.
Il fatto è che aver consegnato, in Italia più che altrove nell’area euro-atlantica, sic et simpliciter la storia agli storici “puri”, perlopiù poco attrezzati sotto il profilo giuridico-istituzionale, ha avuto come conseguenza da un lato di trasformarli – per così dire – in “filosofi” politicizzati e ideologizzati, dall’altro lato di conferire al ridondante dibattito storiografico elevati accenti retorici e spesso proposizioni tautologiche; in alcuni altri casi, i caratteri veri e propri solo di una histoire événementielle, una storia degli avvenimenti quasiché cronachistica e giornalistica. Pertanto, il patrimonio culturale nazionale, privo di un progetto che sia andato al di là della pura contemplazione della propria storia, peraltro in chiave fortemente ideologica, è stato – e lo è tuttora – del tutto incapace di analizzare saggiamente il proprio passato in funzione del proprio futuro. L’esito di tutto ciò è che la funzione sacerdotale, perlopiù eterodiretta, della stragrande maggioranza degli storici italiani ha finito per prevalere sulla quella scientifica, cosicché alla mansione di “scribi della nazione” hanno aggiunto quella di “scribi del potere”, soprattutto se il potere per cui lavorano coincide con il proprio.
Ma i “fantasmi” della Repubblica si sono materializzati oltre che sul piano dell’esegesi storica anche sul piano costituzionale, dato che i “Padri costituenti” hanno ritenuto di inserire tra i principi supremi di uno strampalato impianto costituzionale – frutto di un compromesso altamente deteriore tra le forze dell’esarchia ciellenistica – quelli che non possono essere modificati neppure dalla volontà popolare, in quanto ritenuti superiori alla altre norme di rango costituzionale, cioè la impossibilità di revisione della forma repubblicana dello Stato, così come statuito dall’articolo 139. Insomma, esisterebbero così due livelli della Costituzione o, se si vuole, “due Costituzioni”: una rappresentata dai precetti costituzionali contenuti nella Carta, un’altra costituita dai principi fondamentali che ne sarebbero alla base e che avrebbero carattere di intangibilità. Ed allora esistono diversi livelli di efficacia giuridica? Ma tutta la Carta non ha la medesima efficacia?
Se i principi morali sono intoccabili, che senso ha accostare agli stessi la forma di governo repubblicana, sancendo pure per questa la intoccabilità? E non appare fortemente riduttiva, e in grado di falsare i contenuti della Carta Costituzionale, l’identificazione dei valori morali della Costituzione con il richiamo alla forma repubblicana e il conseguente divieto dell’introduzione dell’Istituto monarchico? Pur volendo accogliere l’obiezione che un nuovo referendum in merito non sarebbe ammissibile per la presenza di un esplicito referendum istituzionale antecedente alla stessa Costituzione, quale necessità era da ravvisarsi nell’includere tra i principi fondamentali un articolo ad hoc, visto che la Corte Costituzionale avrebbe sempre avuto la possibilità di bocciare ogni eventuale successiva iniziativa referendaria, fermo restando che non è affatto sancito alcun divieto di sottoporre a nuovo referendum una normativa già oggetto di quesito referendario?
Questi inquietanti interrogativi, unitamente ad altri temi altrettanto problematici riferiti a fatti salienti di quel periodo, sarebbero da consegnare una volta per tutte alla Storia e da approfondire senza paraocchi ideologici!
Non v’è chi non veda, invece, come la formulazione dell’articolo in questione sia scaturita soltanto da una irriducibile avversione nei confronti della Monarchia da parte dei così detti “Padri della Patria”, ai quali ben si attaglia ancora il giudizio formulato da Gaetano Salvemini e riportato nel precedente “LE STANZE DI UN PAESE OSCURO”, una immotivata ostilità, tuttora sussistente, sulla base di una – mai dimostrata, se non con argomentazioni faziose e irrazionali – connivenza costante della Corona con il regime fascista.
Ed è proprio questa presunta complicità alla base delle aberranti esternazioni mediatiche e storiografiche di cui si diceva innanzi, con particolare riferimento a due questioni essenziali: 1) il “colpo di Stato” del 28 ottobre 1922 posto in atto dal Re nel rifiutare la firma del decreto relativo allo stato d’assedio proposto dal Governo e l’affidamento a Mussolini, capo di un partito di minoranza, dell’incarico di formare un nuovo governo; 2) il mancato rifiuto, da parte del Sovrano, di controfirmare le infami leggi razziali del 1938.
Ma prima di addentrarci nella disamina, seppur succinta, degli avvenimenti in discorso, occorre brevemente delineare i caratteri del costituzionalismo sabaudo, soprattutto alla luce dei suoi successivi sviluppi, onde non cadere nella trappola del qualunquismo storiografico avulso da basi concrete di certezza ordinamentale.
Di certo, lo Statuto Albertino del ‘48 caratterizzava una forma di governo costituzionale pure monarchica, dato che il Re, in qualità di Capo dello Stato, aveva il potere di nomina e di revoca di ministri, ancorché, temperando però siffatto principio, fosse previsto anche l’istituto della controfirma ministeriale. Però, il contemporaneo meccanismo della fiducia parlamentare al governo, che pur godeva della fiducia del Re che lo aveva nominato, di fatto affievoliva i poteri del Sovrano, e questo a maggior ragione a partire dal 1901 a seguito dell’emanazione del Regio Decreto Zanardelli, che ampliava le attribuzioni ministeriali. Insomma, la forma di governo da costituzionale pura si stava gradatamente trasformando – anche e soprattutto per volere del giovane Re Vittorio Emanuele III, succeduto al padre Re Umberto I, assassinato nel 1900 ad opera dell’anarchico Bresci – in costituzionale parlamentare, in una Italia liberale e democratica.
E’ alla luce di siffatta situazione istituzionale, che comunque traeva la sua origine pur sempre dallo Statuto, che occorre approfondire la vexata quaestio del 28 ottobre 1922 – stigmatizzata senza scampo da una menzognera e avversa letteratura – sia sotto il profilo della opportunità politica del momento sia con riguardo alla legittimità dell’azione del Sovrano, tenuto conto del quadro giuridico-normativo in atto.
Quanto all’aspetto della legittimità dell’operato del Re dunque, questi, nel rifiutare la firma del decreto relativo allo stato d’assedio proposto dal governo Facta, che peraltro si dimetteva, e nell’affidare a Mussolini l’incarico di formare un nuovo governo, avrebbe così violato la norma consuetudinaria – gradualmente instauratasi a seguito della progressiva trasformazione in Monarchia costituzionale parlamentare – che non gli consentiva di rifiutare la emanazione dei decreti di emergenza presentati dal governo e di affidare al capo di un partito di minoranza l’incarico della formazione del nuovo governo. Tutto ciò si risolve in un infamante giudizio di immoralità e in un anatema permanente in capo al Sovrano, nel mentre, invece, la questione abbisogna di più esaustive valutazioni tenuto conto del fatto che le norme consuetudinarie – le quali, nella gerarchia delle fonti del diritto oggettivo, si pongono sott’ordinate alle Leggi, formali o materiali, e ai Regolamenti – hanno valore, relativamente all’aspetto dell’efficacia giuridica, quando siano espressamente richiamate dalla legge o perlomeno in assenza di norme di legge che regolino la materia de qua.
La domanda fondamentale che si pone è quella di vagliare se il Sovrano, nel porre in atto le azioni anzidette, abbia agito sine titulo, per cui in tal caso avrebbe sì violato una norma consuetudinaria – che, dunque, sarebbe dovuta essere l’unica vigente in quel momento – ovvero si sia avvalso di qualche norma giuridica di ben più elevata efficacia a fronte di quella violata. Ebbene, lo Statuto del Regno, all’epoca vigente, non prevedeva espressamente, nell’ambito dalla forma di governo costituzionale pura, all’articolo 65, la nomina e la revoca dei ministri da parte del Re? Vittorio Emanuele III si era appunto riappropriato a pieno titolo – sebbene, come si avrà modo di vedere, solo per un brevissimo lasso di tempo – della sua primigenia funzione costituzionale. Infatti, avendo già deciso da tempo che la sua sarebbe stata una Monarchia costituzionale a indirizzo parlamentare, pretese subito che il nuovo governo di Mussolini – in cui erano comunque presenti soltanto tre ministri fascisti – dovesse presentarsi alle Camere al fine di ottenerne la piena fiducia.
La Camera, infatti, approvò con la larga maggioranza di 306 voti favorevoli – azionisti, liberali e popolari – e 116 contrari, solo quelli dei socialisti, conferendo altresì i pieni poteri al nuovo governo per sei mesi.
Acclarata così la totale legittimità dell’azione del Sovrano, vari erano i motivi di opportunità politica, di certo non infondati, ravvisati da Re in quei particolari momenti, atteso che dal 1920 aveva preso avvio il così detto “biennio rosso”, contraddistinto da atti di eversione violenta di masse operaie, che anelavano ad instaurare in Italia il principio dei Soviet. In definitiva, la preoccupazione del Sovrano – convinto anche di poter dar vita ad un “compromesso” controllabile tra la Corona e il fascismo – fu quella di scongiurare una inevitabile guerra civile e spargimenti di sangue e l’esigenza di assicurare la continuità dello Stato, stanti anche i dubbi sulla totale fedeltà dell’esercito, come rappresentatigli dallo stesso Generale Diaz: infatti, era noto che molti ufficiali e generali simpatizzavano per il fascismo. Insomma un più che plausibile coacervo di elementi fattuali che avrebbero dissuaso chiunque dall’intraprendere azioni di forza dagli esiti imprevedibili.
Delineata così nei tratti essenziali la condotta del Sovrano nella vituperata vicenda dell’ottobre del ’22, giova svolgere qualche considerazione in merito alla questione delle cretine leggi razziali, che presero avvio nel luglio 1938 con la pubblicazione del “Manifesto della Razza”, firmato da pur importanti scienziati, leggi che il Re assolutamente non voleva, che minavano anche gli oramai cordiali rapporti con il mondo cattolico.
Il Sovrano più e più volte rappresentava al Duce la gravità del male che stava arrecando al Paese – né erano d’accordo tutti i gerarchi, specialmente Italo Balbo, che mostrava apertamente il suo dissenso – e per ben tre volte Vittorio Emanuele III rifiutò di controfirmare le leggi infami; alla fine, però, da Sovrano costituzionale parlamentare, a fronte del voto quasi unanime del Parlamento, non potendo fare null’altro, dovette cedere.
Certamente il Re, in forza della già richiamata norma statutaria di cui all’articolo 65, avrebbe potuto rimuovere Mussolini dall’incarico di Capo del Governo, dando così avvio ad una crisi istituzionale, ma con gravissime conseguenze poiché Mussolini, date anche le sue mai venute meno inclinazioni antimonarchiche atteso che il Sovrano era visto come un ostacolo alla agognata instaurazione dello Stato Totalitario, avrebbe chiamato a raccolta il popolo, Vittorio Emanuele sarebbe stato detronizzato in quattro e quattr’otto e il Duce sarebbe stato acclamato entusiasticamente Capo dello Stato, ciò che era già avvenuto nella Germania nazista.
Insomma, il pur imperfetto sistema diarchico sarebbe stato completamente spazzato via e il Paese si sarebbe trasformato da dittatoriale in Stato totalitario, atteso altresì che in quei momenti il regime, che si gloriava della fondazione dell’Impero avvenuta da poco, si trovava, anche a livello internazionale, all’apice del consenso generale, mentre in buona parte dell’Europa si stava attuando un grande “pogrom” antiebraico.
L’unico responsabile delle leggi razziali, dunque, era soltanto Mussolini. In prosieguo, però, con il volgere disastroso delle vicende belliche, sarà proprio il Re, impossibilitato in quei momenti ad agire ma deciso da tempo a liquidare il fascismo, ad assumere una funzione da protagonista. Infatti, a seguito del deliberato del Gran Consiglio del fascismo – che, per effetto della sua costituzionalizzazione voluta proprio da Mussolini, si presentava come unico organo valido a sostituire il Parlamento, impossibilitato a funzionare – il quale, nella notte del 25 luglio del ’43, aveva approvato l’Ordine del Giorno proposto da Dino Grandi, Presidente della Camera e ministro guardasigilli, l’altro grande personaggio protagonista della vicenda, il Sovrano, riassunte le sue funzioni statutarie, decreterà la fine del regime. Nel ’39, nell’affidare appunto tale incarico a Grandi, il Re così si esprimeva: “La trincea di difesa è lo Statuto e la Costituzione che presto o tardi dovrà tornare a funzionare in tutta la sua piena e assoluta interezza”. Fu questa la sua predizione avveratasi poi di lì a poco!
I due personaggi, finiranno per diventare, così come è stato scritto, “prigionieri della loro stessa solitudine” e avranno un destino comune: la sera del 9 maggio 1945, per Vittorio Emanuele III inizierà un breve viaggio per l’esilio in terra d’Egitto, dove, sempre col pensiero rivolto all’Italia, vivrà solitario nel ricordo di eventi che non sempre e non del tutto era riuscito a controllare. Poco meno di tre anni prima, era stato preceduto dal triste, avventuroso volo dell’ultimo aereo partito per Siviglia, tra caccia tedeschi che, insospettiti, cercavano di intercettarlo, aereo che aveva trasportato Dino Grandi, l’altro grande protagonista di quegli eventi.
Ma la storia della tragica vicenda della fine del fascismo, impossibile da essere contenuta in uno scritto che ha diversa finalità, è tutta un’altra storia – peraltro già approfondita in precedente lavoro anche con riguardo agli aspetti istituzionali – che necessiterebbe, da parte della storiografia ufficiale, di ben più accurata analisi e di appropriata ricostruzione, ma che non sia quella oggetto, da ultimo, di una fatua riduzione cinematografica ad usum populi, con personaggi quasi da “operetta triste”, a tratti anche fantasiosa e macchiettistica, o se si vuole, talora anche involontariamente comica se non avesse riguardato la storia più tragica del nostro Paese.
Di certo, Vittorio Emanuele III, con il suo alto il senso della Stato e il dogma dell’assiduo rispetto delle regole parlamentari, si trovò a regnare nei momenti più drammatici della storia d’Italia, talché il suo operato, e in genere quello della Monarchia sabauda, con la sua attitudine indiscutibilmente liberale anche durante il regime fascista, meriterebbe ben altra attenzione storiografica e non una perenne “escursione turistica” nella galleria degli orrori condotta da ciceroni fabbricanti di “bolle di sapone” terroristiche, saccenti e irritanti. Non sarebbe un reflusso ideologico, ma una doverosa coscienza di forgiare una formazione storica collettiva.
Francesco Giannubilo, laurea Scienze Politiche ed ex dirigente della P.A., si occupa di studi storico-politici dell’età contemporanea. Pubblicista su testate provinciali e su “l’Opinione delle Libertà” nazionale, dopo la ricerca “Aspetti della politica italiana 1920-1940” (2013), il saggio “DALLA DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA ALLA DEMOCRAZIA LIQUIDA (O LIQUEFATTA?)” (2015).
Ha pubblicato: “L’ITALIA CHE (NON) CAMBIA (2010), assieme di considerazioni etico – politiche sull’impossibilità del riformismo in Italia; “1848-1870 IL RISORGIMENTO INCOMPIUTO” (2011), una riflessione sullo sviluppo storico in Italia in termini di continuità con il processo risorgimentale; “1939-1940 IL MONDO CATTOLICO ALLA SUA SVOLTA?” (2012), un profilo critico sugli atteggiamenti del mondo cattolico dagli inizi del Novecento fino all’entrata in guerra dell’Italia.