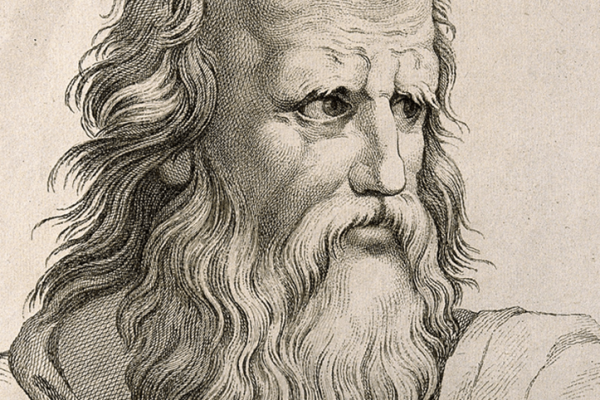Dal primo momento in cui ha potuto levare gli occhi al cielo e contemplarne le poetiche fattezze, l’umano è ammaliato dalla presenza della Luna. Non solamente fonte inesauribile di coinvolgimento emotivo e successivamente letterario, la Luna ha potuto godere di un ruolo centrale nell’elaborazione di alcuni sistemi cosmologici miranti ad ordinare il funzionamento della Terra e, possibilmente, dell’universo tutto. La scienza, un tempo, era a misura della Luna. Ancora più nello specifico, era l’umano ad adoperare un’unità di misura lunare.
Per queste motivazioni, ho optato per una titolazione come quella che figura: non analizzerò – per quanto sinteticamente – la Luna all’interno di poliedrici contesti filosofici e letterari, ma cercherò di disaminare intorno al concetto che la Luna ha rappresentato. In altre parole, mi occuperò delle varie concettualizzazioni che della Luna si sono date affinché convenissero con sistemi filosofici, letterari e cosmologici, a seconda di come essa cambiasse la sua significazione nei vari prospetti della storia della cultura umana. Dunque, ricercherò una visione dell’umano direttamente interconnessa all’influenza lunare.
In buona sostanza, è possibile tirare una linea che faccia da bisettrice tra due momenti fondamentali del concepire la Luna: se da una parte si è avuto un concetto gustosamente spirituale ed etereo, dall’altra si ha un concepimento materialistico e, direi, ciottoloso del sostrato lunare. Questa ambivalenza contraddittoria non solo esplica chiaramente situazioni diverse della cultura umana, ma evidenzia, cosa più importante, due figure dell’umano diametralmente opposte: cambiando il concetto di Luna, con tutto quanto ne derivasse cosmologicamente ed astronomicamente, cambiava l’uomo, il quale dapprima era soggetto all’influenza lunare, poi calpestava sotto i propri piedi la stessa sostanza di cui si descriveva la Luna.
Sentire sotto i propri piedi la composizione di quell’oggetto etereo e sacro non è mica qualcosa di superficiale o trascurabile: se, come si dice comunemente, è bene che si rimanga coi piedi per terra, l’inversione paradigmatica con cui si portava la sostanza lunare sotto le proprie scarpe metteva sul tavolo un umano certamente diverso da quello che alzando lo sguardo scrutava l’inarrivabile. Dopo un certo punto, non c’era, al di là della soglia, alcuna sostanza celeste o eterea che non fosse presente nel proprio mondo.
Se per Aristotele il cosmo era suddivisibile in mondo sublunare, materiale e corruttibile, e mondo lunare, etereo ed influenzante il primo, per Galilei la Luna non era che un ammasso roccioso come tanti altri, quantificabile e soprattutto osservabile con maggiore attenzione. Magari apprezzabile e comunque incuriosente, ma cionondimeno privo di qualsiasi proprietà di perfezione descritta dai sistemi cosmo-astronomici fino a quel momento. La differenza è già qui marcata, eppure il discorso certamente non si limita al geologico o al meramente astronomico, ma espande i propri confini urtando con una questione ben più complessa e stratificata: rovesciare la concezione fisica aristotelico-tolemaica ha significato far inciampare l’umano su sé stesso.
Per comprendere la potenza di questa rivoluzione, credo sia utile specificare come l’influenza lunare, o per meglio dire astrale, era sì di matrice aristotelica, ma non si è eclissata con l’avvenire del Cristianesimo. Al contrario, si è adattata alle esigenze di una nuova cultura, rimanendo sostanzialmente invariata e stagnata. Tutt’al più, veniva cristianizzato ciò che risultava eventualmente pagano – ad esempio il primo motore immobile veniva spesso e volentieri identificato come Dio (cfr. T. D’Aquino, Summa Theologiae, I,2). Di conseguenza, per il Cristianesimo medievale ed anche rinascimentale finanche al ‘700 leibniziano, il mondo lunare o metafisico influenzava il mondo sublunare alla pari di come avveniva nei sistemi di metafisica astronomica pre-cristiana. L’estensione di una dottrina del genere bisogna immaginarsela sconfinata, tanto che pure l’astronomia islamica medievale configurava l’ordine del proprio mondo attraverso le categorie tolemaico-aristoteliche. Non si trattava più di una semplice teoria sul movimento degli astri, ma più profondamente, nel suo interconnettere il mondo lunare con quello calpestato, era una immagine dell’umano resa su misura di un universo più grande di lui.
Aristotele e Galilei guardavano lo stesso cielo, ma vedevano cose diverse. Cionondimeno, non è più una questione di mere situazioni culturali differenti – di rinascimento ed epoca classica – strutturate su diverse categorie. Dall’Oriente, infatti, stava pervenendo in Occidente qualcosa che avrebbe causato, nel corso del cinque-seicento, una frattura impensabile coi paradigmi precedenti: il cannocchiale. Credo sia innegabile che l’umano abbia progredito più nell’arco del secolo rinascimentale che nel corso del millennio medievale. Puntando il cannocchiale al cielo, Galilei non ha solo consapevolmente rifondato l’universo, ma ha anche inconsapevolmente sfatto e disfatto un’umanità che dal cielo etereo era visceralmente dipendente. Pensandoci bene, che l’etereo della luna e degli astri fosse danneggiato è evidente anche sotto la letteratura di Ariosto, ben prima quindi della rivoluzione galileiana: l’ubicazione dell’incorruttibile diventa addirittura accogliente asilo per la follia umana.
Questa spaccatura dell’umanità è ben nota nell’ambito della filosofia, specie in quella scheleriana ed arendtiana: l’uomo religioso di Schiller e l’uomo attivo arendtiano diventano, successivamente all’osservazione galileiana, l’homo faber. Ovverosia, l’uomo produttore, l’uomo-affaccendato. L’umanità, attraverso gli studi di Galilei, modifica il proprio approccio alla realtà: al posto di una visione specialmente qualitativa del reale, dove la conoscenza del fenomeno risiede nel saperne l’essenza, prende piede una strutturazione quantitativa e metodologica della conoscenza. Le cose, passato Galilei, non si acchiappano più mediante l’immaginazione e l’intelletto, ma al massimo si adopera quest’ultimo perché si calcolino i numeri del mondo.
Nonostante le visioni positiviste ed i racconti manualistici intendano questo strappo paradigmatico in termini evoluzionistici e di immediata sostituzione, la verità è che all’umano il nuovo gli sta fin troppo stretto. Interpretando la storia del pensiero attraverso le categorie esistenzialiste, affiancato all’homo faber di cui sopra si è dato un altro modo dell’umanità che gli è tanto opposto quanto inevitabilmente complementare: l’homo dubitans. Sarebbe la commedia a comunicare meglio questo momento dell’umano: dinanzi all’attendibilità inopinabile del calcolo si staglia come un neo l’insopprimibile dubitabilità del tutto. Non che prima non si dubitasse, chiaramente – d’altronde si fallor ego sum –, ma il grado di dubbiezza era commisurato all’inattendibilità della conoscenza di un essere peccaminoso e finito come l’umano. Ed a prescindere, si dubitava nei confronti della conoscenza determinata di un fenomeno, che quindi poteva essere emendata, e non dell’intero – il cui senso d’altronde era di tendere alla salvazione del Giudizio Universale. Con la messa a punto di una metodologia scientifica come quella di Galilei e soprattutto con la disintegrazione di un sistema di conoscenze più che millenario, la narrazione positivista difficilmente trova ragione, e cede il passo ad una verità che espone un’umanità sconvolta e semplicemente spaesata. Dubitante, ed in un certo senso cartesiana.
Questa tesi era già ben nota ad Arendt, la quale infatti sostiene come l’«Eminente caratteristica del dubbio cartesiano è la sua universalità, il fatto che nulla, nessun pensiero e nessuna esperienza, possa sottrarvisi» (H. Arendt, Vita Activa, Bompiani, Milano, 2017, p.292); così, dunque, la realtà tutta non era stata solamente destrutturata, ma le sue fondamenta stesse erano state repentinamente riposizionate, lasciando spazio ad un’inconsistenza e liquidità imperanti.
La Luna, però, non smetteva di essere fermamente a sostegno della Terra, tanto gravitazionalmente quanto poeticamente. Non si sarebbe, insomma, mai smesso di parlare dell’esperienza lunare, ora decisamente più contestuale ai canoni estetici che alle strutturazioni sistematiche e stringenti di teoremi di filosofia naturale. Poteva imbastirsi questo o quell’altro sistema, potevano avvenire le più paradossali e catastrofiche rivoluzioni scientifiche e sociali, la Luna, nonostante tutto, rimaneva fissa lì, a contemplare il divenire spesse volte triste ed abbietto delle vite umane, ancorate ad un mondo che ad oggi gli sta davvero stretto. Nonostante l’influenza lunare non fosse più sostenuta dalla scienza, una sorta di coincidenza estatica confinante col magico avrebbe continuato ad infervorare l’animo dell’uomo, che ora avrebbe potuto contemplare il suolo lunare attraverso le categorie della nostalgia, e quindi della poesia.
Perse le velleità scientifiche, al lunare non rimaneva che essere rappresentato sotto la filtrazione della letteratura, ma in un senso ben specifico: non erano semplici odi o inni quelli mossi alla Luna, ma l’esperienza poetica tutta si configurava come una resa in metrica di quell’etereo che nello scientifico si era perso. Per questa motivazione – per quanto quella perdita di scientificità lunare ed astrale aveva scombussolato l’umano come tale –, mica può sorprenderci come la produzione poetica lunare abbia come interrogativo fondamentale la scompostezza dell’esistere umano.
Da Percy Shelley a Baudelaire, da Hugo a García Lorca, la poetica del lunare è costantemente imbevuta di una sensazione nostalgica, alternativamente decadente o incandescente a seconda dei casi letterari. La Luna, in qualsiasi contesto si ritrovi a fare da ispirazione, performa delle vesti contemplative: scruta l’andamento del divenire degli uomini e, statica nella sua presenza medusea, è spesso oggetto di interrogazioni intorno alla propria condizione miserevole. In qualche modo, è come se l’umanità, proiettando poeticamente nella luna le proprie insicurezze, tenti di rinvenire nuovamente una sorta di inerenza mistica ed astrale. Com’è noto, d’altronde, per quanto si possa riportare tutto alla fisica, la tensione naturale dell’umano è alla metafisica.
“Che fai tu, luna, in ciel?[…]
Dimmi, o luna: a che vale
Al pastor la sua vita,
La vostra vita a voi? dimmi: ove tende
Questo vagar mio breve,
Il tuo corso immortale?” (G. Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, vv.1;16-20).
La scontatezza di questa citazione eguaglia quasi la sua importanza all’interno della storia del pensiero umano. Senza gettarci in un’analisi letteraria davvero stantia ed altrettanto scontata, il passo di Leopardi incapsula tutta la potenza poetica che la contemplazione lunare possa comunicare: il poeta interroga la Luna circa una domanda vecchia quanto l’umanità stessa, ma che minimamente ha perso la sua carica nel corso del tempo – la domanda circa il senso del proprio esistere. Non solamente, la strutturazione metrica del passo propone un accostamento raffinatamente costruito tra la caducità del vivere umano e l’immortalità della presenza lunare. Porrei l’attenzione sul termine immortale, che Leopardi certamente utilizza con coscienza: ben lungi dall’essere l’eternità che dapprima descriveva la sostanza lunare, il grado ontologico del lemma usato ricongiunge l’entità lunare con l’enticità umana. Seguendo la logica, ciò che è immortale è quanto cui etimologicamente non soffre della morte, laddove l’eternità è propria di quell’essere che è sempiterno in quanto fuori-dal-tempo. In sintesi, è immortale quell’ente che, in quanto vivente, è diveniente, ma il suo divenire non comprende la morte, e la sua presenza costante è in relazione alla sua esistenza; è eterno, invece, quell’ente che esiste da sempre e per sempre sarà esistente, ma esplicita la sua presenza in relazione alla sua a-temporalità. Per esempio: eterno è Dio, in quanto non contestuale al divenire delle cose esistenti nel tempo; immortale sarebbe l’uomo se fosse stato creato privo della morte.
Con questa digressione terminologica è possibile intendere più facilmente la specificità del lessico leopardiano nel passo proposto: se aristotelicamente il mondo era eterno specie in relazione alla perfezione del moto circolare uniforme degli astri, ora è invece diveniente e caduco avendo l’astrale perso il suo velo di perfezione. Di fatti, pur conservando una sua superiorità, si degrada ontologicamente, passando dal regime dell’eternità a quello dell’immortalità.
Questa consapevolezza leopardiana è ancora più evidente in uno dei dialoghi – se vogliamo – minori dell’autore, il Dialogo della Terra e della Luna, pubblicato nel 1827. Seppure sia invero definibile minore, in quanto non comunica nulla che in Leopardi non si trovi altrove, all’interno di quest’istanza ci permette un più profondo studio del concetto lunare. In breve, all’interno del dialogo la Terra, parlando con la Luna, scopre come abbiano forse non troppe cose in comune, ma tra quelle ce n’è una a dire il vero fondamentale: la sofferenza. La Luna non avrà gli uomini né avrà alcuna forma di politica, intesa nella sua accezione spregiativa, ma, nonostante il suo popolo più educato, anche lì è presente la sofferenza – «[…]ne sono tutta piena[…]», dice.
Altroché eterea ed eterna, la Luna diventa un mero contenitore delle disgrazie dell’umano poco migliore di quello della Terra. Non avrà quanto è futile e davvero deplorevole, come la guerra, ma ciononostante soffre della sozzura fondamentale, ovvero della sofferenza. La Luna soffre, e soffre disperatamente. E non solo, sostiene anche che «[…]il male è cosa comune a tutti i pianeti dell’universo[…]» e che, per questo, se si domandasse circa le sofferenze agli altri pianeti tutti risponderebbero unanimemente.
Il morbo si è diffuso. E non parlo tanto di quello della sofferenza, quanto di quello della contaminazione del finito dove un tempo vi era l’infinitezza. Quanto prima era il punto di massima perfezione ed incorruttibilità, è ora degradato ad entità transeunte, immortale forse, ma comunque soggetta alle stesse dannazioni di cui è preda la finitezza. L’umanità non ha perso il mondo quando Dio è morto, ma quando si è resa conto che coi propri piedi calpestava lo stesso sacro che era prima venerato, osannato ed intoccabile.
Dalla ricostruzione storico-concettuale addotta, possiamo detrarre come la Luna, nelle sue varie tappe, conduca un percorso inesorabilmente discendente dal picco dell’etereo all’abbietto dell’umano; attraverso le rivoluzioni scientifiche e culturali, si è sempre maggiormente sovraccaricata di categorie umane, finanche a contenere in sé la miseria della sofferenza. C’è comunque un ulteriore passo al contempo rivoluzionario e destabilizzante che conclude irrimediabilmente ogni forma di misticità lunare, già profetizzato da Leopardi sempre nel dialogo prima considerato:
“Cara Luna, tu hai a sapere che[…]se i tuoi non si curano di conquistarti, tu non fosti però sempre senza pericolo: perché in diversi tempi, molte persone di quaggiù si posero in animo di conquistarti esse; e a quest’effetto fecero molte preparazioni. Se non che, salite in luoghi altissimi, e levandosi sulle punte de’ piedi, e stendendo le braccia, non ti poterono arrivare. Oltre a questo, già da non pochi anni, io veggo spiare minutamente ogni tuo sito, ricavare le carte de’ tuoi paesi, misurare le altezze di cotesti monti, de’ quali sappiamo anche i nomi”.
Per quanto Leopardi dipinga un quadro dell’umano fanciullesco nel suo tendere alla Luna, credendo che alzandosi in punta di piedi sulle massime alture avrebbe potuto sfiorarla, la verità è che sottesa a questa visione c’è una chiara malinconia dovuta dalla consapevolezza di un futuro inquietamente prevedibile. Dal punto di vista storico, difatti, gli inizi dell’ottocento sono scanditi dall’odore acre del carbonio e delle macchine a vapore, e da una sensazione inoppugnabile di avversione ad un progresso che sembrava deglutire la reale valenza dell’umano nei contesti di lavoro. Si poteva dedurre come ad un tanto repentino progresso sarebbe conseguito un altrettanto repentino sviluppo delle possibilità umane di approdare sul suolo lunare. Non era quantomeno più impensabile come sembrava un tempo: stava facendosi mondo la figura di Astolfo, ora non più recuperante la follia sulla Luna, ma affermante la potenza tecnologica ed operativa dell’umano.
Al solito, il vaticinio dei poeti contiene una struggente verità, e così, nel 1969, più di un secolo dopo la profezia leopardiana, l’uomo completa l’umanizzazione della Luna calpestandone tronfiamente l’etereo suolo. Non stupisce certamente che dopo questo avvenimento si sia anche scaricata qualsiasi forma di eccitazione poetica nei confronti del lunare. Della Luna non è neanche più propria l’immortalità, sintomatica di una gradazione ontologica superiore a quella dell’umano, soggetto alla morte. Avendone dissacrato il terreno, la Luna è ora come una delle tante cose al mondo: corruttibile, infrangibile e difficilmente poetabile. È in altre parole morente. Seppure Hegel fosse sicuro che il processo fenomenologico sintetizzasse il superamento con l’esplicazione sempre più puntuale della sostanzialità umana, la verità è che a quelle categorie spirituali ora corrispondono altre di matrice esistenzialista.
Nella sua simbiotica connessione con la storia dell’umano, sarebbe possibile, in una sorta di visione storicistica alternativa, narrare delle gesta dell’uomo attraverso i vari momenti del lunare. Quella influenzata dalla Luna è una specifica maniera del soggettivo che, millenaria e tendente all’infinito, ha man mano esaurito la sua potenza, scaricando la sua tempra e naufragando sulle sponde del miseramente finito. Alla soggettività disillusa del contemporaneo, che ha perso gran parte del pensiero magico che contraddistingueva un’epoca la cui scienza stava nel cielo, è precedente una soggettività-magica che contemplando gli abissi infinitamente eterei oltre la soglia del proprio campo di sensibilità spiegava la sua esistenza esplicitando al suo massimo l’immaginazione.
Posta in questo modo, sembra che io condanni qualsiasi forma della scienza dopo la rivoluzione galileiana, o l’approdare dell’uomo sulla Luna. Non è certamente quello che voglio dire: piuttosto, sono convinto del fatto che le polarizzazioni sono, a prescindere, non proficue nell’ambito del sapere. Se il soggettivo-magico era certamente al di fuori di ogni rigore scientifico per come lo intendiamo noi, che è quindi nella misurazione e quantificazione del fenomeno, è pur vero che la totale immersione della soggettività nel ramo delle strette metodologie porta ad una squalificazione perniciosa del mondo nella sua potenziale meraviglia. Per questa motivazione, ritengo che una conveniente visione del mondo stia in una sorta di mediocritas oraziana: se da una parte è innegabile come il progresso scientifico nella quantificabilità metodica abbia portato ad un avanzamento importante della consapevolezza dello stare-al-mondo, è altrettanto vero che, dall’altro lato, il soggetto ha smesso di meravigliarsi di quella stessa realtà che ora può pure conoscere pienamente. Probabilmente, pensandoci, era proprio nel fatto che al soggetto sfuggisse il mondo che risiedeva la potenza della meraviglia. La soggettività si meraviglia nell’atto di far cadere le braccia rispetto a quanto gli manchi del mondo. La meraviglia è una sorta di atto di consapevole perdita, di cosciente mancanza, e massimamente sublime parzialità del manifestarsi delle cose.
Se l’uomo ha davvero peccato, bisognerà dire che abbia peccato due volte, mangiando dallo stesso frutto del cui nutrimento era reo per la prima volta: quello della conoscenza. Caduto nel mondo dell’espiazione, gli era perlomeno possibile meravigliarsi. Volendo conoscere al meglio pure quel mondo, ha finito per darsi una nuova espiazione, ovverosia la caduta nella noia e nella monotonia del presentarsi ingrigito della realtà.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Per approfondire la struttura del cielo aristotelico-tolemaica, si consideri: Aristotele, Il cielo, Bompiani, Milano, 2002.
Come sarà intuibile, è possibile studiare la rivoluzione galileiana e la conseguente riconsiderazione della Luna da una quantità considerevole di testi. Ciononostante, mi sento di consigliare: G. Galilei, Sidereus Nuncius, Marsilio, Venezia, 1997; Galilei in P. Rossi, La nascita della scienza moderna, Laterza, Bari, 1997 (pp.107-147).
Nel caso di interesse circa l’astronomia arabo-islamica del Medioevo, è sicuramente doveroso riferirsi ad autori come al-Khwarizmi (si veda Jim Al-Khalili, La casa della saggezza: l’epoca d’oro della scienza araba, trad. it. a cura di Andrea Migliori, Bollati Boringhieri, Torino, 2013) ed Avempace (cfr. Montada, Josép Puig, “Ibn Bâjja [Avempace]”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2022 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL: https://plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/ibn-bajja/ consultato in data 03/10/2022).
La versione considerata per il Dialogo della Terra e della Luna di G. Leopardi è quella presente nell’edizione delle Operette morali, Mondadori, Milano, 2016 (pp.55-62).
Foto di copertina scattata da Mario Zazzera, fotografo, svolge la sua professione in Monopoli. Ha collaborato, tra gli altri, con realtà quali Meero, Just Eat e Deliveroo.
Nato nel 2001, attualmente studente presso la facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; si è occupato già di Filosofia presso numerose riviste e blog. Spiccano, tra le varie, le collaborazioni con “Gazzetta Filosofica”, “Filosofia in Movimento”, “Ereticamente — Sapienza” e “Pensiero Filosofico”. È stato membro della redazione della rivista “Intellettuale Dissidente”; ivi, si è occupato dell’etichetta “Filosofia”. Ha anche pubblicato per il blog “Sentieri della Ragione” e, sulla sua pagina Facebook (“Sentieri della Filosofia”), è stato relatore, con la direttrice, di due webinar aventi riscosso soddisfacente successo. Saltuariamente, pubblica i suoi contributi sulla piattaforma accademica “Academia.edu”; qui, questi hanno ricevuto — in totale — quasi una decina di migliaia di letture. Ha collaborato con l’editorial board di “Pillole di Ottimismo”, dando, della complessa e poliedrica questione pandemica, una contestualizzazione filosofica. Ha tenuto convegni di Filosofia locali presso la sua città d’origine, Bitonto — in collaborazione con la testata giornalistica del luogo, dal titolo “La Persistenza Filosofica”. Occasionalmente, pubblica anche per il blog di psicologia Italiano, “Psiche.org”. È stato membro della redazione, occupato nell’etichetta “Filosofia”, della rivista — ormai inattiva, “nuovoumanesimo.eu”. Infine, è stato chiamato a presentare un lavoro sul testo “Mobilitazione Totale” di M. Ferraris in occasione dell’evento “Summer School di Filosofia Teoretica” (2019) intitolantesi “Pensare il Futuro/Pensare al Futuro” tenutosi in Bitonto — al quale dibattito (oltre alla presenza dell’autore) ha partecipato il filosofo B. Stiegler.