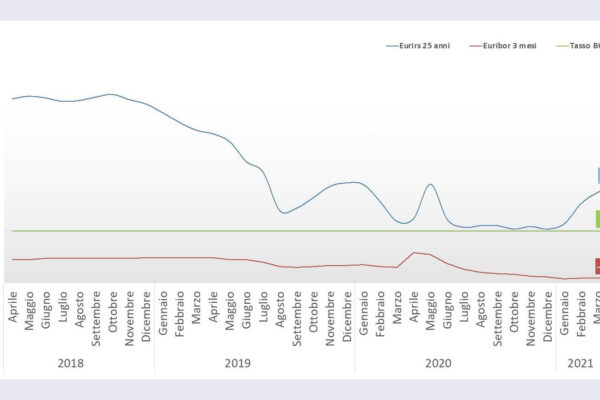Mark Thompson, che è stato direttore generale della BBC e amministratore delegato del New York Times, proponeva nel 2016, nel suo libro La fine del dibattito pubblico, di sottoporre un cittadino comune a una prova, definita come Test di Trump, che potesse consentire “di distinguere al volo i fatti dalle opinioni, il discorso politico adulto dalle pure assurdità”. Tutto ciò avrebbe richiesto un linguaggio chiaro che però, commentava, non appartiene alla retorica politica dei nostri giorni. Non si può non convenire con lui sul fatto che negli Stati Uniti, come altrove, il linguaggio politico “non sta superando l’esame”, perché non permette di orientarsi tra informazioni che si rivelano, spesso, tanto suggestive quanto infondate.
L’uso spregiudicato di argomentazioni sofistiche, da Pericle ad oggi, è connaturato alle democrazie, ma i social media hanno esteso a dismisura la loro diffusione e le opinioni più insensate del demagogo di turno rischiano di apparire credibili a un pubblico incapace di valutare l’affidabilità della fonte. Il variegato Bestiario, che anima una feroce propaganda, trova, in questo clima, un fertile terreno di coltura. Ecco perché ci confrontiamo con una condizione che Tom Nichols, nel suo libro La conoscenza e i suoi nemici, ha descritto come morte della competenza. La fiducia assoluta in ciò che viene diffuso dai media alimenta così il discredito nei confronti di saperi consolidati.
Nel recente saggio di Sabino Cassese, Intellettuali, pubblicato da Il Mulino, si riconosce l’invito kantiano a pensare con la propria testa a voce alta insieme agli altri. Pensare a voce alta significa accettare il dialogo, esporsi alla critica e contribuire, al tempo stesso, ad elevare la consapevolezza dei problemi che dobbiamo affrontare. L’uguaglianza dei diritti politici, che sta alla base della democrazia, non implica, sottolinea Cassese, l’uguaglianza delle competenze. Non si deve infatti pensare che uguali punti di partenza garantiscano uguali punti di arrivo. Se i media mettono oggi in discussione il ruolo degli esperti, e la funzione “oracolare” di Google sembra vanificare ogni tentativo di approfondimento, non bisogna però dimenticare che la figura stessa dell’intellettuale è legata, costitutivamente, proprio ai media. Il 14 gennaio del 1898, Georges Clemenceau chiese, infatti, ai rappresentanti di vari ambiti culturali di firmare un Manifesto degli intellettuali, pubblicato poi sul quotidiano L’Aurore, a sostegno di Emile Zola che, come è noto, difendeva il capitano Alfred Dreyfus dall’accusa di alto tradimento.
Ma chi è l’intellettuale, si chiede Cassese, come definirlo? Può essere l’esperto di un determinato ramo del sapere, il pensatore impegnato, il consigliere del principe, il filosofo distaccato, o anche il “profeta”. Riprendendo una definizione di Karl Mannheim, Cassese scrive che la funzione dell’Intellighenzia dovrebbe consistere nel “tutelare gli interessi spirituali di tutta l’umanità”, e nell’affrontare ogni problema da punti di vista differenti. L’intellettuale può essere un analista disincantato, ma può anche operare delle scelte che fanno della sua vita una testimonianza del suo pensiero. Fu così, secondo Isaiah Berlin, per gli intellettuali russi dell’Ottocento, i quali, come scrive nel suo saggio La storia intellettuale russa, incarnarono i loro ideali “con una costanza e un’assolutezza che in Occidente, fuori dalla vita religiosa, si sono viste di rado”.
L’intellettuale impegnato, quando decide di essere “organico”, rischia di divenire difensore di una ideologia, di una reductio ad unum, in cui la ragione critica cede il passo alla fede in un dogma secolarizzato. Il Novecento ci ha offerto svariati esempi di intellettuali che, a sinistra come a destra, hanno subito questo fascino, rinunciando alla lucidità critica. Julien Benda descrive, nel suo Il Tradimento dei chierici, del 1927, come l’Intellighenzia si lasciò attrarre dal mito nazionalista e antidemocratico da una parte, e da “un’unione mistica con il divenire storico” dall’altra. Cita, a tal proposito, il giurista sovietico Andrej Januarevic Vysinskij, secondo il quale il realismo della politica sovietica era legato alla capacità di “Scegliere coscientemente le vie che determinano in maniera inevitabile lo sviluppo della società”. Il termine “inevitabile”, commenta Benda, introduceva una posizione “assolutamente mistica”, che potrebbe anche essere enunciata ipotizzando che il corso della storia è “opera di Dio”.
L’elemento profetico, presente già in Marx, viene ben evidenziato, in Significato e fine della storia, da Karl Löwith, secondo il quale il messaggio del Manifesto del partito comunista risiede non nel suo “materialismo cosciente”, ma nello “spirito religioso del profetismo”. L’alienazione, o lo sfruttamento, rappresenterebbero, prima che un concetto sociale ed economico, un giudizio morale, un male radicale, un peccato originale. Il materialismo storico potrebbe allora esser letto come “una storia della salvezza espressa nel linguaggio dell’economia politica”. Nello spirito del profetismo, la classe operaia diviene allora il popolo eletto, che dovrà salvare l’umanità intera, guidandola verso la Terra promessa del socialismo.
Cassese traccia una mappa di stili intellettuali, per concludere che il modello che più è adeguato ai nostri tempi è “quello che coglie le connessioni e le connessioni fra le connessioni”. Un esempio, in questa direzione, sarebbe rappresentato, a suo avviso, da Albert Hirschaman. L’intellettuale non può dunque essere, come avrebbe detto José Ortega y Gasset, una sorta di sapiente ignorante, che pur sapendo “tutto” intorno a un determinato ambito, non riesce a collegare la nicchia del suo scibile con altri aspetti della realtà. Rispetto al passato, l’intellettuale dovrebbe inoltre mostrarsi capace di “trasformare i morti in antenati”, considerando la storia, crocianamente, come giustificatrice e non come giustiziera, dal momento che la sua “giuridificazione” o la sua interpretazione con criteri odierni, cara ai teorici contemporanei della Cancel Culture, impedisce una adeguata comprensione del presente. Bisognerebbe quindi promuovere, nel discorso pubblico, un approccio critico alla storia, che per Croce, come per Cassese, è sempre contemporanea.
Si chiede poi se nelle società democratiche, dominate dai media, in cui chiunque è in grado di partecipare alla vita politica, gli intellettuali possano ancora essere utili. Alle origini del costituzionalismo, scrive, si avvertì l’esigenza di selezionare “uomini di grande saggezza”, come sosteneva Hamilton nel Federalista n. 57. Per Vittorio Emanuele Orlando l’elezione poteva essere considerata una “designazione di capacità”. Chi votava, quindi, commenta Cassese, “sceglieva non solo kratos, ma anche aretè ed episteme, non solo forza, ma anche virtù e competenza”.
Se questo valeva nell’ambito del suffragio censitario, tutto è mutato quando “si è affermata l’idea che l’uguaglianza formale e l’uguaglianza sostanziale, in materia politica, andassero di pari passo”. In seguito all’introduzione del suffragio universale, che non assicura sempre scelte legate alla competenza, i partiti hanno svolto un ruolo essenziale nel formare le classi dirigenti. La loro crisi, oggi sempre più evidente, ha alimentato da una parte derive populiste, dall’altra spinte tecnocratiche, come dimostra il libro di Jason Brennan, Contro la democrazia,in cui si sostiene che un governo dei competenti (epistocrazia), sarebbe più adatto delle istituzioni rappresentative a gestire la complessità del presente. L’epistocrazia di Brennan può costituire, secondo Cassese, un correttivo, non un’alternativa alla democrazia, che si fonda sul dibattito pubblico, di cui non rimarrebbe quasi traccia in un modello tecnocratico. John Stuart Mill, che pure aveva preso in esame l’idea del voto plurimo, pensando che fosse giusto attribuire maggior peso all’opinione dei cittadini più colti, era consapevole dei limiti di un governo dei competenti e, a tal proposito, parlava di pedantocrazia.
All’intellettuale ideologo, Cassese preferisce dunque l’intellettuale raziocinante, che “aiuta a pensare”, senza scendere, necessariamente, nel campo di battaglia. Scrive infatti, citando Erwin Panowsky, che stare a terra consente di agire, ma non sempre di vedere quel che ci sta intorno. Non bisogna allora demonizzare la turris eburnea, perché, se è vero che quella posizione non favorisce l’azione immediata, è altrettanto vero che ci permette di osservare e di stare in guardia. Osservare, per prepararsi ad agire in modo critico, può allora rappresentare lo stile ideale per un intellettuale che voglia svolgere un ruolo pubblico. Cassese ricorda, a tal proposito, le figure di Francesco Saverio Nitti, Gaetano Salvemini, Vilfredo Pareto, Luigi Einaudi, che, con un linguaggio scevro di retorica e di oscurità, seppero svolgere un ruolo essenziale nella formazione civile di intere generazioni.
Si potrebbe dire della loro lezione, come anche del ruolo che Sabino Cassese svolge nel discorso pubblico oggi in Italia, ciò che José Ortega y Gasset diceva della filosofia in una sua lezione, nella primavera del 1929 a Madrid. La chiarezza, sosteneva, “è la cortesia del filosofo”, che, per promuovere una coscienza critica, deve usare un linguaggio comprensibile a tutti, a differenza di quanto avviene nelle scienze particolari, che “interpongono tra il tesoro delle loro scoperte e la curiosità dei profani, il drago terribile della loro terminologia ermetica”.
È presidente del Collegio Siciliano di Filosofia. Insegna Storia della filosofia moderna e contemporanea presso l’Istituto superiore di scienze religiose San Metodio. Già vice direttore della Rivista d’arte contemporanea Tema Celeste, è autore di articoli e saggi critici in volumi monografici pubblicati da Skira e da Rizzoli NY. Collabora con il quotidiano Domani e con il Blog della Fondazione Luigi Einaudi.